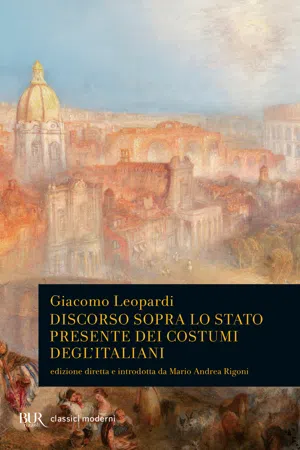1 Nel titolo riecheggia, probabilmente, l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (1756) di Voltaire. Ma, tra gli «antecedenti» del titolo, sono da ricordare nello stesso tempo l’Argomento di una canzone sullo stato presente dell’Italia (1818) e il IV dei Disegni letterari (1819-1821) in cui si accenna a un’opera che avrebbe dovuto chiamarsi Della condizione presente delle lettere italiane (cfr. G. Leopardi, Poesie e prose, a cura di R. Damiani e M. A. Rigoni, con un saggio di C. Galimberti, Milano, Mondadori, 19965, rispettivamente vol. I, p. 620 e vol. II, p. 1207).
2 Allusione al periodo delle guerre napoleoniche.
3 Leopardi considera quella di Luigi XIV «la prima epoca vera della perfezione del dispotismo» (Zib. 911) e «l’epoca della corruzione barbarica delle parti più civili d’Europa, di quella corruzione e barbarie, che succede inevitabilmente alla civiltà» (Zib. 1077). Tuttavia, in questo contesto, egli sembra non poter sottrarsi al fascino della grande opera di Voltaire, Il secolo di Luigi XIV nella quale, fra le epoche della storia umana, l’età dominata dal sovrano francese viene definita «quella che più dappresso tocca la perfezione» (Voltaire, Il secolo di Luigi XIV, trad. it. di U. Morra, Torino, Einaudi, 1994, p. 13).
4 Si delinea un tema destinato ad affiorare più volte, esplicitamente o implicitamente, nell’argomentazione del Discorso: la Francia è il paese moderno per eccellenza; la società, l’opinione pubblica, la letteratura francesi sono moderne per definizione: «Lo spirito, il costume della nazione francese è, fu, e sarà precisamente moderno rispetto a ciaschedun tempo successivamente, e la nazione francese sarà (come oggi vediamo che è) sempre considerata come il tipo, l’esemplare, lo specchio, il giudice, il termometro di tutto ciò ch’è moderno. La ragione si è che la nazione francese è la più socievole di tutte, la sede della società, e non vive quasi che di società» (Zib. 1999-2000). Di qui anche la critica di Leopardi e, talvolta, l’aperta avversione nei confronti degli aspetti della vita francese più artefatti e guastati dai processi di massificazione (cfr. Zib. 671 e 1933-1934). La complessità dell’atteggiamento leopardiano nei confronti della Francia, anche nei suoi risvolti psicologici, è stata colta da Sainte-Beuve: «Ritroveremo ancora [...] lampi di questa collera di Leopardi contro la Francia. Notiamo tuttavia che questa collera non era indifferenza e neppure odio e che la collera è più sovente vicina all’amore di una fredda e tiepida amicizia» (Ch. A. Sainte-Beuve, Portrait de Leopardi, Précédé de Sainte-Beuve et Leopardi par M. A. Rigoni, Paris, Éditions Allia, 1994, p. 34).
5 La situazione descritta è, in realtà, paradossale. Oltre al commercio, il quale ha in comune con la vita il fatto che «tanto più prospera quanto men gli uomini, i filosofi ec. se ne impacciano» (Zib. 4042), anche gli altri mezzi usati per incrementare le relazioni tra gli europei, come i viaggi, la letteratura, la conoscenza enciclopedica, hanno la finalità, come sostiene Leopardi in nota, di rinvigorire una vita affievolita e quasi spenta riunendo le «poche fiamme sparse qua e là» in un «luogo comune». L’incremento delle relazioni civili provoca, però, uniformità e appiattimento, riduce la singolarità tanto degli individui quanto delle nazioni e, «distribuendo i lumi e le qualità buone non accresce la massa, ma la sparte, sì che ridotta in piccole porzioni fa piccoli effetti» (Zib. 22). Si dovrà allora concludere che gli unici viaggi che rivestono un qualche significato sono quelli nei paesi meno civilizzati e perciò meno uniformati (cfr. Zib. 720-721), che frequentare la letteratura per definizione moderna, quella francese, significa aver a che fare con una non letteratura (cfr. Zib. 1174), mentre il Discorso stesso non accredita grande futuro alla residua vitalità della letteratura germanica. Da ultimo, l’enciclopedismo appare come ausilio di una conoscenza di tipo specialistico e settoriale e non come veicolo di «immensi progressi» (cfr. Zib. 1922). Ciò non toglie che Leopardi sia «direttamente e fondamentalmente favorevole» a «far progredire la civilizzazione», visto che il ripristino della vitalità originaria è impossibile e che «l’attività» moderna consente almeno quella distrazione la quale sola può alleviare l’infelicità (cfr. Zib. 4187).
7 Corinne ou l’Italie di Madame de Staël venne pubblicato nel 1807 e fu una delle opere che esercitarono maggiore influsso su Leopardi all’epoca della redazione del Discorso.
8 La ricostruzione dell’interesse dei letterati inglesi verso l’Italia è esemplarmente fornita da R. Marshall, Italy in English Literature (1755-1815). Origins of the Romantic Interest in Italy, New York, Columbia University Press, 1934.
9 Sull’Account of the Manners and Customs of Italy, with observations on the mistakes of some travellers, with regard to that country cfr. R. Marshall, op. cit., pp. 22 ss.
11 Già Rousseau aveva lamentato la difficoltà di scrivere su temi nazionali rimanendo in patria e sottolineato la sua «posizione favorevole» di «straniero che viveva in Francia» sostenendo che «quando si vogliono consacrare i propri libri al bene della patria, non bisogna comporli in seno ad essa, a meno che si sia uomo da intrighi» (J. J. Rousseau, Émile, trad. di L. De Anna, Firenze, Sansoni, 1993, p. 978). Le preoccupazioni di Rousseau si riferivano principalmente alla censura; preoccupazioni analoghe non dovettero rimanere del tutto estranee neppure al Leopardi (cfr. S. Timpanaro, Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana, Pisa, ETS, 1982, p. 179; G. Savarese, Il «Discorso» di Leopardi sui costumi degl’Italiani: preliminari filologici [1988], in L’eremita osservatore. Saggio sui «Paralipomeni» e altri studi su Leopardi, Roma, Bulzoni, 1995, p. 231). La «sincerità e libertà» cui Leopardi aspira non sembrano, tuttavia, quelle messe in pericolo da un eventuale intervento censorio, quanto quelle garantite dal felice straniamento che uno sguardo forestiero procura quando si tratta di giudicare costumi e peculiarità nazionali. A questo proposito, un significativo effetto di spaesamento, da ottenersi rendendo il proprio punto di vista artificiosamente «straniero» rispetto ai costumi patrii, era stato perseguito da Montesquieu nelle Lettres persanes e anche da Voltaire nelle Lettres anglaises (meglio conosciute come Lettres philosophiques). La proclamazione di italianità, infine, presente nella chiusa di questa argomentazione, mostra la conclusiva coincidenza di osservatore e osservato, di giudicante e giudicato e rivela la necessità di un doppio sguardo, contemporaneamente estraniato e partecipe, che gli interpreti più recenti hanno riconosciuto necessario a qualsiasi indagine di tipo anche latamente antropologico (cfr. C. Geertz, Opere e vite, trad. it. di S. Tavella, Bologna, Il Mulino, 1990).
12 L’uomo, a giudizio di Leopardi, «non può essere virtuoso per natura» e inoltre «non si può muovere neanche alla virtù, se non per solo e puro amor proprio, modificato in diverse guise» (Zib. 1100). La natura provvide ad attenuare gli effetti distruttivi dell’amor proprio «destinando agl’individui di una stessa specie, e fra questi agli uomini, o niuna società, o scarsa e larga» (Zib. 3785). Le illusioni fecero il resto deviando, una volta che l’uomo era entrato nello stato civile, l’amor proprio «modificato» verso il fine non egoistico dell’amor di patria (cfr. Zib. 879). La «distruzione» o la «strage» delle illusioni, caratteristica della civilizzazione, non può né reintegrare l’originaria società «scarsa e larga», né sostituire le illusioni perdute con un altro fondamento della morale e della virtù politica. Viene così lasciato spazio al ritorno di un «universale egoismo», ma poiché questo è «incompatibile colla società» (Zib. 4136), soltanto il caso può essere invocato come motivo del permanere della società stessa. Sempre il caso, peraltro, viene invocato più volte come principio di spiegazione dell’origine della civiltà (cfr. Zib. 1739-1740 e 1570). Su quello che potremmo definire il «contingentismo» leopardiano cfr. A. Tilgher, La filosofia di Leopardi [1940], Bologna, Massimiliano Boni Editore, 1979, e G. Rensi, La filosofia dell’assurdo [1937], Milano, Adelphi, 1991, pp. 174 ss.
13 «[...] le esattezze, le definizioni, le circoscrizioni, le formole chiare e precise, non sono in natura, ma inventate e rese necessarie dalla corruzione degli uomini, i quali oggidì hanno bisogno di stringere ed essere stretti con leggi, patti, obbligazioni (o morali o materiali) distintissime, minutissime, specificatissime, numerosissime, matematiche ec. perchè si tolga alla malizia ogni sotterfugio, ogni scanso, ogni equivoco, ogni libertà, ogni campo aperto e indeterminato» (Zib. 555). L’inefficacia della sola legge al fine sia di trattenere l’uomo dal male sia di spingerlo al bene, venne riconosciuta già da Tucidide: «È semplicemente impossibile, anzi assai ingenuo, ritenere che la legge, o qualunque altra tremenda costrizione, possa ergersi, invalicabile baluardo, a infrangere il potente impeto della natura umana, quando arde nel volo di una conquista» (Guerra del Peloponneso, trad. it. di E. Savino, Milano, Garzanti, 1974, p. 190). La posizione di Leopardi contrasta con una rigogliosa tradizione illuministica favorevole al perfezionamento umano garantito dalle leggi. Esemplare, in questo senso, il pensiero di Helvetius: «Dunque solo con buone leggi si possono formare uomini virtuosi. Tutta l’arte del legislatore consiste perciò nel forzare gli uomini, facendo leva sul sentimento dell’amor di se stessi, ad essere sempre giusti gli uni verso gli altri» (Dello Spirito, trad. it. di A. Postigliola, Roma, Editori Riuniti, 1976, p. 77).
14 «Quid leges sine moribus / vanae proficiunt?» (Orazio, Odi, III, 24, vv. 35-36).
15 Leopardi non pare ignorare l’uso del termine «stato» (cfr. Zib. 332 e 625-628). Sembra però mantenersi all’interno di quella tradizione che, da Hobbes a Kant, pur con sfumature diverse, rimane anteriore alla distinzione tra «società» (societas civilis) e «stato». Risulta dunque estranea al suo pensiero quella differenza, concettuale prima che terminologica, tra bürgerliche Gesellschaft e Staat stabilita da Hegel e a noi così familiare e necessaria. Ciò nulla toglie alla dimensione profondamente politica del pensiero leopardiano (cfr. M. A. Rigoni, Introduzione a G. Leopardi, in La strage delle illusioni, Milano, Adelphi, 19932, pp.18-19), ma le conferisce una tonalità particolare. Se da un lato, infatti, l’autentica virtù politica viene data per scomparsa con il tramonto dell’illusione «antica» dell’amor di patria (cfr. Zib. 606-607 e 3029), necessariamente accompagnato dall’odio per le altre nazioni (cfr. Zib. 879), dall’altro bisogna constatare che «il diritto delle nazioni è nato dopo che non vi sono state più nazioni» e che «la sorgente delle guerre, che una volta era l’egoismo nazionale, ora è l’egoismo individuale di chi comanda alle nazioni, anzi costituisce le nazioni» (Zib. 897-898). Del resto, la moderna funzione del «governo» politico sembra depotenziata e incapace di impedire i processi di massificazione e omogeneizzazione sia fra popoli diversi sia all’interno di uno stesso popolo (cfr. Zib. 148-149). La posizione di Leopardi risulta, così, anticipatamente critica di tanto nazionalismo tardo-ottocentesco, che, alla luce di questi presupposti, potrebbe essere interpretato non tanto come un’affermazione parossistica del principio nazionale, quanto come un sintomo della sua profonda crisi e dissoluzione. Andrebbe attribuita, quindi, al pensiero dell’autore, più che una dimensione moralistica, fondamentalmente impolitica o metapolitica, come spesso si è fatto, una dimensione insieme «inattuale» e «postuma» come quella riv...