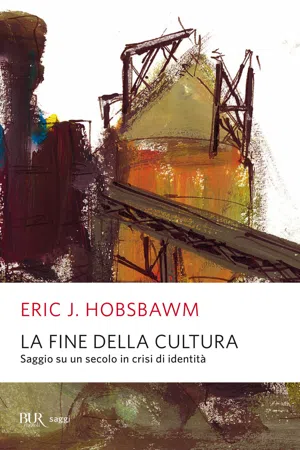![]()
1
Manifesti
Contributo a una «Maratona dei Manifesti» organizzata da Hans Ulrich Obrist per la Serpentine Gallery di Londra, 2008.
Molti dei partecipanti qui presenti hanno scritto dei manifesti. Io non ne ho da proporre, e credo di non aver mai steso un documento che porti questo nome, sebbene abbia redatto testi equivalenti. Tuttavia, ho letto documenti chiamati «manifesti» per buona parte di un secolo e suppongo che ciò mi conferisca una certa credibilità come commentatore in una maratona di tal genere. Ho iniziato la mia vita intellettuale a scuola, a Berlino, all’età di quindici anni, con il Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels. Ho una foto che mi ritrae mentre sto leggendo il quotidiano italiano «il manifesto», che è, almeno credo, l’ultimo giornale europeo a definirsi comunista. Poiché i miei genitori si sono sposati nella Zurigo della Prima guerra mondiale, tra Lenin e i dadaisti del Cabaret Voltaire, mi piace pensare che un manifesto dadaista abbia emesso un sonoro peto al momento del mio concepimento, ma sfortunatamente il primo Manifesto del dadaismo era stato declamato tre mesi prima.
A dire il vero, i lettori sistematici di manifesti sono una specie peculiare del XX secolo. C’erano stati un sacco di analoghi proclami collettivi, perlopiù religiosi e politici, nei secoli precedenti, ma venivano identificati con diverse etichette: petizioni, statuti, appelli e così via. Ci sono state le grandi dichiarazioni – per esempio, la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino –, ma si trattava di enunciazioni da parte di governi e organizzazioni di carattere ufficiale, come la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. La maggior parte dei manifesti appartiene al secolo scorso.
In che modo i manifesti potranno sopravvivere nel XXI secolo? I partiti e i movimenti politici non sono più quelli del secolo passato, e proprio essi costituivano, dopotutto, una delle due fonti principali di manifesti. L’altra erano le arti. Inoltre, con l’ascesa della società degli affari e del gergo Mba (Master of Business Administration), sono stati largamente soppiantati da quella terrificante invenzione che porta il nome di mission statement, dichiarazione di intenti. Nessuna delle mission statements in cui mi sono imbattuto afferma qualcosa che valga la pena di essere ripetuta, a meno di non essere un fan delle banalità scritte male. Non si può camminare per più di qualche metro nel sottobosco della stampa senza inciampare in qualche esempio, universalmente giudicato insulso, che equivale a frasi tipo «Le auguro una buona giornata» o «La sua chiamata per noi è importante».
Ciononostante, i manifesti competono con discreto successo con le mission statements. Ci sono quasi venti milioni di potenziali «occorrenze» su Google, una vera profusione, anche escludendo la Manifesto Records e i suoi vari prodotti. Non posso certo affermare che tutti i manifesti siano all’altezza della definizione fornita dal dizionario: «Una pubblica dichiarazione di princìpi, linee di condotta o intenti, specialmente di natura politica». O di qualunque altra natura. Includono un manifesto per l’allattamento al seno, uno per i giardini e la loro fauna, un altro per le colline, che si occupa di come allevare il bestiame sugli altipiani scozzesi, e un manifesto piuttosto allettante per una nuova cultura del camminare lanciato dal gruppo di artisti-ricercatori Wrights and Sites, zeppo di riferimenti ai dadaisti, ai situazionisti, ad André Breton e a Brecht, ma, in modo alquanto sorprendente, nemmeno uno al campione incontrastato dei camminatori urbani, Walter Benjamin. E, naturalmente, vi sono compresi tutti i manifesti di questa maratona.
Non ho avuto la possibilità di ascoltarne molti, ma una cosa che mi colpisce è che così tanti sono dichiarazioni individuali e non, come accadeva quasi per ogni manifesto del passato, dichiarazioni di gruppo, che rappresentino qualche «noi» collettivo, formalmente organizzato o meno. Di certo, questo è il caso di tutti i manifesti politici che mi vengono in mente. Parlano sempre al plurale e mirano a conquistare sostenitori (anch’essi al plurale). Questo è anche il caso, tradizionalmente, dei manifesti nell’ambito delle arti, divenuti popolari sin da quando, nel 1909, i futuristi introdussero il termine nel mondo dell’arte grazie alla parlantina sciolta e retorica di Marinetti. Così facendo, anticiparono i francesi di qualche anno. Sono sicuro che ai cubisti sarebbe piaciuto inventare questa parola, ma all’epoca erano poco politici e più bravi a esprimere il proprio pensiero con la pittura che con le parole. Sto ovviamente pensando alle avanguardie che si sono riconosciute come tali al loro tempo, non a etichette o scuole create a posteriori, come il «postimpressionismo», oppure inventate dai critici e, sempre di più, dai mercanti d’arte, come l’«espressionismo astratto». Sto pensando a gruppi genuini di individui, a volte riuniti attorno a una persona o a una rivista, per quanto di breve vita, consapevoli di ciò a cui si oppongono come pure di quel che ritengono di avere in comune: i dadaisti, i surrealisti, De Stijl, il Lef (Fronte di sinistra delle arti) o l’Independent Group, intorno al quale, negli anni Cinquanta, nacque in Gran Bretagna la pop art. Oppure Magnum, l’originale collettivo di fotografi. Se vogliamo, sono tutti movimenti associativi.
Non so bene a che cosa servano i manifesti puramente individuali, se non per esprimere le paure per il presente e le speranze per il futuro di una singola persona, che può, attraverso di essi, auspicare o meno che vengano condivise da altri. Come si può realizzare tutto questo? Principalmente con l’autocultura e l’esperienza condivisa, come ci dice Vivienne Westwood nel suo affascinante manifesto? In che altro modo? I futuristi inventarono l’autopropaganda pubblica. È un segno della nostra società caotica e disgregata che la pubblicità mediatica sia oggi la prima cosa a cui pensa un potenziale «manifestante», invece che alla classica via dell’azione collettiva. Naturalmente, gli individui possono anche utilizzare un manifesto per reclamizzare un’innovazione personale, e rivendicarne così la priorità, come nel manifesto letterario di Jeff Noon («The Guardian», 10 gennaio 2001). C’è inoltre il manifesto di stampo terrorista, di cui è stato pioniere Unabomber nel 1995, che pubblicizza il tentativo di un singolo di cambiare la società, in questo caso inviando ordigni incendiari a nemici selezionati. D’altro canto non sono certo se ciò appartenga alla sfera della politica o dell’arte concettuale. Tuttavia, esiste un altro manifesto meramente individuale, una dimostrazione di egocentrismo, che non ha in mente nessun altro se non lo stesso solipsista che lo divulga. Un esempio estremo è rappresentato da quello straordinario documento che è il Chelsea Hotel Manifesto del 1961 di Yves Klein. Klein, forse ricorderete, aveva fatto carriera dipingendo in un’unica tinta, un inconfondibile blu carico. Nient’altro: su tele quadrate e oblunghe, usando qualunque oggetto tridimensionale, perlopiù spugne, ma anche modelle che faceva rotolare nel colore. Il manifesto spiega che ciò era dovuto alla sua ossessione per il cielo blu, benché il blu di Klein sia il colore meno ceruleo che abbia mai visto. Mentre era disteso sulla spiaggia di Nizza, ha raccontato, «iniziai a odiare gli uccelli che volavano nel mio cielo blu senza nubi, perché cercavano di bucare la mia opera più grande e bella. Gli uccelli vanno eliminati».
Non c’è bisogno di dirvi che Klein ha trovato critici che ne hanno spiegato la profondità e galleristi che ne hanno venduto le opere. La Gagosian Gallery, che si è assicurata il copyright del suo manifesto, gli ha conferito il genere di immortalità che meritava.
Ciò mi porta al contenuto dei manifesti della mia vita. La prima cosa che mi colpisce, ripensando a essi, è che l’autentico interesse di questi documenti non risiede in quello che realmente invocano. Per gran parte si tratta di materiale tendente all’ovvio e al banale, con cui si potrebbero riempire grosse discariche, o comunque destinato a una rapida obsolescenza. Questo vale persino per il grande e stimolante Manifesto del partito comunista, che resta a tal punto attuale da essere stato riscoperto nell’ultimo decennio dagli stessi capitalisti, in mancanza di una sinistra con un serio peso politico in Occidente. La ragione per cui lo leggiamo oggi è la stessa che mi indusse a leggerlo quando avevo quindici anni: la verve e lo stile meravigliosi, irresistibili del testo. Ma soprattutto la sublime visione analitica del cambiamento mondiale delineato nelle prime pagine. Molto di quello che il Manifesto di fatto proponeva è di interesse puramente storico, e i lettori perlopiù saltano quella parte, fatta eccezione per il fervido appello finale – quello sui lavoratori che non hanno nulla da perdere all’infuori delle loro catene e che hanno un mondo da guadagnare. Proletari di tutti i Paesi, unitevi. Purtroppo, anche questo ha ormai fatto il suo tempo.
Ovviamente, questo problema si ha con ogni scritto che concerne il futuro: il futuro è inconoscibile. Sappiamo quello che non ci piace del presente e perché, il che spiega come mai i migliori manifesti siano quelli di denuncia. Quanto all’avvenire, abbiamo un’unica certezza: ciò che facciamo avrà conseguenze non volute.
Se tutto questo è vero per un testo così duraturo come il Manifesto del partito comunista, lo è ancor più per i manifesti nelle arti creative. Per molti artisti vale ciò che mi disse una volta un musicista jazz in un night-club: «Le parole non sono il mio strumento». E anche quando lo sono, come nel caso dei poeti, persino i più brillanti, il percorso che segue la creazione non è «penso e poi scrivo», bensì assai meno controllabile. Questo, se mi è permesso dirlo, è il guaio con l’arte concettuale. A livello intellettuale, i temi dell’arte concettuale sono di solito poco interessanti, a meno che non li si possa interpretare come scherzi: si pensi all’orinatoio di Duchamp, oppure alle opere di Paul Klee, a mio avviso molto più divertenti.
Perciò, leggere la maggior parte dei manifesti nell’ambito delle arti per cogliere il loro significato si rivela un’esperienza frustrante, eccetto forse come performance. E sono interessanti non perché recitati, ma perché possono essere visti come arguzie o burle. Ecco probabilmente perché il dadaismo, questo stile per cabarettisti, rimane la risorsa preferita a cui attingono ancora oggi così tanti manifesti: il suo umorismo è buffo e nero al tempo stesso e, come il surrealismo, non richiede interpretazioni, ma solo di giocare con l’immaginazione, il che, dopotutto, è il fondamento di ogni lavoro creativo. Per giudicare un piatto non basta la descrizione sul menu del ristorante, per quanto fiorita, bisogna assaggiarlo.
Questo è il motivo per cui i creatori nel campo delle arti hanno avuto più successo dei loro manifesti. Nel Secolo breve scrissi: «Perché gli stilisti di moda, una categoria notoriamente poco propensa alla razionalità analitica, anticipino talvolta con successo le forme di oggetti futuri meglio dei pronosticatori di professione, è una delle questioni storiche più oscure; e, per lo storico della cultura, è una delle più importanti».1 Non conosco ancora la risposta. Guardando alle arti nell’ultimo decennio prima del 1914, possiamo notare che molto di esse anticipava il crollo della civiltà borghese avvenuto dopo quella data. La pop art degli anni Cinquanta e Sessanta prendeva atto delle implicazioni dell’economia fordista e della società dei consumi di massa, e, così facendo, dell’abdicazione della vecchia opera d’arte visiva. Chissà, forse tra cinquant’anni uno storico dirà lo stesso di quello che sta accadendo nelle arti, o di ciò che va sotto il nome di arte, nel nostro periodo di crisi capitalistica e di ritirata per le ricche civiltà dell’Occidente. Così come nel pregevole film-documentario Man on Wire, ma in modo assai più precario, le arti camminano su una fune tra l’anima e il mercato, tra la creazione individuale e quella collettiva, persino tra i prodotti riconoscibili e identificabili dell’ingegno umano e la tecnologia e il rumore pervasivo di Internet che li inghiottono. Nel complesso, il tardo capitalismo ha consentito una vita agiata a più persone creative rispetto al passato, ma per fortuna non le ha rese soddisfatte né della loro situazione né della società. Quali auspici trarrà lo storico del 2060 dalla produzione culturale degli ultimi trent’anni? Non lo so e non sono in grado di saperlo, ma nel frattempo verrà pubblicato qualche nuovo manifesto.
![]()
Parte I
La difficile situazione della «cultura alta» oggi
![]()
2
Dove vanno le arti?
Conferenza in tedesco al Festival Dialogues, Salisburgo 1996.
In realtà, è inappropriato chiedere a uno storico quali caratteristiche avrà la cultura nel nuovo millennio. Noi siamo esperti del passato. Non ci interessiamo del futuro, e certamente non del futuro delle arti, che stanno attraversando l’epoca più rivoluzionaria della loro lunga storia. Ma poiché non possiamo fare affidamento sui profeti di professione, a dispetto delle somme astronomiche spese da governi e aziende per le loro previsioni, uno storico può anche avventurarsi nel campo della futurologia. In fin dei conti, malgrado tutti gli sconvolgimenti, passato, presente e futuro formano un continuum indivisibile.
Ciò che caratterizza le arti del nostro secolo è la loro dipendenza da una rivoluzione tecnologica storicamente unica – in particolare le tecnologie della comunicazione e della riproducibilità – e la trasformazione che esse hanno subito in seguito a tale rivoluzione. Quanto alla seconda forza che ha rivoluzionato la cultura, cioè la società dei consumi di massa, essa è impensabile senza la rivoluzione tecnologica, per esempio senza il cinema, la radio, la televisione e i dispositivi portatili per l’ascolto della musica da tenere nel taschino della camicia. Ma è precisamente questo a non consentire che poche predizioni generali sul futuro dell’arte come tale. Le vecchie arti visive, come la pittura e la scultura, sono rimaste fino a non molto tempo fa puro artigianato; semplicemente, non facevano parte dell’industrializzazione – di qui, per inciso, la crisi in cui si trovano oggigiorno. La letteratura, d’altro canto, si è adattata alla riproducibilità tecnica mezzo millennio fa, ai tempi di Gutenberg. La poesia non va intesa né come opera destinata a una rappresentazione pubblica (com’era una volta il caso dell’epica, che di conseguenza scomparve dopo l’invenzione della stampa) né – per esempio nella letteratura cinese classica – come opera calligrafica. È soltanto un’unità assemblata meccanicamente con simboli alfabetici. Dove, quando e come la riceviamo, sulla carta, sullo schermo o in altro modo, è del tutto irrilevante, una questione secondaria.
Nel frattempo, nel XX secolo e per la prima volta nella storia, la musica ha sfondato il muro di una comunicazione esclusivamente fisica tra strumento e orecchio. La stragrande maggioranza dei suoni e dei rumori che udiamo oggi come esperienza culturale ci raggiunge in maniera indiretta – riprodotta meccanicamente o trasmessa da una certa distanza. Ciascuna delle Muse ha avuto una diversa esperienza dell’epoca della riproducibilità individuata da Walter Benjamin, e affronta il futuro in modo differente.
Lasciatemi perciò cominciare con una breve panoramica delle singole aree della cultura. In quanto scrittore, mi sia permesso di prendere in esame innanzitutto la letteratura.
L’umanità nel XXI secolo (diversamente dagli inizi del Novecento) non sarà più composta principalmente da illetterati. Oggi ci sono solo due aree del mondo in cui la maggioranza delle persone non sa né leggere né scrivere: l’Asia meridionale (India, Pakistan e le regioni circostanti) e l’Africa. Istruzione regolare significa libri e lettori. Un semplice incremento del 5 per cento del tasso di alfabetizzazione equivale a cinquanta milioni in più di potenziali lettori, perlomeno di libri di testo. Inoltre, a partire dalla metà del nostro secolo gran parte della popolazione dei cosiddetti «Paesi sviluppati» può aspettarsi di ricevere un’istruzione di secondo grado, e nell’ultimo terzo del secolo una percentuale significativa dei gruppi di età in questione riceve un’istruzione di livello superiore (attualmente in Inghilterra la proporzione si aggira intorno a un terzo). I fruitori della letteratura di ogni genere si sono quindi moltiplicati, e con essi, tra parentesi, il «pubblico colto» a cui tutte le arti dell’alta cultura occidentale si sono indirizzate sin dal XVIII secolo. In cifre assolute, questa nuova audience di lettori continua ad aumentare vertiginosamente. Anche gli odierni mass media mirano a essa.
Nel film Il paziente inglese, per esempio, la protagonista legge Erodoto, e subito frotte di inglesi e americani sono corse ad acquistare le opere dello storico greco antico, che prima, nel migliore dei casi, conoscevano solo di nome.
Una simile democratizzazione del materiale scritto deve necessariamente condurre – come nell’Ottocento – a una frammentazione attraverso la crescita di vecchie e nuove letterature in volgare e – di nuovo come nel XIX secolo – a una età dell’oro per i traduttori. Del resto, in che altro modo, se non attraverso le traduzioni, Shakespeare e Dickens, Balzac e i grandi autori russi avrebbero potuto divenire patrimonio comune della cultura borghese internazionale? Questo è in parte vero anche ai nostri giorni. Un romanzo di John le Carré diventa un best seller perché viene regolarmente tradotto in trenta, se non addirittura cinquanta lingue. Tuttavia, la situazione attuale è fondamentalmente diversa per due aspetti.
In primo luogo, come sappiamo, per un certo tempo la parola ha dovuto indietreggiare davanti all’immagine, e la parola scritta e stampata davanti a quella pronunciata sullo schermo. Fumetti e libri illustrati con testi ridotti al minimo non sono più ormai destinati solo a principianti che stanno ancora imparando a compitare. Molto più importante, tuttavia, è la ritirata delle notizie stampate dinanzi a quelle illustrate o comunicate verbalmente. La stampa, il principale medium della «sfera pubblica», secondo Habermas, nel XIX secolo e in buona parte del XX, difficilmente sarà in grado di mantenere questa posizione nel XXI secolo. In secondo luogo, però, l’economia e la cultura globali dei nostri giorni necessitano di una lingua globale per integrare quella locale, e non soltanto per una élite trascurabile in termini numerici, bensì per strati più ampi della popolazione. Oggi questa lingua globale è l’inglese, e probabilmente rimarrà tale nel XXI secolo. Una letteratura specialistica internazionale in inglese si sta già sviluppando. E questo nuovo inglese-esperanto ha a che vedere con l’inglese letterario non più di quanto il latino ecclesiastico del Medioevo ne abbia con Virgilio e Cicerone.
Ma tutto ciò non può arrestare la crescita quantitativa della letteratura, cioè delle parole stampate, nemmeno quella delle belles lettres. In effetti, sarei quasi tentato di sostenere che – malgrado tutte le previsioni pessimistiche – il libro stampato, per tradizione il principale medium della letteratura, terrà duro senza eccessive difficoltà, con alcune eccezioni, come le grandi opere di consultazione, vocabolari, dizionari eccetera, ovvero i prediletti di Internet. Primo, non c’è nulla di più facile e pratico da leggere del maneggevole e nitidamente stampato volumetto tascabile inventato da Aldo Manuzio a Venezia nel XVI secolo –, molto più facile e pratico di una stampata del computer, a sua volta incomparabilmente più semplice da leggere di un testo tremolante sullo schermo. Cosa che può essere confermata da chiunque passi un’ora a leggere il medesimo testo dapprima in forma stampata e poi sullo schermo del computer. Anche l’e-book non basa le sue pretese su una migliore leggibilità, ma su una maggiore capacità di memoria e sul fatto di non dover girare pagina.
Secondo, la carta stampata è, finora, più durevole dei media tecnologicamente più avanzati. La prima edizione dei Dolori del giovane Werther è leggibile ancora oggi, ma non è per forza così per i testi elettronici, sia perché – come le vecchie fotocopie e pellicole – hanno solo una vita limitata, sia perché la tecnologia diventa obsoleta così rapidamente che i computer più recenti semplicemente non sono più in grado di leggerli. Il progresso trionfale del computer non eliminerà il libro, così come non ci sono riusciti il cinema, la radio, la televisione e altre innovazioni tecnologiche.
La seconda tra le belle arti che se la cava bene ancora oggi, e continuerà a farlo nel XXI secolo, è l’architettura. Questo perché l’umanità non può vivere senza edifici. I quadri sono un lusso, ma le case una necessità. Chi progetta e realizza edifici, dove, come, con quali materiali, in quale stile, che sia un architetto, un ingegnere o un computer… tutto questo probabilmente cambierà, ma non l’esigenza di creare edifici. Anzi, si può persino affermare che nel corso del XX secolo l’architetto, in particolare quello di grandi edifici pubblici, sia divenuto il re del mondo delle belle arti. È lui – in genere è sempre un «lui» – a trovare l’espressione più consona, cioè la più costosa e imponente, alla megalomania della ricchezza e del potere, nonch...