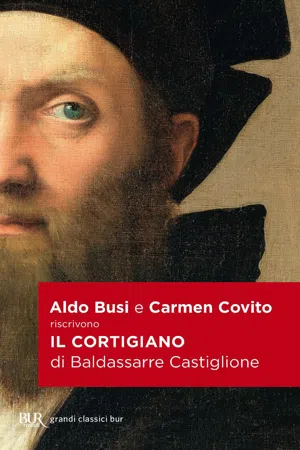![]() IL CORTIGIANO
IL CORTIGIANO![]()
A Sua Eminenza Eccellentissima
don Michel de Silva,
vescovo di Viseu (Portogallo)
I
Alla morte di Guidubaldo da Montefeltro, duca di Urbino, io con qualcun altro dei gentiluomini che erano stati alle sue dipendenze restai al servizio del suo erede e successore, il duca Francesco Maria della Rovere. E dato che non mi erano ancora svaporati dalla mente il profumo delle qualità del duca Guidubaldo e la soddisfazione che in quegli anni avevo ricevuto dall’amicizia e dalla compagnia di gente bella come quella che allora frequentava la corte di Urbino, i ricordi mi spinsero a scrivere questi quattro libri del Cortigiano: buttati giù in pochi giorni, con l’intenzione di mettermi poi, col tempo, a correggere tutti gli errori nati dal desiderio di saldare il mio debito all’istante. Ma per molti anni i casi della vita mi hanno tenuto sempre e di continuo così sotto torchio che non ho mai potuto prendermi uno spazio per fare del manoscritto un testo di cui la mia modesta capacità critica potesse accontentarsi. Perciò, trovandomi in Spagna e sentendomi avvisare dall’Italia che la signora poetessa marchesa di Pescara, Vittoria Colonna, dopo essersi fatta prestare il libro con la promessa di leggerlo e basta, ne aveva invece fatto copiare una gran parte, non ho potuto fare a meno di seccarmi un po’: in situazioni simili possono capitare parecchi inconvenienti. Comunque, confidavo che l’intelligenza e il tatto di quella signora, la cui miracolosa cultura io ho sempre religiosamente venerato, bastassero a evitare che dall’aver fatto una cortesia a lei venisse un danno a me. Da ultimo ho saputo che a Napoli quella parte del libro era finita in troppe mani: e, sempre a caccia di novità come siamo tutti, sembrava che certi tali fossero lì lì per stamparne un’edizione pirata. Spaventato da questa prospettiva, mi sono finalmente deciso a fare subito al libro quei pochi emendamenti che avrei avuto il tempo di fare prima di pubblicarlo: ho pensato infatti che era meno peggio lasciarlo andare in giro poco corretto da me che molto storpiato da altri. Così, per mettere in atto la mia decisione, ho cominciato a rileggerlo; e subito, dalla prima pagina, davanti a quel titolo che era come un’ammonizione, mi ha preso una tristezza non piccola, che mentre andavo avanti cresceva sempre più: mi veniva in mente che la maggior parte dei protagonisti delle mie conversazioni sono già morti. E infatti, oltre a tutte le persone di cui si parla nell’introduzione all’ultimo libro, è morto anche lo stesso Alfonso Ariosto a cui l’opera è dedicata, e era un giovane alla mano, discreto, di maniere più che delicate, abile in tutto ciò che si conviene a un uomo di corte. E non è morto anche il duca Giuliano de’ Medici, la cui grandezza d’animo e cortesia da gran signore avrebbero dovuto farsi godere più a lungo in questo mondo? Il signor Bernardo, detto il Bibbiena, cardinale di Santa Maria in Portico e uomo che per le sue spiritose frecciate a bruciapelo riusciva simpaticissimo a chiunque lo conoscesse, è morto. Morto è Ottaviano Fregoso, una vera rarità per i tempi nostri, un generoso, un religioso, un buono, pieno di intelligenza, di saggezza, di gentilezza, sinceramente amante dell’onore e della rettitudine, e tanto degno di lode che i suoi stessi nemici si sono sentiti sempre costretti a lodarlo; tutte le disgrazie che quest’uomo ha dovuto sopportare – senza piegarsi – bastano a dimostrare che come sempre, e oggi più che mai, il successo non sa che farsene degli uomini veri, o, per dirla in parole più rinascimentali, che la cosiddetta «fortuna» se ne frega della cosiddetta «virtù». Molte altre persone nominate in questo libro, che sembravano destinate per costituzione a una vita lunghissima, sono morte. Ma quello che non si dovrebbe raccontare senza piangere almeno un po’ è che perfino la duchessa, Elisabetta Gonzaga, la signora di Urbino, anche lei è morta. E se io mi sento scosso per la perdita di tanti miei amici e protettori, che mi hanno lasciato a girare da solo in questa vita come in un insidioso deserto, avrò ben motivo di sentire un dolore molto più intenso per la morte della duchessa che per quella di tutti gli altri: perché lei valeva molto più di tutti gli altri, e io le dovevo molto più che a tutti gli altri. Dunque, per non tardare a pagare il mio debito verso la memoria di una padrona di tale rilievo e verso gli altri defunti – e spinto, certo, anche dal rischio che correva il mio libro –, l’ho fatto stampare e distribuire in tutta fretta e così com’è. Lei, caro vescovo, mentre erano vivi non ha mai saputo niente né della duchessa né degli altri, a parte il Giuliano de’ Medici e il cardinal Bibbiena, e perciò le mando questo libro per darle, come posso, qualche notizia di loro adesso che sono morti: lo prenda come un ritratto della corte di Urbino, dipinto non certo da un Raffaello o da un Michelangelo, ma da un imbrattatele della domenica che se la cava a abbozzare le linee principali e non sa né imbellire la verità con colori graziosi né far vedere una cosa per un’altra con l’arte delle false prospettive. Benché io abbia fatto del mio meglio per mostrare attraverso i dialoghi il carattere e lo status sociale delle persone che vi partecipano, confesso di non essere riuscito non dico a esprimere ma nemmeno a suggerire le qualità morali della duchessa: non è solo la mia scrittura che non ce la fa a descriverle, è proprio la mia intelligenza che non arriva a concepirle. E se qualcuno mi farà delle obiezioni su questo punto o su altre cose che posso aver sbagliato (nel libro, lo so bene, ce ne sono a bizzeffe), non sarò io a negare la verità.
II
Ma dato che gli esseri umani a volte ci prendono tanto gusto a criticare che criticano anche le cose che non meritano critiche, risponderò a certe persone che mi rimproverano perché non ho imitato il Boccaccio e non mi sono nemmeno limitato all’uso del toscano parlato di oggi (1527), e dirò: Boccaccio, per i tempi suoi, era senz’altro una bella testa e in alcune parti della sua opera ha scritto con arte e con misura, e tuttavia quando si è lasciato guidare solamente dal suo genio e talento naturale, senza stare troppo a correggere e a limare, ha scritto molto meglio di quando si è sforzato, con fatica, di fare il letterato tutto cultura e controllo. Tant’è vero che i suoi stessi partigiani (Pietro Bembo, per fare un nome a caso) affermano che il poveretto si è sbagliato di grosso nel giudicare le proprie opere, disprezzando il Decamerone che lo ha fatto entrare nella storia della letteratura e tenendo in gran conto le opere minori. E allora, se io avessi imitato quel modo di scrivere che gli viene rimproverato da chi lo porta alle stelle per il resto, non sarei certo sfuggito perlomeno alle stesse critiche che si fanno a Boccaccio su questo punto: e me ne sarei meritate di peggiori, perché lui sbagliò credendo di far bene e io avrei sbagliato sapendo di far male. D’altra parte, mi sembrava che se avessi imitato quel modo di scrivere che molti considerano il massimo e che lui, il Giovanni, disprezzò, col fatto stesso di imitarlo mi sarei mostrato in disaccordo con colui che imitavo: ora, secondo me, una cosa del genere non sarebbe stata per nulla cortese. E quand’anche non mi avesse trattenuto questa forma di rispetto, in che cosa imitarlo? Nell’argomento no, non potevo, perché Boccaccio non ha mai scritto niente di simile a questo Cortigiano. E imitarlo nella lingua, a mio parere, non dovevo, perché la forza dello stile – e quindi l’unica vera regola – sta tutta nell’uso vivo della lingua: usare parole scadute è sempre un vezzo e quindi un vizio. Per questo non mi è sembrato il caso di adoperare molte delle parole di Boccaccio, che si usavano ai tempi suoi e oggi sono state smesse anche dagli stessi toscani. Allora perché non mi sono limitato alle parole in uso nel toscano attuale, come vorrebbero i teorici, appunto, toscani? Perché le regioni e le nazioni non sono torri d’avorio per letterati schifiltosi e le correnti di comunicazione hanno sempre avuto la forza di trasportare dall’una all’altra non solo merci ma anche parole nuove, che poi, a seconda che la gente le usi o no, entrano nel vocabolario o vengono dimenticate. Lo testimonia l’autorità degli antichi e lo si vede chiaramente nel Decamerone stesso, dove di parole francesi, spagnole e provenzali – alcune delle quali forse ormai incomprensibili per i toscani di oggi – ce ne sono tante che, a levarle tutte, i due volumi diventerebbero sì e no un mezzo tascabile. Secondo me, la lingua adoperata in altre regioni italiane, in città dove si concentrano uomini di cultura e d’ingegno che parlano con eloquenza di importanti affari di stato, di letteratura, di scienze militari e di commercio, non è da buttar via: perciò penso che non mi si possa dare del pazzo se nella mia lingua scritta ho usato, tra i vocaboli della lingua parlata in quelle città, i più eleganti, quelli che suonano meglio e che comunemente vengono ritenuti espressivi e corretti, benché non siano toscani e abbiano, a volte, perfino un’origine europea. Oltretutto, molte delle parole derivate dal latino che si usano in Toscana sono chiaramente storpiate, mentre nella zona padana e in altre parti d’Italia sono rimaste com’erano in latino, senza deformazioni, e tutti le usano così spesso che non solo le persone colte le considerano di buona lingua italiana, ma anche gli analfabeti le capiscono senza difficoltà. Quindi credo di non aver sbagliato se io, mantovano, ho usato nella mia scrittura qualcuna di queste parole: ho preferito prendere quello che c’era di autentico e ruspante nella mia terra piuttosto che portarmi a casa le storpiature e le sofisticazioni di un dialetto altrui. E poi, non mi sembra giusto quello che dicono molti grammatici, che la lingua italiana sarebbe tanto più bella quanto meno assomiglia al latino; e non capisco perché tra tutti gli usi linguistici si debba dare a uno solo una tale autorità che basterebbe l’uso toscano per nobilitare delle parole latine smangiate e smozzicate e farle sembrare tanto fini che tutti le possano usare, così mutilate, come parole «belle» (e chi lo nega? per carità!), mentre l’uso lombardo – o qualunque altro – non avrebbe il potere di far passare per accettabili le parole latine originali, intere, tali e quali, come appena sfornate. Diciamoci la verità: se si può definire un folle presuntuoso chi inventa neologismi inutili o vuole mantenere in vita delle parole morte che nessuno usa più, alla stessa maniera mi sembra, oltre che difficile, criminale violentare la forza della lingua per cancellare, anzi seppellire vive delle parole che hanno sfidato i secoli e si sono difese dagli attacchi del tempo con lo scudo dell’uso, mantenendo la loro dignità fulgida e intatta mentre intorno l’Italia andava in pezzi e tra guerre e vergogne nazionali tutto, la lingua, l’architettura, le mode e le abitudini cambiavano. Io quindi mi considero scusato per non aver voluto né usare nella mia scrittura i toscanismi di Boccaccio che in Toscana non si usano più, né piegarmi alla norma imposta da quelli che ritengono impropria ogni parola non risciacquata in Arno. Per riassumere, penso di aver modellato su scrittori non meno autorevoli del Boccaccio sia l’argomento del libro che la mia lingua – per quel che la lingua di uno scrittore può servire da modello alla lingua di un altro; e non credo che mi si possa accusare con la matita rossa e blu per aver scelto di farmi riconoscere per lombardo parlando lombardo invece di farmi passare per toscano toscaneggiando troppo: mi sarebbe successo quello che successe a Teofrasto, il filosofo di provincia che proprio perché parlava ateniese meglio di un ateniese fu subito riconosciuto da una vecchietta ignorante per quello che era, un provinciale. Ma dato che di questa attualissima questione della lingua ho fatto chiacchierare in abbondanza i miei personaggi nel Libro Primo, per ora basta così. Aggiungerò soltanto, per togliere di mezzo ogni contestazione, questo: ai miei criticoni confesso che questa loro pregiata e preziosa lingua toscana io non la conosco; ho scritto nella mia, ho scritto come parlo e per quelli che parlano come parlo io. E con ciò non mi sembra di aver offeso nessuno, perché, secondo me, non c’è nessuna legge che proibisca a uno di scrivere e di parlare nella propria lingua. D’altra parte, nessuno è costretto a leggere o a ascoltare quello che non gli va. Di conseguenza, se quelli lì non vorranno leggere il mio Cortigiano, cavoli loro. Io non mi offendo mica.
III
Altri vanno dicendo che, visto quanto è difficile, anzi quasi impossibile trovare un uomo perfetto come io vorrei che sia il mio cortigiano, non valeva la pena di scriverne, perché è del tutto inutile insegnare una cosa che non si può imparare. A costoro rispondo che sono ben contento di aver sbagliato in compagnia di Platone (La Repubblica), Senofonte (Ciropedia) e Cicerone (De Oratore), per non parlare di tutti gli altri che hanno discettato sul mondo delle idee, nel quale, se ragioniamo platonicamente, come c’è il modello ideale dello stato perfetto e del re perfetto e dell’oratore perfetto ci dev’essere anche quello del cortigiano perfetto. Se io scrivendo non sono riuscito a avvicinarmi alla sua immagine ideale, gli aspiranti cortigiani faranno meno fatica di me perché, per avvicinarsi nella pratica alla meta e al modello che io propongo, loro avranno questo manuale; e se neanche così riusciranno a raggiungere quella perfezione – qualunque sia – che io mi sono sforzato di rappresentare, be’, chi le si avvicinerà di più sarà il più perfetto: quando si fa una gara di tiro e nessuno centra in pieno il bersaglio, chi ci va più vicino vince, o no?
Altri ancora dicono che ho voluto farmi un autoritratto: secondo loro, sarei convinto che tutte le virtù che attribuisco al cortigiano modello ce le ho io. Egregi signori, non nego certo di aver provato a fare tutto quello che vorrei far fare al cortigiano, e penso che nessuno, per quanto erudito, avrebbe potuto scrivere questo libro senza avere perlomeno qualche cognizione degli argomenti che vi si trattano; ma nel giudicare me stesso non sono tanto sprovveduto da poter presumere di sapere tutto quello che so desiderare.
E adesso affido la mia difesa da queste accuse (e forse da molte altre) al giudizio dell’opinione pubblica; perché quasi sempre il pubblico, anche se non capisce bene, sente a naso un certo profumino di buono o di cattivo e, senza saper spiegare perché, gradisce questo e rifiuta quello, ama questo e non compra quello. Perciò, se il libro piacerà a tutti e dappertutto, io lo giudicherò buono e penserò che meriti di avere vita lunga; se invece non piacerà, lo giudicherò pessimo e mi convincerò subito che se ne debba perdere anche il ricordo. E se poi ai miei critici non va bene nemmeno il giudizio del pubblico, si accontentino almeno di quello del tempo, che a lungo andare mette a nudo i difetti nascosti di tutte le cose e, padre della verità e giudice al di sopra delle parti, emette sempre una sentenza giusta sulla morte o la vita dei libri.
Baldassar Castiglione
![]() Al signor Alfonso Ariosto
Al signor Alfonso Ariosto![]()
LIBRO PRIMO
1
Per molto tempo, carissimo Alfonso, non ho saputo decidere quale cosa mi riusciva più difficile tra queste due: rifiutarti ciò che mi hai chiesto tante volte con tanta insistenza, o dartelo. Infatti, da una parte mi sembrava troppo duro negare qualche cosa, e soprattutto un’ottima cosa, a una persona che mi piace molto e da cui sento di essere molto amato; d’altra parte, mettermi in un’impresa che non ero sicuro di saper portare a termine mi sembrava poco conveniente per uno che tiene le critiche giuste nella considerazione in cui devono essere tenute. Alla fine, dopo averci pensato ben bene, ho deciso di fare l’esperimento per vedere quanto aiuto possono dare alla mia buona volontà quell’affetto e quell’intenso desiderio di far piacere che, solitamente, spingono gli uomini a darsi tanto da fare in altre cose.
Mi chiedi dunque che io scriva quali sono, secondo me, l’essenza e le tecniche della cortigianità di cui un gentiluomo stanziato nelle corti dei potenti dovrebbe disporre per essere capace di servirli a puntino in ogni affare onesto, entrando così nelle loro grazie e ricavandoci un prestigio pubblico; insomma, quale specie di uomo si meriterebbe la definizione di portaborse ideale. Meditando su questa richiesta, io dico che se non mi fosse sembrata una vergogna maggiore essere considerato poco premuroso da te che poco prudente dagli altri, avrei scansato questa faticaccia: con tutta la varietà di usi e costumi che c’è nelle corti europee, mi domando infatti se non sembrerò un presuntuoso a tutti quelli che sanno quanto è difficile dire: «questa è la cortigianità perfetta, la migliore in assoluto», giacché capita spesso che una stessa cosa ci piaccia o non ci piaccia solo per abitudine, e talvolta ne deriva che le mode, le costumanze, i comportamenti e i riti sociali che un tempo erano un must diventano volgari e, viceversa, quelli che erano volgari diventano il non plus ultra della raffinatezza. Evidentemente, non è il buon senso ma l’andazzo corrente a vincere, facendo penetrare tra noi modi di vivere nuovi e cancellando quelli vecchi fino al punto che chi cerca di valutarne i pregi spesso si sbaglia. Perciò io, che vedevo questa e molte altre difficoltà nell’argomento su cui mi veniva proposto di scrivere, ora mi sento in obbligo di mettere un po’ le mani avanti e di chiarire che questo sbaglio, se sbaglio si può chiamare, l’ho fatto io ma l’hai fatto anche tu, e quindi, se ne ricaverò delle critiche, ce le divideremo a metà; perché tu che mi hai imposto un carico superiore alle mie impari forze non sei meno colpevole di me che me lo sono assunto.
Ma andiamo a incominciare e, se è possibile, svolgiamo questo nostro compito di progettare un cortigiano tanto eccellente che un principe degno di averlo al suo servizio meriterebbe di essere definito un gran signore anche se governasse uno staterello da niente. In questi quattro libri non seguiremo il solito ordine dei manuali, con la suddivisione delle regole per argomenti come quasi sempre si fa oggi per insegnare qualsiasi cosa; rinnovando un simpatico genere letterario piuttosto in voga nell’antichità, metteremo invece in scena alcune conversazioni tenute sul nostro argomento da persone molto distinte. Io non ero presente, perché al tempo di questi dibattiti mi trovavo in Inghilterra, ma poco dopo il mio ritorno mi furono raccontati da uno che è un registratore vivente, e a mia volta mi sforzerò di ricordarli, fin dove la memoria mi assisterà, per filo e per segno, affinché tutti sappiano quello che pensavano e dicevano su questo argomento delle persone degne del massimo rispetto e al cui giudizio ci si poteva rimettere a occhi chiusi in tutto. Non credo di andare fuori tema se, per arrivare con ordine là dove voglio andare a parare, racconterò come e perché si svolsero queste conversazioni.
2
Sulle pendici degli Appennini, quasi al centro dell’Italia, sul versante adriatico, c’è, e non è una novità, la piccola città di Urbino. Benché si trovi tra le montagne, e montagne non così ridenti come ce ne sono forse altrove, ha avuto la fortuna che le terre intorno sono ben coltivabili e producono raccolti grassi, in modo che, oltre a tanta aria sana, la città è ricca di tutto ciò che fa un buon prodotto nazionale lordo. Ma tra le maggiori attrattive che le si possono riconoscere, la principale, secondo me, è che da lungo tempo in qua è sempre stata governata da una dinastia ottima (eccezion fatta per la parentesi di Cesare Borgia, che le ha soffiato la città per qualche tempo: ma durante le Guerre d’Italia questo era un incidente comune). Senza andare a cercare più lontano, possiamo sostenere la nostra affermazione rievocando la gloriosa memoria del duca Federico, che ai tempi suoi fu un faro per tutta l’Italia; e sono ancora vivi molti uomini attendibili che possono testimoniare di aver personalmente osservato la sua saggezza, umanità, giustizia, generosità, grandezza d’animo e valore militare; di quest’ultimo fanno fede, in particolare, le sue tante vittorie, le conquiste di piazzeforti imprendibili, la velocità nei movimenti tattici e il fatto che non poche volte con un pugnetto di soldati mise in fuga eserciti ben più forti e agguerriti, e di battaglie non ne perse mai una, tanto che non avremmo torto se lo paragonassimo ai più famosi generali antichi. Tra le altre cose buone che fece, Federico II da Montefeltro costruì, sul fianco scosceso della collina di Urbino, un palazzo che per molti storici dell’arte sarà il più bel palazzo del rinascimento italiano; e lo fece dotare di tante comodità che sembrava non un palazzo ma una città intera in forma di palazzo; e per l’arredamento non si limitò ai soliti vasi d’argento e tappezzerie di costosissimi broccati d’oro e di seta e altre cosette del genere, ma collezionò un’infinità di statue antiche in marmo e bronzo, quadri di grandi pittori, strumenti musicali di ogni tipo; e in casa sua non voleva niente che non fosse più che raro e pregevole. Poi, spendendo un capitale, mise insieme una biblioteca di rarissimi e importantissimi testi greci, latini, ebraici: e li fece rilegare tutti in oro e in argento, perché li considerava il tesoro più prezioso del suo grande palazzo.
3
All’avanzata età di sessantacinque anni questo duca morì gloriosamente come era vissuto, di morte naturale. E lasciò erede del suo stato l’unico figlio maschio, un ragazzino di dieci anni già orfano di madre: Guidubaldo. Sembrò subito che, assieme alla proprietà di Urbino, questo bambino avesse ereditato dal padre tutti i suoi pregi; aveva un carattere che era una meraviglia e prometteva tanto che sembrava perfino troppo, o almeno più di quanto ci si può aspettare da un essere umano. E la gente cominciò a dire che, tra tutte le imprese del duca Federico, nessuna superava quella di aver generato un figlio così. Ma la sorte, i...