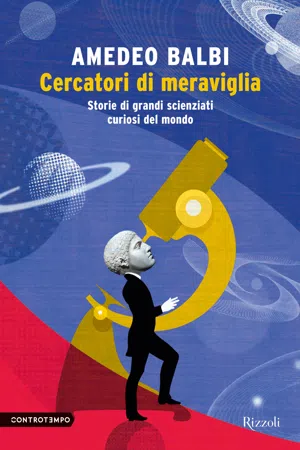![]()
1
Eppur si muove
Tenetevi forte: in questo preciso istante, state girando su una giostra, a una velocità che supera i mille chilometri l’ora.
Il valore esatto dipende dalla latitudine a cui vi trovate: la giostra in questione è infatti il pianeta su cui vi è capitato di nascere, ovvero, salvo clamorose sorprese, la Terra. Di sicuro lo sapete già, ma bisogna aggiungere che la Terra, oltre a ruotare su se stessa, gira anche attorno a una stella chiamata Sole. Questo significa che, mentre leggete queste righe (e in qualunque altro momento della vostra vita, per la verità), vi state muovendo rispetto alla stella suddetta a una velocità di circa centosettemila chilometri l’ora. In effetti, le cose sono ancora più complicate, perché il Sole si muove a sua volta rispetto al centro della nostra galassia, la Via Lattea, la quale viaggia anche lei a velocità folle nello spazio. In realtà, nell’universo non c’è niente che possa dirsi immobile, in assoluto.
Ciò nonostante, la terra che avete sotto i piedi vi sembra piuttosto stabile. Non sentitevi tonti: generazioni di esseri umani hanno dato per scontato che la Terra fosse il posto più fermo e centrale dell’universo. Ci sono voluti moltissimi anni, parecchi mal di testa, e anche un certo numero di episodi non proprio edificanti, per venire a capo della questione.
Come spesso accade, qualche inascoltato precursore si trova già nell’antichità. Il primo di cui abbiamo tracce storiche si chiamava Aristarco, era nato nell’isola greca di Samo e, circa tre secoli prima di Cristo, si era messo in testa che la Terra dovesse ruotare attorno al Sole. Come è facile intuire, non riuscì a convincere molti altri che l’idea fosse sensata. Al contrario, il modello di universo con la Terra ferma e centrale, reso noto da Tolomeo, si impose senza troppi sforzi e restò il preferito fino a non molti secoli fa.
Nel XVI secolo, un astronomo polacco di nome Copernico riscoprì le idee di Aristarco e, inopinatamente, se ne innamorò. La cosa rischiava di non renderlo molto popolare, e così Copernico si tenne le sue preferenze per sé. Solo dopo la sua morte, il suo trattato De revolutionibus orbium coelestium prese lentamente a circolare in Europa e, dopo qualche decennio, le menti più sottili avevano cominciato a rendersi conto che la cosa poteva funzionare. Anzi, a dire il vero, il modello copernicano sembrava una spiegazione della realtà assai più convincente di quello tolemaico.
La storia di come anche il resto dell’umanità abbia, seppure a fatica, aperto gli occhi, rendendosi conto che la Terra non era affatto immobile come sembrava, comincia (chi l’avrebbe mai detto?) in Italia.
Galileo patteggia
Il 22 giugno 1633, un professore sessantanovenne stanco e in salute malferma venne condotto in una delle sale del convento domenicano adiacente la chiesa di Santa Maria sopra Minerva, a Roma. Se entrasse in quella stanza oggi, l’anziano accademico si troverebbe circondato dai volumi della biblioteca della Camera. All’epoca trovò invece ad attenderlo un molto meno rassicurante collegio di cardinali, riunito per leggergli la sentenza di condanna emessa dal tribunale della Santa Inquisizione.
Il malcapitato, che indossava la veste bianca del penitente e fu invitato ad ascoltare la sentenza in ginocchio e a capo chino, si chiamava Galileo Galilei, ed era stato giudicato colpevole di aver sostenuto la tesi che la Terra girasse attorno al Sole e non fosse il centro dell’universo. La condanna fu di prigione a vita nei locali del Santo Uffizio (in seguito commutata in quelli che oggi chiameremmo arresti domiciliari), con la pena accessoria di una recita settimanale dei salmi per i tre anni successivi. Tutto sommato, a Galileo andò anche bene, perché si risparmiò le torture fisiche che gli inquisitori tendevano a elargire con una certa facilità, e soprattutto evitò il rogo toccato a Giordano Bruno solo una trentina di anni prima. Si potrebbe dire che Galileo se la cavò con un patteggiamento. L’udienza terminò infatti con la lettura da parte del trasgressore di un testo scritto in cui egli dichiarava di abiurare, maledire e detestare le idee in odore di eresia che gli venivano attribuite.
Fin qui i fatti, riferiti da documenti scritti e da testimonianze dell’epoca. Dopo di che, la devozione popolare vorrebbe costringerci a immaginare la scena seguente: Galileo che esce all’aperto, guarda prima il cielo poi il pavimento della piazza, sbatte il piede per terra e, con umore contemplativo, pronuncia le parole «Eppur si muove!». La Terra, sottinteso.
L’episodio fu riportato in questi termini per la prima volta oltre un secolo dopo, nel 1757, in una collezione di biografie e opere di italiani illustri scritta in inglese da tal Giuseppe “Joseph” Baretti, un critico letterario torinese emigrato a Londra. Sembra altamente probabile che il Baretti se lo sia inventato di sana pianta. Lo studioso galileiano Stillman Drake scrive però che, nel 1911, una famiglia belga portò a far ripulire un dipinto di sua proprietà raffigurante Galileo nelle celle dell’Inquisizione. Una volta tolto dalla cornice, il dipinto, datato tra il 1643 e il 1645 e attribuito alla scuola del pittore spagnolo Murillo, si rivelò più grande di quanto si pensasse: una parte era stata ripiegata dietro il telaio e mostrava, scritto sul muro della prigione, nella direzione verso cui puntava il dito di Galileo, il testo «Eppur si muove!». Drake conclude quindi che la frase circolasse già pochi anni dopo il processo, e che fosse arrivata a Madrid per via orale, portata dal fratello dell’arcivescovo Ascanio Piccolomini, amico e protettore di Galileo. Chissà. Se proprio dobbiamo figurarci che la frase sia stata pronunciata, ci viene più facile pensare al povero Galileo che la bofonchia fra sé e sé (magari accompagnata da un’imprecazione in dialetto) mentre si rimette in piedi, con le giunture che cigolano sotto il peso degli anni e degli eventi.
In ogni caso, uno potrebbe chiedersi su cosa fosse basata tutta questa ostinazione da parte di Galileo nel difendere una tesi che la maggior parte delle persone di buon senso, all’epoca, riteneva assurda (e ancora oggi, qualcuno non del tutto convinto, a cercare bene, lo si trova). Andiamo, lo vediamo tutti che la Terra sta ferma, no? Ci vogliono evidenze forti per convincerci del contrario e Galileo, padre del metodo sperimentale, doveva certo averne di fortissime. Giusto?
Non esattamente.
Tre personaggi in cerca di una risposta
I guai di Galileo con l’Inquisizione hanno una storia lunga e complessa, ma si può dire che la goccia che fece traboccare il vaso fu la pubblicazione da parte del pisano di un libro che, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto chiamarsi Del flusso e del reflusso (poi vedremo perché), ma che invece si chiamò Dialogo di Galileo Galilei Linceo Matematico Sopraordinario dello Studio di Pisa e Filosofo, e Matematico Primario del Serenissimo Gr. Duca di Toscana, dove ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due Massimi Sistemi del Mondo, Tolemaico e Copernicano, proponendo indeterminatamente le ragioni Filosofiche, e Naturali, tanto per l’una quanto per l’altra parte, titolo che ha il pregio della chiarezza, se non quello della sintesi.
I protagonisti del Dialogo sopra i massimi sistemi, ambientato a Venezia, sono tre gentiluomini toscani: Salviati, che in realtà è una specie di alter ego dello stesso Galileo, Simplicio, che riflette le posizioni degli accademici aristotelici dell’epoca, e Sagredo, l’uomo di cultura al di sopra delle parti che i due tentano a turno di convincere. Salviati e Sagredo erano in effetti i nomi di due conoscenti stretti di Galileo, mentre Simplicio è un nome di fantasia: scelta prudente, visto che Simplicio fa sistematicamente la figura del fesso. Salviati appare invece come una mente superiore, e le simpatie di Sagredo per quest’ultimo sono piuttosto evidenti. Il fatto che fosse Galileo a dare le parti in commedia non fu del tutto estraneo all’esito della disputa. Va detto, d’altronde, che gli aristotelici dell’epoca erano davvero piuttosto fessi, e Galileo era in realtà una mente superiore. Il libro è scritto in un italiano semplicemente meraviglioso, e leggerlo è un assoluto godimento. Galileo voleva che fosse apprezzato da più persone possibile, che non contenesse troppi argomenti matematici, e che desse ampio spazio alle digressioni. Era, insomma, un libro divulgativo. E diventò subito un best seller.
Ora, come spiega Galileo stesso nell’introduzione, nel 1616 i teologi del Sant’Uffizio avevano preso una posizione ufficiale sulla questione della mobilità della Terra: sostenere che la Terra ruotasse intorno al Sole era assurdo, sciocco, falso e, incidentalmente, contrario alle Scritture. Quindi, formalmente eretico.
Il pronunciamento era una risposta esplicita allo stesso Galileo che, in una lettera alla granduchessa Cristina di Toscana, aveva sostenuto le posizioni copernicane, asserendo che le dispute sulle questioni naturali non dovessero essere decise sulla base dell’autorità delle Scritture ma a seguito di «sensate esperienze e dimostrazioni necessarie»: ovvero, usando il metodo scientifico. Sacrosante parole, seppure un po’ in anticipo sui tempi. Come se non bastasse, Galileo aveva aggiunto alcune sue considerazioni teologiche su come meglio interpretare i passi biblici per accordarli con la visione copernicana, affermando infine che lo Spirito Santo dovesse limitarsi a suggerire come andare in cielo e non come andasse il cielo.
Era un po’ troppo, ed era scattata l’ammonizione. I teologi, guidati dal cardinal Bellarmino, avevano convocato Galileo a Roma e lo avevano invitato a occuparsi d’altro, preferibilmente di qualcosa che non avesse alcuna attinenza con la Bibbia. Un conto era trattare il moto della Terra come una costruzione ipotetica che poteva servire a spiegare le osservazioni astronomiche, un altro era sostenerne la realtà fisica, cosa di cui non esisteva alcuna evidenza. Ancora peggio era voler spiegare ai teologi come fare il proprio mestiere. Per rendere più persuasivo l’incitamento a cambiare argomento di studio, il Sant’Uffizio aveva messo nero su bianco la condanna delle idee di Copernico e tolto dalle stampe il suo libro De revolutionibus, pubblicato più di settant’anni prima.
Galileo non si era mostrato particolarmente scosso. Non era stato adottato alcun provvedimento diretto contro di lui, aveva ottimi rapporti con il mondo ecclesiastico (persino una figlia suora) e un’altissima opinione di se stesso. Così quando, dopo molti anni di lavoro, diede alle stampe il Dialogo, pensava di essere in una botte di ferro. La forma narrativa gli permetteva di distanziarsi e di sostenere un’imparzialità di facciata fra la tesi tolemaica e quella copernicana, sebbene per «pura ipotesi matematica» nel discorso egli avesse preso le parti di quest’ultima. Addirittura, arrivò a sostenere, con una certa faccia tosta, che la ragione per cui aveva scritto il libro fosse quella di essere «testimonio di sincera verità» contro chi aveva voluto «temerariamente» mettere in dubbio il «salutifero editto» del 1616 come «parto non di giudizioso esame, ma di passione poco informata». La verità era che pensava di avere un formidabile asso nella manica, e non era tipo da riuscire a tenerlo per sé: si trattava niente di meno che di una dimostrazione sperimentale in grado di mostrare la realtà fisica del moto terrestre.
Galileo svela le carte per gradi, nel corso delle quattro giornate in cui si articola il Dialogo. Inizia smontando l’argomento più ovvio contro il movimento terrestre, ovvero: se la Terra si muove, perché le cose che sono sulla sua superficie non rotolano in direzione contraria al moto? Perché, se faccio cadere un peso dall’alto, questo cade sulla perpendicolare, visto che la Terra nel frattempo ha cambiato posizione? Perché una freccia scagliata verso ovest non va più lontana di una lanciata verso est? Perché la Terra non scorre sotto la pancia degli uccelli in volo, lasciandoli fermi dove stanno, come chi corra su un tappeto mobile? E via di questo passo. Galileo risponde invitando a compiere un meraviglioso esperimento mentale che è una pietra miliare nella storia della scienza.
Immaginate, dice Galileo, di trovarvi nella stiva di una grande nave, e di voler capire se la vostra nave si stia muovendo o sia ancora ferma nel porto. Per farlo, visto che non potete guardare fuori, potete solo studiare il movimento degli oggetti nella stiva, per esempio il volo degli insetti in ogni direzione, o le gocce d’acqua che cadono in un vaso dall’imboccatura molto stretta. Ebbene, continua Galileo, a patto che la nave si muova a velocità perfettamente costante, senza scossoni e cambi di direzione, non riuscirete a notare alcun cambiamento in quegli effetti, e non potrete stabilire da quelli se la nave cammina o sta ferma. In altre parole, Galileo sta enunciando il suo principio di relatività: le leggi del moto devono rimanere le stesse in ogni sistema di riferimento che si muova senza accelerare. La Terra, con buona approssimazione, può ritenersi uno di questi sistemi, e non c’è modo di notare l’effetto del suo movimento osservando le traiettorie dei corpi materiali.
L’argomento della nave era corretto e convincente, ma non era una prova che la Terra si muovesse: semmai, rimuoveva le obiezioni contro il moto terrestre sollevate dagli aristotelici. Galileo passa allora a una serie di ragionevoli evidenze indirette a supporto del sistema copernicano, derivate dalle osservazioni astronomiche che egli stesso aveva compiuto per la prima volta molti anni addietro, quando si era costruito un cannocchiale e per primo lo aveva puntato verso il cielo notturno: il fatto che Venere avesse delle fasi simili a quelle lunari, segno che il pianeta orbitava attorno al Sole; l’esistenza di satelliti in orbita attorno a Giove; il movimento delle macchie solari, spiegabili con la rotazione della stella, e così via. Erano osservazioni che il sistema copernicano spiegava meglio di quello tolemaico e, partendo da esse, Galileo riesce addirittura nel capolavoro retorico di guidare per mano l’inconsapevole Simplicio nella costruzione del modello eliocentrico.
Ma Galileo è perfettamente consapevole che sta chiedendo ai suoi lettori di accettare qualcosa che è in contrasto con l’esperienza immediata: a un certo punto, durante la terza giornata, Salviati confessa a Sagredo che egli stesso si meraviglia di come l’idea di Copernico possa aver trovato qualche seguace, visto fino a quale punto essa pretende che la ragione prevalga sui sensi. Andare oltre il buon senso comune, sottometterlo al metodo e al ragionamento: questo richiedeva la nuova scienza galileiana.
Dopo aver preparato il terreno, tutto è pronto per l’attacco finale, l’esibizione della prova conclusiva. Galileo, con un trucco da drammaturgo consumato, l’ha introdotta in anticipo, all’inizio della terza giornata, facendo arrivare il povero Simplicio in ritardo, tutto trafelato, perché la sua gondola è restata in secca in un canale a causa dell’alta marea.
Eccola, l’arma che ha in serbo Galileo: la spiegazione del fenomeno delle maree.
Anche i migliori sbagliano: Galileo e le maree
L’idea gli era venuta molti anni prima, mentre, stipendiato dalla Repubblica veneziana, lavorava all’università di Padova. Si dice che l’osservazione che fece accendere la lampadina avesse ancora a che fare con una nave: quella che trasportava acqua potabile alla città di Venezia. In questo caso, però, il fenomeno che attirò l’attenzione di Galileo era di natura opposta a quella dell’esperimento mentale degli insetti nella stiva: mentre in quel caso si richiedeva che la nave si muovesse a velocità costante, in questo erano proprio gli improvvisi cambi di direzione e velocità a essere importanti.
Galileo notò che, quando la nave sballottava di qua e di là, l’acqua contenuta nel vascone sciabordava, e ipotizzò che una cosa del genere potesse avvenire agli oceani terrestri a causa del moto del pianeta. Egli sapeva che nel modello copernicano il movimento di ogni punto sulla superficie terrestre era il risultato della combinazione di due moti diversi: quello annuale di rivoluzione della Terra attorno al Sole, e quello quotidiano di rotazione della Terra attorno al proprio asse. La conseguenza era che, ogni giorno, un punto sulla superficie terrestre avrebbe dovuto viaggiare per dodici ore nella stessa direzione del moto attorno al Sole, e per dodici in direzione contraria. Secondo Galileo, questi periodici cambi di direzione potevano imprimere una spinta alle acque dei mari terrestri, alterandone il livello e spiegando così il ciclo delle maree. Nel 1597, Galileo scrisse all’astronomo tedesco Keplero, per comunicargli di aver accettato la posizione copernicana, dopo aver scoperto che essa spiegava molti fenomeni fisici che non erano spiegabili in altro modo. Galileo non lo dice esplicitamente, ma l’impressione è che, già allora, uno dei fenomeni naturali che aveva in mente fosse proprio quello delle maree (le sue osservazioni astronomiche con il cannocchiale sarebbero arrivate solo nel 1609). Keplero, a sua volta copernicano convinto, aveva però un’ipotesi diversa: per lui era l’azione della Luna a spiegare la variazione del livello del mare.
Galileo riteneva la spiegazione di Keplero assurda, “fanciullesca”, influenzata da idee astrologiche e arcaiche: come poteva la Luna esercitare, attraverso lo spazio vuoto, un’azione a distanza sulla Terra? Obiettivamente, il fatto che Keplero facesse riferimento a concetti fantasiosi come la «simpatia della Luna per l’acqua» non aiutava. La spiegazione di Galileo, tutta meccanica e razionale, era indubbiamente più moderna.
Purtroppo, era anche completamente sbagliata. Oggi sappiamo che l’ipotesi di Keplero era più vicina alla realtà, ma all’epoca nessuno aveva mai sentito parlare di una cosa chiamata forza di gravità. Così, Galileo poté scartare l’idea del collega come una pura superstizione. Convinto di aver fatto bingo, e di essere riuscito in un solo colpo a spiegare un fenomeno misterioso come quello delle maree e a dare una prova diretta del moto terrestre e della correttezza del modello copernicano, Galileo nel 1616 si era messo all’opera per esporre le sue idee in un trattato, sotto forma di lettera al cardinale Alessandro Orsini, con il titolo Discorso del flusso e reflusso del mare.
Subito dopo, però, era arrivato il monito dell’Inquisizione, e Galileo aveva trovato saggio abbandonare questo argomento. Lo riprese solo molti anni dopo, nel 1623, quando fu eletto papa Urbano VIII, con cui Galileo era in cordialissimi rapporti. Fu proprio dopo essere stato a colloquio con l’amico appena diventato papa che Galileo ebbe l’impressione (errata, evidentemente) che i tempi potessero essere maturi per riaffrontare il discorso interrotto. Così, il Discorso sulle maree fu riciclato, diventando l’ossatura per la quarta giornata del dialogo tra Sagredo, Salviati e Simplicio. Il nuovo libro ottenne l’autorizzazione alla pubblicazione a patto di eliminare dal titolo ogni riferimento alle maree (ovvero a quella che sembrava la principale evidenza fisica a favore del modello copernicano), e diventò così il Dialogo sopra i massimi sistemi.
Purtroppo, quello che Galileo sperava potesse essere il punto più alto della sua traiettoria scientifica si trasformò nell’inizio della sua rovina. A chiusura del Dialogo, dopo che la teoria delle maree è stata elegantemente illustrata dal sempre brillante Salviati, col controcanto ammirato dell’ormai copernicano Sagredo, l’ottuso Simplicio ammette, annichilito, di non averci capito granché. Sull’orlo della sconfitta, il pover’uomo prova a raccattare almeno un pareggio, sostenendo che, se Dio volesse, potrebbe, con la sua infinita potenza, far muovere le acque, senza per questo dover muovere anche il vaso che le contiene, ovvero la Terra, e che sarebbe ...