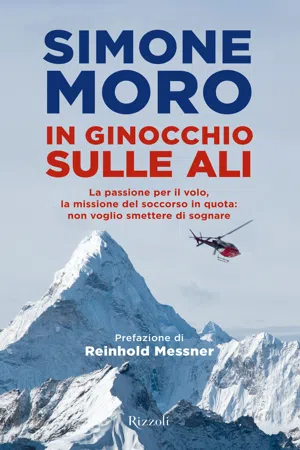![]()
1
Salvo, grazie a un AS350 B2
Argentina, 1993. Era il quinto giorno in parete e le temperature avevano toccato anche i -46 gradi. Io e Lorenzo Mazzoleni eravamo in trappola, bloccati nella nostra minuscola tendina, sulla parete sud dell’Aconcagua, quella sempre in ombra perché rivolta sull’emisfero meridionale, nel pieno dell’inverno australe. Nevicava senza sosta e noi dovevamo uscire continuamente a spalare la neve dalla piccolissima piazzola sospesa sull’abisso in cui c’era spazio solo per il nostro rifugio di nylon verde e giallo. Sotto, i difficili 2000 metri verticali appena scalati. Avevamo superato le avversità maggiori e ci mancavano meno di 1000 metri per arrivare in cima alla montagna più alta delle due Americhe e compiere la prima salita invernale della parete. Ovviamente eravamo gli unici su tutto il massiccio montuoso con attrezzatura buona ma in stile leggero e senza nessun supporto logistico. Avevamo trasportato tutto alla base della parete con numerosi viaggi e gli sci ai piedi. Poi la scalata in stile alpino, io, Lorenzo e un unico innocente accordo verbale con Alberto, un altro amico che componeva la spedizione ma che vi aveva rinunciato dopo aver visto la parete.
«Senti Alberto, se non siamo a Puente del Inca entro cinque giorni vieni a cercarci o chiama i soccorsi. Se non ci vedi è perché abbiamo bisogno d’aiuto o è successo qualcosa.»
«D’accordo Simone, ma vedete di non fare cazzate, ok?»
«Ma sì dai, tu però tieni solo a mente questa cosa!»
Le condizioni non accennavano a cambiare, anzi sembravano peggiorare e dentro la nostra tendina ci sentivamo quasi soffocare. Forse per scongiurare il peggio o forse per distrarci, con la mia piccola telecamera avevamo anche videoregistrato il nostro «ultimo» messaggio. Era molto ironico, e in fondo io avevo la convinzione che sarebbe arrivato un elicottero a salvarci, quello mandato da Alberto allo scadere del quinto giorno, e che quel video non sarebbe stato il nostro testamento ma un ricordo che ci avrebbe fatto fare quattro risate una volta tornati giù. Vivevo quei momenti con una doppia consapevolezza: quella di una probabile fine e quella molto forte che un elicottero ci avrebbe tirato fuori da quella situazione per restituirci la vita, regalarci la salvezza.
L’elicottero non arrivò, e fummo costretti ad affidarci unicamente alle nostre energie fisiche e mentali. Affrontammo il tentativo disperato di ridiscendere quasi 2000 metri di dislivello nella tormenta, con pochissimo materiale alpinistico e con scarse possibilità di successo. Ce la facemmo attaccandoci alla volontà disperata di non cedere allo sconforto e al dubbio. Giunti alla base della parete, increduli, trovammo pure le forze per compiere altri 30 chilometri e più per arrivare alla strada di confine tra Argentina e Cile e incontrare Alberto, che non era riuscito a organizzare nessun soccorso e neppure a mobilitare un elicottero.
Così scontato per noi occidentali, il mezzo nel quale avevo riposto le mie speranze nei cinque giorni in mezzo alla tormenta, rappresentava un’eccezione rara e costosa che potevano permettersi solo in poche zone montuose del mondo. Per questo Alberto non ne aveva trovato uno che potesse soccorrerci.
Negli anni successivi affrontai alcune spedizioni himalayane, al Lhotse nel 1994, poi al Kangchenjunga nel 1995. Nel 1996 mi impegnai in tre diverse esperienze: all’inizio dell’anno in Patagonia dove salii il Fitz Roy in ventiquattro ore, in primavera ero in Nepal per il Dhaulagiri e in autunno in Tibet per il Shisha Pangma. Nel corso della mia carriera alpinistica ho avuto spesso a che fare con situazioni di pericolo e ho potuto sperimentare, anche indirettamente, che la determinazione a farcela da soli a volte può non bastare.
Nella storia dell’alpinismo, l’11 maggio 1996 è la data che si ricorda tristemente per la tragedia sull’Everest in cui persero la vita otto componenti di due spedizioni commerciali, la Mountain Madness e la Adventure Consultants, tra cui i capispedizione Rob Hall e Scott Fisher.
Le vittime sarebbero state molte di più se Anatoli Boukreev, una guida russa della spedizione di Scott Fisher, non avesse portato in salvo altri alpinisti esausti e dispersi nella tormenta a 8000 metri. Conobbi Anatoli pochi mesi dopo la tragedia: seppur in giorni diversi scalammo la cima centrale del Shisha Pangma, 8008 metri, e da allora divenne una delle persone più importanti della mia vita.
Sulla tragedia del 1996 sono stati scritti libri, articoli, realizzati film e reportage. Sono state dette anche un sacco di imprecisioni e non è mai stato dato il giusto tributo ad Anatoli Boukreev. In particolare Jon Krakauer, il giornalista americano che partecipò alla spedizione di Rob Hall come cliente, ha sparato cinicamente a zero su Anatoli. Senza conoscerlo, senza capire un tubo di alpinismo d’alta quota, senza essere una guida e senza aver mai compreso realmente il ruolo del mio amico nel salvataggio. Eppure il suo libro, scritto magistralmente ma dannatamente di parte e impreciso, ha venduto milioni di copie e gli ha fatto guadagnare milioni di dollari. Krakauer ha però pagato caro quel modo di raccontare la tragedia, perdendo la credibilità e il rispetto di quasi la totalità della comunità alpinistica, abituata a valutare le cose per i gesti e non per le parole. Krakauer-Boukreev: la metafora di due concetti opposti, parole il primo e fatti il gigante russo.
Il numero dei morti in quelle due spedizioni sarebbe stato ancora maggiore se tra i soccorritori non ci fosse stato anche il pilota dell’elicottero militare nepalese, il tenente colonnello Madan Khatri Chhetri, che realizzò un soccorso storico per l’epoca, atterrando con il suo AS350 B2 al Campo 1 dell’Everest a 6096 metri per recuperare Beck Weathers e Makalu Gau. La notizia di questo intervento ai limiti dell’impossibile fece il giro del mondo, ma fu frettolosamente dimenticata, sepolta dai numerosi libri e dalle interviste che seguirono.
Penso che questo soccorso abbia gettato le basi involontarie per la crescita delle missioni in elicottero ad altissima quota. La tecnologia e i progressi in campo aeronautico hanno poi consolidato la consapevolezza che si sarebbe potuto andare più in alto e con una frequenza più regolare in modo da garantire standard di sicurezza migliori non solo per gli alpinisti, ma anche per le popolazioni che vivono nei villaggi più remoti.
Questi flash di memoria non hanno la pretesa di rappresentare le tappe fondamentali dell’evoluzione storica del mezzo a rotore, ma segnano le tappe del mio percorso personale attraverso il quale ho maturato la consapevolezza e il desiderio di fare di questo mezzo e di questo mondo la mia nuova passione e forse la mia futura professione.
Vent’anni fa non esistevano ancora servizi di elisoccorso ed evacuazione ordinari e tutto era lasciato all’intraprendenza di pochissimi piloti privati o ai mezzi militari. Insomma, gli elicotteri per il soccorso in alta quota erano un lusso, e oltre alla scarsa disponibilità anche gli standard di volo e le abilità tecniche non potevano sempre definirsi ottimali.
Un anno dopo la tragedia del 1996, mi trovavo al Campo Base della montagna più alta della Terra. Ero con Anatoli Boukreev e volevamo tentare la traversata Lhotse-Everest. Non eravamo di certo gli unici su quelle montagne, e il villaggio del Campo Base era ormai gigantesco. Le numerose spedizioni militari, commerciali e scientifiche di diverse nazionalità erano il chiaro segnale di come quella montagna fosse cambiata e destinata a lasciare sempre più spazio alle sole spedizioni commerciali. Io e Boukreev condividevamo il nostro permesso con due diverse missioni: per il Lhotse con quella scientifico-alpinistica italiana del comitato Ev-K2-CNR e per l’Everest con un team straniero che non ricordo nemmeno.
Nella primavera del 1997 al Campo Base c’era anche Eric Escoffier con l’obiettivo di scalare il Lhotse. Quell’anno l’alpinista francese aveva annunciato il suo progetto di concludere tutti i quattordici ottomila e le seven summit entro il 2001. Eric era stato un grandissimo alpinista e arrampicatore negli anni Ottanta e la sua carriera era stata bruscamente interrotta da un incidente d’auto nel 1987 che gli aveva causato forti limitazioni motorie nella parte sinistra del corpo. Aveva recuperato abbastanza bene grazie a un’intensa e ferrea rieducazione e aveva ripreso a fare alpinismo benché il livello tecnico non potesse più essere quello di una volta.
Il suo tentativo al Lhotse non andò a buon fine e decise di richiedere un elicottero per essere evacuato dal Campo Base. Il lungo trekking di rientro sarebbe stato troppo pesante per lui che già pensava alle successive cime da tentare. Alla fine fu mandato un elicottero dell’esercito, lo stesso modello impiegato l’anno precedente dal tenente colonnello Madan Khatri Chhetr.
Come in tutte le cose un po’ al limite, più delle macchine sono spesso le persone a fare la differenza. Eric era pronto con le sue borse ai lati della piazzola eretta sopra un seracco e ricoperta di pietre per evitare che la superfice piatta si sciogliesse o si deformasse con il calore del sole. Per facilitare le manovre del pilota, salii sulla piazzola a effettuare i segnali d’atterraggio. L’elicottero, ovviamente di colore verde mimetico, fece due giri sopra di noi e poi impostò la discesa nella mia direzione. La velocità all’inizio era moderata e il rateo di discesa sembrava normale anche per il mio occhio inesperto. Mentre stavo con le braccia alzate a guardare l’elicottero venire verso di me, di colpo la velocità di avvicinamento si fece preoccupante, troppo rapida, così come il rumore delle pale nell’aria che non accennava il classico “schiaffeggio” che sta a indicare una richiamata di potenza e una riduzione della velocità verticale. Quell’elicottero stava piombando dritto su di noi esattamente come un seracco che si stacca dalla parete. Feci giusto in tempo a fare un tuffo di lato, buttandomi dietro una roccia poco sotto la piazzola che sentii lo schianto e il fracasso delle pale che si disintegravano contro le pietre e il ghiaccio della morena. Una delle pale si abbatté proprio contro la roccia dietro la quale avevo trovato riparo e ricordo ancora la forza del colpo e la sua vibrazione.
Dopo l’impatto, il velivolo si ribaltò e si adagiò fumante su un lato, fortunatamente senza incendiarsi. Io e altri corremmo verso la carcassa e aprimmo la porta laterale sinistra da cui tirammo fuori il primo pilota. Era abbastanza magrolino e praticamente incolume. Poi facemmo lo stesso con il secondo pilota, che oltre a essere di corporatura grossa, era in evidente stato confusionale e non collaborava. Ci volle un po’ di tempo per estrarre quel bufalo dall’abitacolo ma alla fine ci riuscimmo. Li portammo nella nostra tenda e li mettemmo immediatamente in ossigenoterapia, vista la quota elevata e lo shock subito.
La telefonata che il pilota in comando fece a Kathmandu ai vertici militari fu davvero buffa. All’inizio nessuno pareva credergli, tutti pensavano fosse uno scherzo. Ci volle qualche minuto di insistenze per far passare il messaggio che l’elicottero aveva fatto una brutta fine. Ne fu mandato un altro che fece numerosi giri sopra il Campo Base prima di decidersi ad atterrare nella piazzola a pochi metri dalla carcassa del mezzo precipitato. I volti dei due piloti appena arrivati mi sembrarono decisamente tesi. Fecero due viaggi: nel primo portarono via i piloti dell’elicottero caduto e nel secondo evacuarono Eric Escoffier.
Anche quell’esperienza vissuta sul campo, da testimone oculare, mi aveva fatto capire quanto fosse precario anche il solo recupero alla base delle montagne e quanto, lungo la scalata, fosse impossibile contare sull’aiuto del mezzo meccanico. Proprio come all’Aconcagua nel 1993, anche in quel 1997 il messaggio rimaneva lo stesso: meglio contare sempre e solo sui propri mezzi quando ci si trova in alta quota e tra le valli impervie dei colossi montuosi del pianeta.
Pochi mesi dopo l’incidente dell’elicottero militare al Campo Base dell’Everest, mi trovavo nuovamente in Nepal. In seguito alla prova del Lhotse in primavera, con Anatoli Boukreev sognavamo di realizzare la prima salita invernale della storia del versante meridionale dell’Annapurna. Il periodo era il più duro e inospitale dell’anno, ma quella stagione in particolare era stata caratterizzata da nevicate molto abbondanti che avevano di fatto chiuso e reso inaccessibile anche la valle dell’Annapurna. Sebbene il Campo Base sia uno tra i più bassi di tutti i giganti di 8000 metri, fummo costretti ad andarci con un elicottero.
Vista la quantità di materiale da trasportare, ci affidammo a piloti e mezzi russi operanti nel Paese himalayano. Ai comandi del potente MI-17, elicottero biturbina in grado di trasportare fino a due tonnellate e mezzo di materiale e arrivare a 4000 metri con ventisei persone a bordo, c’era Serguey Danilov, un amico di Anatoli.
Danilov ci prelevò all’aeroporto di Pokhara con il suo bestione volante, senza nessuna difficoltà arrivò al Campo Base e atterrò in un metro di neve fresca. Quel mezzo era così potente e il vortice generato così forte da sollevare una vera nuvola di neve. In quella situazione di visibilità quasi nulla scendemmo e scaricammo tutto il nostro materiale. In pochi minuti la tormenta artificiale di neve e aria aveva lasciato spazio a un silenzio penetrante, alla solitudine più assoluta.
La storia di quella spedizione è ormai nota: tornai a casa solo, senza Anatoli e Dimitri, scomparsi sotto una valanga gigantesca che aveva travolto anche me. Io ne uscii, contuso e scioccato, ma vivo.
Quella spedizione, rivista oggi con gli occhi dell’alpinista e del pilota, rappresenta una tappa fondamentale nel mio progetto dell’aria. A parte essere stato depositato con successo al Campo Base da un elicottero di sette tonnellate di peso e a pieno carico, fui salvato con un’operazione incredibilmente audace e al limite dell’operatività. Nessuno sapeva dov’eravamo e in quale punto della via stavamo scalando. Per scelta non avevamo preso nessun mezzo di comunicazione ed eravamo pronti all’isolamento per due mesi. Avevamo solo un accordo verbale con il pilota per essere recuperati a fine febbraio.
Dopo essere sopravvissuto alla valanga, dovetti tentare disperatamente di salvarmi, affrontando in discesa quasi 1500 metri di dislivello senza poter usare le mani, che erano state massacrate nella caduta. Avevo fatto un volo di 800 metri, da 6300 a 5500 metri dentro blocchi di ghiaccio e neve che ci erano precipitati in testa staccandosi dalla cresta sommitale. Dal volo, che non aveva risparmiato i miei due amici, ero riemerso in superficie sanguinante e con poche possibilità di sopravvivenza.
Aggrappato alla mia forza di volontà e alla mia voglia di vivere, perdendo sangue e con un occhio tumefatto da cui non potevo vedere, camminai per un giorno e mi trascinai fino alla mia tendina del Campo Base a 4000 metri. Là c’era solo il nostro cuoco Phurba ad attendermi, e certamente non si aspettava di vedermi in quelle condizioni. Avevo bisogno di cure urgenti e Phurba fece una corsa disperata verso valle, aprendosi il cammino nella coltre di neve che all’andata avevamo sorvolato con il MI-17. Con una serie di peripezie e grazie anche a fortunate coincidenze, si riuscì ad attivare uno dei primissimi elicotteri privati che, a differenza dei militari, accettò di partire da Kathmandu a metà giornata e volare nel pomeriggio, quando il cielo in genere era nuvoloso e perturbato, per trovare la valle in cui ero e il luogo esatto da cui prelevarmi.
Le nuvole avevano tappato quasi tutta la valle e la nebbia aveva già annunciato quella situazione a metà giornata. Non so davvero come fece il pilota ad arrivare fino lassù, ad atterrare vicino alla tenda in cui mi trovavo. Io feci un salto fuori dal sacco a pelo per buttarmi letteralmente nell’elicottero che mi portò in salvo, prima atterrando nel villaggio di Gandrung, dove fece rifornimento di carburante da alcune taniche che aveva depositato all’andata, e poi portandomi fino a Kathmandu.
Il 26 dicembre 1997, il giorno in cui fui soccorso, realizzai molte cose sul ruolo dell’elicottero e dei piloti in alta quota. La prima, e più importante, è che mi avevano salvato la vita.
![]()
2
Cash, please
Il legame con l’Est si era magicamente saldato grazie ad Anatoli Boukreev che mi aveva descritto il mondo sovietico durante le interminabili chiacchierate rintanati nei nostri sacchi a pelo. Nonostante avessi già fatto qualche spedizione con alpinisti cecoslovacchi, fu Anatoli ad aprirmi le porte su una realtà che non conoscevo, quella oltre la Cortina di ferro. Ero stato molto colpito dalla genialità nepalese nel soccorso che mi aveva salvato la pelle nella valle dell’Annapurna, ma nelle mie esperienze avevo anche toccato con mano la bravura dei piloti russi e la potenza dei loro mezzi. Poi la tragedia che aveva strappato dalla mia vita l’amico e fratello più prezioso mi obbligò a continuare idealmente la nostra amicizia. Avrei voluto sentire, imparare e condividere ancora così tante cose con Anatoli. L’unico modo per farlo fu andare nella sua terra, tra la sua gente e le montagne di cui mi aveva parlato e sulle quali era cresciuto e si era formato alpinisticamente.
Nell’estate del 1999 partii per le montagne del Pamir e del Thien Shan, nei territori dell’ex Unione Sovietica da dieci anni diventati gli Stati indipendenti di Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan per il progetto Snow Leopard. Lo Snow Leopard, dal nome del felino che abita quelle valli selvagge, era un riconoscimento che in epoca sovietica veniva attribuito a coloro che nell’arco di una vita avessero realizzato la salita di tutti i cinque settemila dell’ex URSS: Pik Lenin, Pik Kommunism, Pik Korjenevska, Pik Khan Tengri e Pik Pobeda. Ovviamente Anatoli lo aveva fatto più volte, ma l’idea nata con lui era di portare a termine il progetto in un’unica stagione, che voleva dire circa in due mesi.
Ci voleva un’organizzazione perfetta e una macchina operativa efficiente, soprattutto per gli spostamenti da una montagna all’altra e da uno Stato all’altro, considerando che quello non era più un territorio unico, come quando la bandiera sul Cremlino era la stessa per quasi un continente intero. Nella logistica avevamo dovuto pensare all’elicottero, a più di uno in verità, includere jeep, pullman, un aereo di linea, addirittura cavalli. Quella spedizione si rivelò magica, forse la più bella della mia intera carriera alpinistica.
I MI-17 russi, bestioni rumorosi con le scritte in cirillico e i fili elettrici che pendevano da qualche angolo della macchina volante, furono al centro della mia...