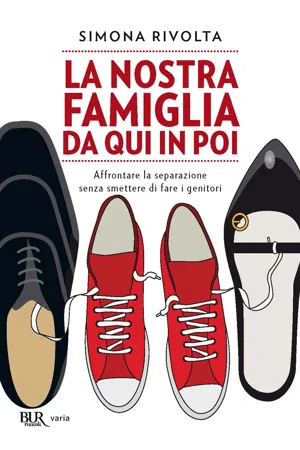![]()
CAPITOLO 1
La separazione dal punto di vista del bambino
«È stato il papà a dirmi che lui e la mamma si stavano lasciando. Mi ha messo seduto sul tavolo della cucina e mi ha detto che andava via. Ho pensato che fosse per sempre, poi ho capito che intendeva solo in un’altra casa. Ero piccolo allora... Certo, mi sono preso un bello spavento.»
(Claudio, 12 anni)
Crescere in una famiglia separata è senza dubbio un’esperienza di vita particolare, non certo rara, ormai, ma comunque differente rispetto a quella che attraversano i figli delle coppie che non si lasciano. Quello che vorrei chiarire sin dall’inizio è che la separazione dei genitori, pur rappresentando una ferita emotiva, non deve per forza di cose tradursi in uno svantaggio incolmabile per i figli.
Si tratta però di avere chiaro che, dopo il momento della rottura, si avvia un processo, si inaugura un diverso modo di essere persone e famiglia, non soltanto per i figli ma per tutti i soggetti coinvolti. Questo presupposto, se condiviso tra una madre e un padre che si lasciano, rappresenta una vera tutela dei figli, perché implica una protezione potente dai rischi a cui i più piccoli sono esposti crescendo nella famiglia separata:
- raggiungere con fatica un equilibrio tra due appartenenze, nessuna delle quali completa;
- sperimentare un senso di sé incompiuto, a causa della necessità di operare una costante valutazione, a volte una censura preliminare di quelle manifestazioni – pensieri, affetti, emozioni – che parlano della propria relazione con il genitore in quel momento assente, se quello presente non lo gradisce;
- dubitare del fatto che la propria nascita sia frutto di un amore e di un legame autentici e preziosi se quella relazione viene presentata come un errore di cui pentirsi, un capitolo fallimentare;
- essere costretti a un incessante monitoraggio degli stati d’animo propri e altrui e alla mediazione costante.
Tutto questo sul lungo periodo – e la crescita richiede un periodo lungo – può produrre un effetto più profondo e insidioso della quantità di divergenze tra i genitori.
E qui occorre sfatare un primo mito: molto a lungo il fattore determinante nel decidere del benessere dei figli dei separati è stato considerato il grado di conflittualità tra gli adulti. A mio avviso, non è questo l’elemento più saliente. Il conflitto può essere assente, per esempio, quando i genitori semplicemente si ignorano e si passano il testimone nella presenza accanto ai figli in un’ordinata staffetta all’insegna dell’indifferenza. Al contrario, ci possono essere divergenze d’opinione che però alimentano scambi produttivi, frutto della condivisione del ruolo interpretato da ciascuno con il proprio stile personale.
Il ruolo attivo dei figli nella separazione
C’è invece un aspetto poco considerato quando si discute di ciò che accade ai figli nella separazione dei genitori. L’atteggiamento più frequente prevede che i protagonisti della vicenda siano individuati da tutti nella coppia che mette fine al matrimonio. Madre e padre, con i loro sentimenti e risentimenti, occupano la scena, e dei figli si parla moltissimo ma in qualche modo come di coloro destinati a subire le ripercussioni delle decisioni degli adulti.
Si cerca di immaginare quali potranno essere gli eventuali danni per la crescita del bambino, le conseguenze cui far fronte dopo il cambiamento, oppure in che modo muteranno i rapporti tra ciascun genitore e il figlio. Ci si interroga e si cercano indicazioni su come lenire un dolore di cui si intuisce la portata profonda.
Più raramente ci si cala davvero nei panni dei figli e ci si chiede quali potranno essere le iniziative, concrete e affettive, che ognuno di loro sentirà di voler intraprendere nel fare fronte alla trasformazione che gli si prospetta.
Quando un bambino assume i panni del mediatore o del portavoce, quando dipinge un genitore con certe tinte, oppure lo attacca, o lo blandisce, quando sembra dimenticarlo o al contrario non poterne fare a meno, la tendenza è quella di attribuire all’altro genitore gesti e parole che fanno pensare a una missione assegnata al figlio.
A volte, è innegabile, l’istigazione è smaccata e i bambini sono palesemente il braccio governato da una mente adulta. In generale, tuttavia, i figli agiscono in autonomia: a muoverli sono emozioni e sentimenti del tutto genuini e spontanei, attraverso i quali manifestano il proprio personale tentativo di giocare un ruolo attivo, di fare e non subire, di far sentire la propria voce e il proprio desiderio. Questo avviene in modi diversi a seconda dell’età e delle competenze di ogni figlio.
Senta dottoressa, lei dice che io banalizzo e la faccio troppo facile, e forse ha ragione. Però cerco di essere ottimista, e invece mio marito fa il contrario, e anche questo non fa bene a Davide. Da qualche settimana, quando torna a casa dopo il weekend con il padre, mi dice che il papà è triste, che è solo, e se non possiamo farlo tornare a casa così magari ritorna contento. Si rende conto? Andrea sostiene che lui non ha mai detto niente del genere al bambino, ma ammesso che sia vero io lui lo conosco bene, non faccio fatica a immaginarmelo, mette su quell’aria da cane bastonato che per forza anche un bambino di quattro anni capisce che cosa vuole dire. Le sembra giusto? Non dovrebbe evitare certi comportamenti?
Elena e Andrea sono separati da qualche mese e nelle parole della donna non c’è traccia di dubbio: Andrea si serve di Davide per far arrivare a lei un messaggio. L’idea che quel messaggio contenga una preoccupazione e un desiderio dello stesso Davide non è presa in considerazione, e trova scarsa accoglienza.
A quattro anni, invece, Davide intuisce che la fragilità e la sofferenza del padre non sono solo affare del padre. Il suo bisogno di contenimento e sicurezza trova una risposta di qualità diversa da quando i genitori sono impegnati nella separazione; gli è facile identificarsi nella tristezza di Andrea, nel suo disorientamento, che somigliano parecchio ai propri.
Quando chiede alla madre di far tornare a casa il papà, il bambino riconosce in lei l’interlocutore meno segnato dalle vicende emotive della rottura, quello con più potere, ed è a lei, di conseguenza, che chiede di ripristinare la situazione precedente, che sente più protettiva e tutelante. Perché questo avvenga non c’è alcun bisogno che Andrea parli con il figlio, né chiaramente né velatamente.
È Davide ad avere esigenze precise e a manifestarle.
Il problema, quindi, non è certo la mancanza di interesse e attenzione da parte degli adulti, semmai è l’oggetto sul quale si concentrano a dover essere chiarito. La sensazione è che il bambino immaginato non coincida con quello reale: gli scenari post-separazione che i genitori hanno in mente ruotano spesso intorno a un profilo del figlio che ha contorni poco corrispondenti a ciò che sappiamo di bambini e ragazzi, di come «funzionano», di quello che ci si può aspettare ragionevolmente da loro.
In particolare nei passaggi complicati che la fine di un matrimonio implica, si oscilla tra due ritratti del bambino, solo faticosamente sovrapponibili: da un lato lo si raffigura come individuo prezioso e insieme fragilissimo, da custodire e proteggere; dall’altro ci si compiace nel tratteggiare la sagoma di un piccolo adulto dotato di risorse e competenze emotive straordinarie, tanto da immaginarlo capace di fornire comprensione, appoggio, incoraggiamento.
La tendenza a leggere i bambini principalmente in termini adulti, proprio dal punto di vista dei grandi, si manifesta in modo eclatante nelle separazioni più conflittuali.
Per spiegarmi meglio, utilizzerò una storia insolita, in cui il figlio, uno dei figli di una coppia, compiuti nove anni chiede al padre di andare a vivere con lui, dopo aver trascorso con la madre i primi cinque anni dal momento della separazione.
Le ricostruzioni di Filippo e Federica, gli ex coniugi, concordano unicamente sulla cronologia degli eventi. Racconta Federica:
Filippo se ne è andato quando Emilio aveva tre anni e mezzo, subito dopo la nascita di Chiara. Io ho sempre cercato di fare in modo che i bambini non perdessero il rapporto con lui, veniva a casa quando voleva, restava a cena, uscivamo spesso insieme, insomma le cose non andavano male, pur essendo noi separati. Improvvisamente, dopo cinque anni, una domenica prima di riportare Emilio a casa Filippo mi ha telefonato dicendomi che aveva bisogno di parlarmi, e che quindi sarebbe stato meglio che venissi io a prendere il bambino. Quando sono arrivata, insieme mi hanno comunicato che Emilio aveva deciso di restare con il padre, che non voleva tornare a casa con me. Io non capivo, però gli ho detto che per me andava bene se era contento lui, di pensarci e che ne avremmo riparlato. Da allora mio figlio non è più tornato a vivere con me. Chissà da quanto tempo Filippo me lo metteva contro, chissà cosa gli avrà detto per condizionarlo così. Non ci credo che è stato lui a volerlo, un bambino da solo non rifiuta sua madre così, senza motivo.
Secondo Filippo di motivi ce n’erano eccome:
Quando ci siamo separati Federica ha subito chiarito che non mi avrebbe reso la vita facile. Era furiosa, diceva che l’avevo abbandonata con due bambini piccoli e da allora ha tenuto a recitare la parte della vittima. Emilio ha iniziato a chiedermi di tenerlo con me molto tempo prima del trasferimento vero e proprio, si lamentava perché Federica sembrava preferire la sorella e non occuparsi di lui; Chiara è nata con un problema di metabolismo, è sempre stata fragile e credo che inizialmente la mia ex moglie si sia concentrata molto su di lei per questa ragione. Per almeno un paio di anni ho cercato di farlo ragionare, di spiegargli perché la madre si comportava in un certo modo. Quando ne ho parlato con Federica è stato perché non mi è più sembrato giusto costringerlo e vederlo stare male. Lei in tutto quel tempo non si era accorta di niente. Quando poi Emilio è rimasto da me, sua madre non solo gli ha detto che per lei non c’erano problemi, è praticamente scomparsa per più di un mese. Non lo chiamava, non voleva vederlo, sparita. E con lei anche mia figlia. E poi ci si stupisce se a Emilio di sua madre non importa? Se non gli interessa stare con lei?
Conosco Emilio quando ha tredici anni, e il suo atteggiamento verso la madre mi preoccupa molto. A impressionarmi, oltre all’assenza di ricordi, è l’indifferenza con cui ne parla, l’assenza di passione; non sembra triste e nemmeno arrabbiato, non è rivendicativo né ha propositi di rivalsa. Di Federica parla come di una persona del passato, che associa a un periodo ormai concluso e che non vale la pena riesaminare. Quando gli chiedo che cosa sa della ragione per cui si trova lì a chiacchierare con me mi risponde: «L’assistente sociale dice che non va bene che io non voglia vedere mia madre, che dobbiamo recuperare il rapporto. Ma non è vero che non la voglio vedere, se mi dicono che ci devo andare io ci vado, l’ho vista anche l’altro giorno. Però se dipendesse da me non lo farei, non mi interessa. A proposito, quand’è che inizia a dipendere da me? Mi hanno detto che fino a diciotto anni decidono loro».
Emilio è un ragazzo di grande intelligenza e senso dell’umorismo, grazie ai quali argina in modo impeccabile anche le emozioni più potenti. Per lui questo carattere è una risorsa, ma anche un rischio. Accedere al mondo interno implica l’aggiramento di un dispositivo di protezione molto elaborato ed efficace, che se nel tempo è servito a sostenerlo in una crescita all’insegna dell’adattamento minaccia adesso di ostacolarlo nell’acquisire competenze affettive più elaborate, che prevedono di entrare in contatto con gli stati d’animo prodotti dall’esperienza e imparare a maneggiarli.
Ci vorranno quasi due anni prima che Emilio riesca a raccontare la sua storia, a farne una cronaca un poco meno stringata e superficiale, a dichiarare quali sono i rimproveri che muove alla madre e a riconoscere di averne avuto bisogno, quantomeno in passato. Senza entrare nel dettaglio della relazione tra madre e figlio, è possibile leggere nelle richieste di Emilio bambino l’espressione di bisogni precisi, prima di tutto suoi.
Mettersi nei panni del bambino
Gli adulti nella cultura postmoderna sono insomma portatori di una grande contraddizione: da un lato affermano a gran voce la priorità accordata al benessere dei figli; nelle piccole scelte quotidiane tendono a soddisfare desideri e richieste in nome del «dare dignità al bambino come persona», non prevaricare, lasciare esprimere. Un atteggiamento che prescinde dalla riflessione sugli effetti futuri di una scarsa pratica della frustrazione. Effetti non tutti positivi, che iniziamo a vedere nelle manifestazioni di fragilità di bambini e ragazzi e sui quali da qualche anno si sta cominciando a riflettere.
D’altro canto, quando invece si tratta di questioni decisive non soltanto per ciò che comporteranno in futuro ma per la qualità della vita presente, come è nelle separazioni, ci si scorda della dignità del bambino, dei suoi gusti e delle sue preferenze, si tende ad agire a suo nome e in sua vece, praticamente annullandone il diritto a essere persona separata e portatrice di istanze proprie, spesso non coincidenti con quelle degli adulti. I genitori diventano insomma incapaci di praticare proprio ciò cui intendono dare il primo posto: la capacità di mettersi nei loro panni, di vederli in un modo che tenga conto di chi sono veramente: persone che hanno una vita già in corso, con desideri, bisogni, pensieri che a quella vita – e non a ciò che sarà in futuro – si riferiscono.
Questa pecca caratterizza da sempre i rapporti tra adulti e bambini, non più ignorati ma marginalizzati. È purtroppo, mi pare, uno dei molti segnali di un cambiamento importante, graduale, inarrestabile e piuttosto rapido nella struttura del soggetto contemporaneo. È ciò che la sociologia definisce il dominio della soggettività, e in cui la psicologia rintraccia un’impressionante somiglianza con le caratteristiche del funzionamento della mente adolescente: aspetti di impulsività, onnipotenza e scarsa tolleranza alle frustrazioni sono infatti il pane quotidiano dell’adolescenza, da sempre. La stagione delle tempeste emotive, tuttavia, tende oggi a prolungarsi ben oltre il raggiungimento dell’età adulta anagrafica. E i nuovi valori ispirano la dottrina psicopedagogica, producendo modalità educative particolari, di cui iniziamo a vedere gli effetti.
Sebbene di questa incongruenza di rado i genitori che incontro sono coscienti, si dimostrano però frequentemente disposti a discuterne. Le madri e i padri con cui faccio conoscenza quando la coppia è in crisi e va verso la dissoluzione, così come quelli che già da tempo hanno organizzato un equilibrio post-matrimoniale e lo vedono vacillare, sono invariabilmente preoccupati in modo sincero; chiedono aiuto e indicazioni su come gestire il cambiamento o la situazione critica e appaiono disponibili a mettere in discussione le proprie convinzioni.
Avere in mente una netta distinzione tra lo spazio dei grandi e quello dei piccoli, recuperare il senso dei ruoli, delle gerarchie che strutturano la famiglia e dunque delle differenze – più che delle affinità, fin troppo sottolineate nella cultura dell’infanzia attuale – è forse il requisito preliminare, che fa da presupposto a tutti gli altri, se si desidera rendere gestibile ai figli il dolore per la separazione dei genitori. Questo si traduce nell’assunzione in prima persona della responsabilità della propria scelta, che è una scelta consapevole e produce una serie di effetti che consentono ai figli di non sostituirsi agli adulti.
Nei capitoli che seguono farò luce su una serie di aspetti in generale poco considerati dai genitori che si rivolgono a me per una consulenza:
- la famiglia non finisce con la separazione: si trasforma. E a separarsi non è solo la coppia ma tutta la famiglia; i soggetti coinvolti non sono pertanto due, ma tutti i componenti del nucleo familiare in modo diretto e, più indirettamente ma concretamente, anche i membri della famiglia allargata;
- la fine della relazione coniugale tra i genitori, anche la meno conflittuale, è un fatto traumatico e doloroso, analogo a un lutto, che richiede un’elaborazione; perché questa possa avere luogo, i sentimenti che derivano dal cambiamento devono poter essere espressi, in particolare dai figli, e i genitori hanno il difficile compito di accettarne la manifestazi...