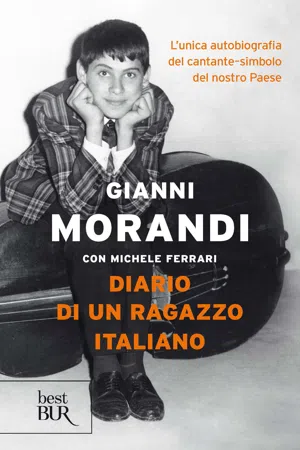![]()
1
Avevo un diario, nascosto in casa da qualche parte. Sentivo il bisogno di scrivere, di registrare alcuni passi importanti della mia giornata, facevo delle piccole operazioni per non sbagliare a fare i conti, indicavo sempre con un più o un meno la qualità della giornata. Avevo una regola calibrata al millesimo: non potevo tardare più di cinque minuti sull’orario di rientro stabilito da mio padre. Ogni cinque minuti di ritardo, dovevo saltare un pomeriggio di libera uscita. Sul diario registravo anche queste piccole penalità e il metodo per sanarle.
Ancora oggi tengo un diario. La sera, prima di spegnere la luce e addormentarmi, mi infilo gli occhiali e scrivo. Perché un diario non è una cosa da adolescenti o femminucce. È per me un riferimento quotidiano, che mi aiuta a mantenere la memoria fervida e allenata; quasi sempre, quando lo rileggo, restituisce momenti della mia vita capaci ancora di sorprendermi. Come quelli che sto per raccontare.
![]()
2
Mi trovo al Teatro Ponchielli di Cremona. È il tardo pomeriggio di una domenica e me ne sto seduto in una poltrona del palco numero 11, intento a meditare sulla scaletta del concerto che terrò tra poche ore. Dopo le prove mi piace isolarmi, prendermi un momento tutto per me, evitare le domande o gli incontri obbligatori con i notabili locali. Ho bisogno di allontanarmi e ispirarmi davanti al foglio bianco del mio diario per comporre la successione delle canzoni che voglio cantare. La scaletta viene definita solo dopo questo mio ritiro. Del resto, volete che uno come me, alla mia età, non abbia una qualche mania, una consolidata, irrinunciabile consuetudine? Da sempre scrivo la scaletta prima sul diario, per «storicizzare» la mia scelta, e poi la comunico al gruppo, ai musicisti, ai tecnici delle luci, al fonico. Da questa scaletta scritta a mano viene tratto un documento semiufficiale, una fotocopia scritta a pennarello che si attacca nei punti strategici delle quinte, come fosse il vangelo di quella sera. Ma non è il vangelo.
Al termine del concerto, quando tutto è finito e rientro in camerino, prima di cambiarmi riapro il diario e annoto la reale successione delle canzoni, nell’ordine in cui le ho cantate: le due liste non coincidono quasi mai. Ecco allora che mi metto a fare medie, stilare statistiche, applicare formule: il risultato è un «coefficiente di confronto», un dato che mi diverto a fissare per vedere quanto sono stato stimolato a rivoluzionare la mia prima scelta. A seconda di quale canzone cambio o inverto, aumento o diminuisco il coefficiente. Se cambio meno del 5 per cento rispetto alla decisione del pomeriggio, il concerto è stato mediocre perché vuol dire che ho improvvisato poco; se cambio oltre il 50 per cento significa che è stata una serata difficile, con un pubblico troppo eterogeneo o distratto (caso raro che capita d’estate in certe piazze di paese). Significa che ho dovuto rivoluzionare troppo per tenere alto il ritmo dello spettacolo. Se invece le variazioni si attestano intorno al 30 per cento, allora vuol dire che ci siamo, che il concerto è andato bene. Così, anche dopo anni, per capire com’è andata una determinata sera mi basta leggere il coefficiente di confronto che ho annotato sotto la data del concerto.
La scaletta rappresenta per un cantante ciò che la punteggiatura rappresenta per uno scrittore. È il vero spartito, la dose di emozioni che devo trasferire a chi mi sta di fronte. Ho imparato con l’esperienza che il pubblico, il singolo spettatore, il fan, si immedesima nel mio trasporto, mi segue nel vortice della mia interpretazione, si lascia convincere dalla sincerità della lirica e dell’esecuzione come se quella manciata di minuti spesi nella canzone fosse un modo per raccontare un frammento della nostra vita reale, vissuta senza risparmiarsi, proprio così come io la canto. Allora va bene il sudore che bagna il petto sotto la camicia e corre lungo la schiena, va bene la boccata d’aria attesa come vitale dopo l’apnea dell’acuto, vanno bene le smorfie di fatica, le braccia aperte che accolgono l’applauso come unica benzina per il mio motore. Lo spettatore sa leggere la differenza tra passione e mestiere e per me, nel bilancio finale, deve sempre prevalere di gran lunga la passione. Mentre canto il mio unico termometro è il pubblico, il lievitare del gradimento, la dose di bianco che mi restituiscono i sorrisi della gente, l’anticipo dell’applauso, o meglio la percezione dell’applauso imminente. Ormai questo momento lo avverto fisicamente, e so darne una stima esatta che difficilmente mi tradisce. Quando tutto va bene l’entusiasmo della gente galoppa, muovendosi come una discreta ma robusta onda sonora che per me risulta più udibile della musica stessa. Allora può capitare, e spesso capita, che per via di quell’entusiasmo mi venga naturale cambiare, improvvisare un’altra sequenza o cantare una canzone che magari non avevo nemmeno provato.
La prima ipotesi di scaletta nasce dopo il sound check, vale a dire il controllo del suono. A parte alcuni pilastri inamovibili, la scaletta nasce anche osservando e analizzando i posti a sedere, il punto di vista del pubblico. Ecco dunque questo teatro semibuio, dormiente, in attesa di animarsi e di svolgere il suo lavoro di generatore di applausi. Com’è l’architettura? Come si vede da qui, da questa loggia? Sono comode le sedute? Si è liberi di sbracciarsi senza sgomitare il vicino? Quanta gente ci sta qui dentro? Che distanza c’è tra il palco e la prima fila? Ogni piazza ha la sua storia, la sua natura, il suo senso. Quanti, prima di me, hanno accettato il giudizio e misurato il consenso da quello stesso palco?
Comincio a scrivere: Un mondo d’amore, alla fine del «prato verde» bisogna salutare, comunicare il privilegio di potersi esibire per un pubblico così speciale come quello di Cremona… Poi Bella signora, Vita, e già a questo punto posso verificare una prima reazione, capire chi ho di fronte; poi mettiamo Se perdo anche te, Solo chi si ama veramente, e qui deve arrivare un grande scrosciare di applausi; così poi, con il groove della batteria che annuncia il pezzo successivo, se mi riesce, dissolvo l’applauso in un battito a tempo a sostegno di Banane e lampone; poi, già che sono sul movimentato, ci aggiungo pure Corre più di noi, che finisce con lo stop, con il freeze, cioè l’effetto congelamento mio e di tutta la band. Una pausa naturale, scenografica. Poi racconterò qualche aneddoto sulla mia passione per lo sport, la maratona, l’attività fisica… e ripartirò con la suite anni Sessanta: Andavo a cento all’ora, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Se vuoi uscire una domenica sola con me, C’era un ragazzo… C’era un ragazzo…? Mi fermo a fissare questo titolo. Una figura concreta e palpabile prende vita dalla carta e si alza in piedi sopra il foglio. Salta sulla balaustra, sul cordolo di velluto rosso con passamaneria dorata che delimita questo palchetto pieno di storia. Ma ora questa balaustra non è più una protezione per non cadere giù in mezzo alla platea, è il ciglio di un pendio sotto il quale si apre un’intera valle. È una sorta di irrequieto Peter Pan in calzoncini corti di vigogna grigia, si muove come un forsennato, mi sorride e mi ipnotizza. Sono io che mi rido in faccia e che salto lì sopra restando in bilico. Questa visione mi travolge. Entro nel suo significato e riesco persino a sentire il profumo dell’aria aperta, del bosco, della corteccia di quercia. C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones… È una musica, un suono, un concetto. Il frullo di questa coscienza esagitata mi fa pensare così, in questo modo tanto vero e presente. C’era un ragazzo che come me… Ma sì, è vero, c’era un bambino, e poi un uomo. Ma un ragazzo? C’è stato davvero quel ragazzo lì?
![]()
3
Si faceva sempre quello che diceva mio padre. Lui era uno tosto, un montanaro passato attraverso la guerra e tornato a Monghidoro con i suoi modelli e le sue idee rivoluzionarie: il comunismo, il rigore, il lavoro indefesso. Nonna Maria, sua madre, voleva che crescessi con un’educazione cattolica. Lui no. Niente catechismo, niente parrocchia, niente preghiere! Così, visto che non si osava mancare di rispetto agli anziani, papà Renato faceva sparire la dottrina che la nonna mi portava tutti i giovedì di ritorno dal mercato. La comprava in chiesa dal sacrestano e ogni settimana, per molti anni, rimase tra madre e figlio questo tacito accordo: la dottrina misteriosamente spariva e altrettanto misteriosamente ritornava.
La bottega da calzolaio di mio padre era la nostra cucina di casa, che all’occorrenza diventava anche sala da pranzo o luogo di riunione tra ospiti e parenti. La mattina, prima di cominciare il mio lavoro di aiuto ciabattino, mio padre mi obbligava a leggere ad alta voce, appoggiandomi al desco del mastice, alcune pagine del Capitale di Karl Marx, di cui né io né forse lui comprendevamo a fondo il significato. Ma erano proprio il mio mugugnare e la mia totale mancanza di interesse a costituire per lui una rassicurante forma di devozione, allineata alla sua coscienza di buon attivista. Oltre al Capitale dovevo leggere cinque metri del quotidiano «l’Unità». Cinque metri era la misura giusta stabilita dal suo senso del dovere politico ideale, prima di iniziare una giornata di lavoro. La sera del giovedì la nonna mi passava il catechismo da sotto il tavolo e così crescevo alimentato dall’incrocio surreale di questi due fuochi.
Secondo mia madre avrei dovuto chiamarmi Gian Luigi, nonna Maria invece insisteva per Andrea. Un soldato americano passò una coperta a mia madre Clara e a sua mamma, la nonna Sestilia, quando durante una bufera di neve, alle sette e mezza di mattina dell’11 dicembre 1944, mi fecero nascere quasi sotto il cielo aperto della casa in cui abitavamo a Monghidoro. Il tetto era semisfondato dai bombardamenti e riparato alla bell’e meglio con teloni di fortuna. «Little John, little John» esclamava l’americano che non riusciva a pronunciare il nome Gianni. Tornò più volte a trovarci e mia madre Clara si ricorda che cantava un motivetto: «Welcome, welcome little John in the smiling world. Come, come little John to see a new sunshine…». Le strofe di quella canzoncina furono per mia madre rime di buon auspicio e ancora oggi sono trascritte sul mio diario.
In famiglia cantavano tutti, ogni occasione era buona per intonare una canzonetta con impegno e con la giusta modulazione. In noi montanari erano innate la cura per l’espressione e l’attenzione a un’esecuzione dolce e virtuosa, anche se non si cantava certo per esibirsi ma solo per farsi compagnia. Cantava mio padre mentre rifiniva i tacchi, cantava mia madre con le mani impiastricciate dell’impasto della sfoglia. Io mi misuravo con zia Ernestina mentre andavo a raccogliere la legna per il fuoco o facevo pascolare l’unica mucca di famiglia. Durante il tragitto nel bosco cantavamo per ore. Poi vennero le Feste dell’Unità, dove fui invitato a salire sul palco per esibirmi. La maestra Alda Scaglioni di Bologna mi notò e disse di voler provare a educarmi alla musica. Era il periodo dei bambini prodigio e mio padre diede il suo consenso, purché il mio impegno nella bottega non fosse messo in discussione. Prendevo lezioni a casa della maestra, che mi insegnava tutto sul canto e mi faceva esercitare per ore. Durante il fine settimana mi faceva esibire con una piccola orchestra. Guadagnavo 1000 lire la domenica pomeriggio e 1000 la sera. Registravo sulla pagina del diario l’incasso di quelle esibizioni sotto la voce: «Soldi guadagnati per aver cantato». Poi tornavo a Monghidoro, mio padre mi requisiva le 2000 lire e mi rimettevo a lavorare nella bottega-cucina-tinello-salotto, fino al venerdì, quando riprendevo la corriera per Bologna e tornavo dalla maestra Scaglioni. Non avevo mai una lira, si metteva da parte tutto «perché non si sa mai… e tu sei ancora piccolo per avere soldi in tasca».
A mezzogiorno e un quarto finivo il turno di lavoro del mattino e avevo circa un’ora e mezza di pausa, durante la quale lo schema di mio padre prevedeva che mangiassi e avessi poi un’ora d’aria per giocare con gli amici nel campo sportivo parrocchiale. Le regole erano molte e inderogabili. Qualche volta si poteva sperare in un cof, vale a dire in un ghiacciolo, ma costava 15 lire e dovevo comunque averlo meritato. Mio padre aveva sempre con sé, nella tasca del paltò, una consistente quantità di spiccioli, ricavati dalla vendita dell’«Unità» di cui era «diffusore» in paese. Un giorno, da vero incosciente, prelevai i soldi da quella tasca per comprarmi il cof, proprio nel momento in cui mio padre rientrava a casa e non c’era più tempo per sparire, visto che era ormai l’ora della lettura. Così, mentre leggevo i sei, sette metri dell’«Unità» (aggiungevo sempre due metri per scontare le penalità dovute ad alcuni ritardi), involontariamente feci tintinnare le tre monete da 5 lire che mi erano rimaste in mano. Quella volta la punizione non fu la perdita di altre ore di svago, ma l’umiliazione. Non mi rivolse la parola per tutta la giornata e io soffrivo di più che se me le avesse date con la cinghia. All’ora di cena, davanti a mia madre, mi costrinse a dichiararmi ladro e a raccontare il furto. Fu la peggiore delle pene.
Mio padre Renato morì improvvisamente a Caracas il 19 agosto 1971, stroncato da un infarto. Era la prima volta che viaggiava oltre oceano ed era con me per un concerto. Si stava trasferendo a New York, convinto da Adriano Aragozzini a visitare quella che per lui era la città del capitalismo e della perdizione. Incredibile che uno stalinista come lui fosse sul punto di visitare New York prima di Mosca. Era eccitato per il mio concerto, teso oltre ogni misura per questo viaggio non previsto e fuori standard. Forse fu proprio l’emozione a investirlo così violentemente da risultargli fatale.
Nel rispetto delle sue volontà, fu sepolto al cimitero della Certosa di Bologna, ma sulla tomba non venne apposta nessuna croce, così come aveva sempre espressamente richiesto. Mia madre volle rispettare questa sua scelta, ma alcuni giorni dopo comparve sulla lapide una croce di bronzo perfettamente conforme alle scritte. Allibita per lo strano fenomeno, mia madre fece rimuovere la croce. Ma questa riapparì. La misteriosa apparizione della croce sulla tomba di mio padre si ripeté diverse volte. Fino alla morte di nonna Maria.
![]()
20 novembre 1956 (prima pagina del diario)
Io non so veramente come posso essere ma comunque credo di essere quasi quasi così: prima di tutto vorrei descrivere i miei difetti.
A me piacerebbe essere un bambino educato, sincero, leale e amico con tutti, ma purtroppo non sono così.
Quando vado in casa di qualche persona è solo per puro caso che io dica il «buon giorno» o la «buona sera» o «arrivederci». Non sono tanto sincero, qualche volta poi commetto anche delle birichinate: rompo un vetro, tiro un sasso a un amico. L’altro giorno vidi per la prima volta un morto. Mi si gelò il sangue e provai molto ribrezzo. Se potessi non guarderei mai più un morto.
Designerò ora alcune mie qualità.
Lavoro ora da calzolaio aiutando mio padre e mi piace molto di fare lo spago, piantare bullette e chiodi sulle scarpe. Io credo di essere pessimista, cioè vedo le cose sempre al male. Rispetto i vecchi e non pronuncio parole irrisorie contro un mutilato perché ha le stampelle. Provo dolore nel vedere un amico piangere.
Questo credo sia il mio ritratto seppure descritto in modo non molto chiaro.
![]()
4
Scrivevo il diario con la penna Bic a punta fine. Mi ero imposto la regola che l’inchiostro dovesse essere sempre blu. La penna era quella dalla cannuccia gialla a sezione ottagonale, con il tappo che finiva con una specie di chiodo allungato. Spesso, dopo aver tolto i tappi e sfilato il refil, la cannuccia diventava una preziosa cerbottana con cui «sparare» sul «coppino» delle compagne di classe. I micidiali proiettili erano costituiti dalla carta strappata dagli angoli del quaderno e succhiata fino a ridurla in minuscole pallottole.
All’età di tredici anni cominciai a fare le prime serate. Il diario doveva venire con me e quindi anche la biro blu, poi mi portavo sempre un mazzo di carte da gioco. Inoltre mia madre mi preparava qualche panino per il viaggio e avevo naturalmente lo spazzolino da denti e un paio di mutande pulite, insieme a un paio di calzoni corti che mamma mi adattava riconfezionando quelli che acquistava all’America Stracci, deposito nel quale si stoccavano grosse balle di vecchi vestiti americani. Portavo anche qualche spicciolo che tenevo dentro un borsellino artigianale, ricavato dalla tomaia in pelle di un paio di décolleté che una ricca signora si era dimenticata di venire a ritirare.
Ogni volta che me ne andavo da Monghidoro, quindi, portavo con me un vero e proprio bagaglio. Del resto, in casa di valige non ce n’erano: non era previsto che nessuno andasse tanto lontano da giustificare la presenza di un tale accessorio da viaggio. Fu così quindi che nacque la «mappatella», una sacca di tela color crema di cotone grezzo, con due lunghi manici, che nonna Maria realizzò con le sue mani allo scopo principale di introdurre tra i miei effetti personali anche la dottrina. Nel tempo la mappatella ha subìto diverse trasformazioni, specie per il contenuto, ma quasi mai nella foggia. È sempre la stessa tracolla informe e sbiadita, che forse, per un cantante di successo, non è proprio il miglior accessorio da mostrare. E pensare che è il più prezioso che ho. Senza la mappatella non farei un passo. Posso sopravvivere senza mangiare o senza una camera d’albergo decente, ma non senza la mappatella. Ancora oggi la utilizzo per tenervi di tutto: il diario, una penna a inchiostro blu, il portafoglio, le chiavi di casa e della macchina, una confezione di estratto di limone, un tubetto di olio essenziale, un pennarello nero per gli autografi, l’orologio buono che durante i concerti mi tolgo, il cronometro per la corsa, il caricabatteria del cellulare, due aspirine, un cappello per «camuffarmi» quando non posso affrontare gli assalti della folla, alcuni flaconcini di integratori di ferro, la rubrica telefonica (quella digitale si smagnetizza e così riporto su carta gli stessi numeri salvati sul telefonino), una confezione di caramelle alla menta, qualche copia del mio ultimo cd e ultimamente un paio di occhiali da vista…
![]()
5
La mia canzone preferita arrivò fulminea come un inno, definitiva come una bandiera. Squadernando le pagine del diario rileggo ciò che scrissi, a caratteri cubitali, il 18 aprile 1966: C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Che botta! Oggi Franco mi ha portato una canzone fortissima che mi ha sconvolto! È vero, non avevo mai provato una sensazione così!
In quegli anni Gianni Morandi non era solo il mio nome: era diventato anche il «marchio» di un’azienda per la quale lavoravano diverse persone. C’era il discografico con tutto il suo ufficio e soprattutto c’era il produttore e paroliere: Franco Migliacci. Era sempre vicino a me e al centro di ogni decisione. Grazie al nostro affiatamento, si era consolidato il sound morandiano, fatto di melodie e liriche capaci di suscitare una cascata di emozioni di sicuro impatto. Un sound da post-boom economico capace di proiettare fuori dal mangiadischi un’immagine ben confezionata fatta di cieli sereni e baci appassionati. Quando mi proponevano un pezzo che ritenevano adatto a me, io lo ascoltavo un po’ di volte e ci mettevo dentro Gianni Morandi, poi lo eseguivo ed ecco che usciva ciò che tutti si aspettavano di ascoltare. Anche se a volte non ero poi così convinto, lavoravo con persone di cui mi fidavo e che sapevano bene quali dovevano essere le mie canzoni. Avevano quasi sempre ragione. Quasi ogni brano diventava un successo e tutto questo mi gratificava.
Ma con C’era un rag...