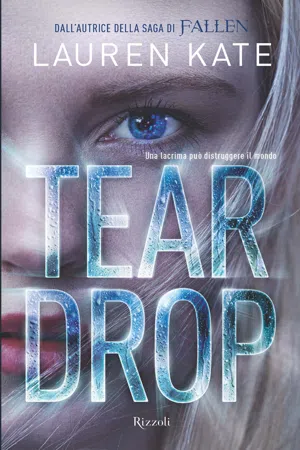![]()
1
EUREKA
Nella quiete della piccola sala d’aspetto color crema, l’orecchio lesionato di Eureka fischiava. Se lo massaggiò distratta, un gesto automatico che ripeteva dal giorno dell’incidente che l’aveva resa mezza sorda. Non servì a niente. In fondo alla sala vide girare la maniglia di una porta. Una donna con una morbida camicetta bianca su una gonna verde oliva, e i capelli biondi raccolti in un elegante chignon, comparve sulla soglia illuminata dalla luce artificiale.
«Eureka?» La voce bassa della dottoressa risuonò appena sopra il gorgoglio dell’acquario, una vasca che pareva avere un solo abitante: un sub di plastica immerso nella ghiaia fino alle ginocchia.
Eureka si guardò intorno come in cerca di un’invisibile Eureka che potesse prendere il suo posto per tutta l’ora successiva.
«Sono la dottoressa Landry. Prego, accomodati.»
Da quando suo padre si era risposato, quattro anni prima, Eureka aveva affrontato un esercito di analisti. Una vita governata da tre adulti che non andavano d’accordo su niente si era dimostrata molto più difficile di una governata da due soltanto. Il papà aveva diffidato del primo analista della vecchia scuola freudiana almeno quanto la mamma aveva detestato il secondo psichiatra dalle palpebre pesanti che le dispensava tranquillanti come caramelle. A quel punto si era intromessa Rhoda, la nuova moglie del padre, e aveva proposto prima lo sportello psicopedagogico della scuola, poi l’agopuntura, poi la terapia per il controllo della rabbia. Alla fine Eureka si era impuntata con il terapeuta familiare, un uomo dall’aria saccente che aveva fatto sentire suo padre quanto mai lontano dall’idea di famiglia. Per certi versi Eureka aveva apprezzato l’ultimo strizzacervelli, che aveva caldeggiato un lontano collegio in Svizzera, ma quando sua madre era venuta a saperlo aveva minacciato di trascinare l’ex marito in tribunale.
Lo sguardo di Eureka fu attratto dalle ballerine di pelle chiara della sua nuova terapeuta. Si era seduta su tanti divani davanti a innumerevoli calzature di quel tipo. Le strizzacervelli donne adottavano sempre lo stesso trucchetto delle scarpe basse: comode da sfilare all’inizio dell’incontro, e altrettanto facili da rimettere quando era il momento di chiudere la seduta. Dovevano aver letto tutte lo stesso stupido articolo su quanto il Metodo Scarpe fosse più garbato nei riguardi del paziente che non dire semplicemente che il tempo era scaduto.
L’arredamento dello studio era pensato per creare un’atmosfera serena: un lungo divano di pelle marrone contro la parete, appena sotto la finestra chiusa, due poltrone rivestite di tessuto davanti a un tavolinetto basso con sopra una ciotola di bonbon al caffè dall’involucro dorato, un tappeto decorato con impronte di piedi colorate. Un profumatore di ambienti spandeva nella stanza una fragranza di cannella che a Eureka non dispiaceva.
La dottoressa Landry sedette in una delle poltrone. Eureka lasciò cadere lo zaino sul pavimento con un tonfo sonoro (i libri di testo dei corsi avanzati pesavano un accidenti) e si sdraiò sul divano.
«Bel posto» disse. «Dovrebbe metterci uno di quei pendoli con le sferette d’argento. Il mio ultimo terapeuta ne aveva uno. E magari un distributore d’acqua con i rubinetti caldo e freddo.»
«Se vuoi un bicchiere d’acqua, c’è un brocca accanto al lavandino. Posso…»
«Non importa.» Eureka si era già lasciata sfuggire più parole di quante avesse avuto intenzione di dire per tutta l’ora. Era nervosa. Inspirò a fondo e innalzò di nuovo le sue barriere. Rammentò a se stessa che era una stoica.
La dottoressa Landry si sfilò una ballerina, poi usò la punta del piede per togliersi l’altra; attraverso le calze velate si intravedeva lo smalto marrone rossiccio. La donna piegò le ginocchia per infilarsi i piedi sotto le cosce e poggiò il mento su un palmo. «Allora, cosa ti ha portata qui oggi?»
Quando Eureka si sentiva intrappolata in una situazione sgradevole, la sua mente evocava immagini assurde, che lei lasciava correre a briglia sciolta. Si figurò una parata motociclistica che sfilava in una pioggia di coriandoli colorati attraverso il centro di New Iberia per scortarla in gran stile verso la seduta di terapia.
Ma la dottoressa sembrava un tipo razionale, interessata alla realtà da cui Eureka desiderava evadere. Era stata la sua Jeep rossa a portarla lì. Le diciassette miglia di strada fra la scuola e lo studio l’avevano portata lì… e ogni secondo che scivolava verso un altro minuto significava tempo sottratto agli allenamenti per il raduno di corsa campestre di quel pomeriggio. La sfiga l’aveva portata lì.
O forse era stata la lettera dell’Acadia Vermilion Hospital dove si sosteneva che, dato il suo recente tentativo di suicidio, la terapia non era consigliata ma obbligatoria?
Suicidio. La parola suonava più violenta di quanto fosse stato il tentativo. La sera prima di cominciare l’ultimo anno delle superiori, Eureka aveva semplicemente aperto la finestra e si era sdraiata sul letto mentre le leggere tendine bianche si gonfiavano nella brezza. Aveva cercato di pensare ad almeno un aspetto positivo del suo futuro, ma la mente le tornava ostinata ai momenti di felicità perduti che non avrebbe mai più riavuto. Non poteva vivere nel passato, e così aveva deciso che non poteva vivere, punto. Aveva acceso l’iPod e inghiottito tutte le pastiglie di ossicodone che era riuscita a recuperare dall’armadietto dei medicinali, dove le teneva suo padre per quando soffriva di ernia al disco.
Otto, forse nove pillole… non aveva tenuto il conto della manciata che si era ficcata in bocca. Aveva pensato a sua madre. Aveva pensato a Maria madre di Dio che prega per tutti i peccatori nell’ora della morte, come le era stato insegnato fin da piccola. Sapeva che la religione cattolica vieta il suicidio, ma credeva nell’infinita misericordia di Maria ed era certa che avrebbe capito: Eureka aveva perso tutto e poteva solo arrendersi.
Si era risvegliata legata a una barella in un pronto soccorso gelido con il tubicino della lavanda gastrica che le andava di traverso. Aveva sentito il padre e Rhoda che litigavano nel corridoio mentre un’infermiera la costringeva a bere un disgustoso intruglio di carbone attivo per assorbire i residui di veleno che ancora circolavano nel suo organismo.
Eureka non conosceva le frasi che le avrebbero garantito immediate dimissioni dall’ospedale – “Voglio vivere”,“Non lo farò mai più” – così aveva passato due settimane nel reparto psichiatrico. Non avrebbe mai dimenticato l’assurdità di saltare alla corda accanto a un donnone schizofrenico durante le sessioni di calistenia; o di mangiare la pappa d’avena insieme a uno studente universitario che si era tagliato i polsi ma non fino in fondo, e che adesso sputava in faccia a tutti gli infermieri che tentavano di dargli le pillole.
Sedici giorni dopo Eureka camminava svogliata verso la messa mattutina che precedeva l’inizio delle lezioni alla Evangeline Catholic High, quando Belle Pogue, una ragazza del secondo anno che veniva da Opelousas, l’aveva fermata sulla soglia della cappella: «Devi sentirti benedetta dal Cielo per essere ancora viva.»
Eureka aveva guardato dritto negli occhi slavati di Belle con una tale intensità che la ragazza era trasalita, si era fatta il segno della croce ed era corsa a rifugiarsi nel banco più lontano. E nelle sei settimane che erano trascorse da allora, Eureka aveva perso molti altri amici: ormai non li contava più.
La dottoressa Landry si schiarì la voce.
Eureka fissò i pannelli del controsoffitto. «Lo sa benissimo perché sono qui.»
«Preferirei sentirlo dalla tua voce.»
«La moglie di mio padre.»
«Hai problemi con la tua matrigna?»
«È Rhoda che mi fissa gli appuntamenti. Ecco perché sono qui.»
La terapia di Eureka era diventata una delle tante cause a cui si dedicava la moglie di suo padre. Prima era stato per affrontare il divorzio dei genitori, poi per elaborare il lutto della perdita della madre, e adesso per portare alla luce i motivi del tentato suicidio. Senza Diana, non c’era più nessuno a intercedere per Eureka, nessuno pronto a far fuori i medici incapaci con una telefonata. Eureka immaginò se stessa ancora alle prese con le sedute dalla dottoressa Landry a ottantacinque anni, non meno incasinata di quanto non fosse in quel momento.
«So che è stata dura perdere tua madre» disse la dottoressa. «Cosa provi?»
Eureka si concentrò sulla parola perdere, come se lei e Diana si fossero perse nella folla e fossero destinate a ritrovarsi, a prendersi per mano e andare lungo il molo in cerca del ristorante più vicino dove ordinare un buon fritto misto di mare, come se non fossero mai state divise.
Quella mattina a colazione, da un capo all’altro del tavolo, Rhoda le aveva mandato un messaggio: Dott.ssa Landry. Ore 15. E aveva aggiunto un link per inserire l’appuntamento nell’agenda del cellulare. Quando Eureka aveva cliccato sull’indirizzo, sulla mappa era comparso uno spillo che indicava lo studio su Main Street a New Iberia.
“New Iberia?” aveva chiesto con voce rotta.
Rhoda aveva bevuto un sorso di succo verde dall’aria decisamente disgustosa. “Credevo ti avrebbe fatto piacere.”
New Iberia era la cittadina dov’era nata e cresciuta Eureka. Era il posto che ancora considerava casa, dove aveva vissuto con i genitori quando era tutto integro, finché non si erano separati, la mamma si era trasferita e la camminata sicura del padre si era trasformata in un passo strascicato come quello dei granchi reali del Victor’s, il ristorante dove lavorava come chef.
Era il periodo di Katrina, e poco dopo era arrivato Rita. La loro vecchia casa era ancora in piedi (Eureka aveva sentito dire che adesso ci abitava un’altra famiglia) ma il padre non se l’era sentita di impegnare tempo e fatica per ripararla. Così si erano trasferiti a Lafayette, a ventiquattro chilometri e trent’anni luce da casa. Il papà aveva ottenuto un posto nella brigata di cucina da Prejean’s, un locale molto più grande e molto meno romantico del Victor’s. Eureka aveva cambiato scuola, ed era stato orribile. Non aveva nemmeno fatto in tempo ad accorgersi che suo padre ormai stava meglio, che avevano già traslocato in una grande casa su Shady Circle, di proprietà di una donna dai modi spicci e autoritari. Rhoda. Era incinta. La nuova camera da letto di Eureka si trovava in fondo al corridoio davanti a una cameretta da neonato ancora in allestimento.
Quindi no, Rhoda, a lei non piaceva affatto l’idea che la nuova terapeuta fosse a New Iberia. E poi come avrebbe fatto a tornare in tempo per il raduno?
Il raduno era importante non solo perché l’Evangeline avrebbe gareggiato contro la Manor High, la sua rivale storica. Quello era anche il giorno in cui Eureka aveva promesso di far sapere all’allenatrice se avrebbe lasciato o no la squadra.
Prima della morte di Diana, Eureka era stata nominata capitano senior. Dopo l’incidente, quando era tornata abbastanza in forze, gli amici avevano insistito perché partecipasse a un paio di gare amichevoli durante l’estate. Ne aveva corsa una, ma era andata malissimo, e in cambio aveva ricevuto soltanto dei gesti di pietà. L’allenatrice aveva attribuito la lentezza di Eureka ai gessi che ancora portava ai polsi. Ma era una bugia. Il suo cuore non era più nella corsa. Non era più con la squadra. Il suo cuore era in fondo all’oceano con Diana.
Dopo l’episodio delle pillole l’allenatrice le aveva portato dei palloncini, un’assurda nota di colore nella sua stanza sterile del reparto psichiatrico. Dopo l’orario di visite, non le avevano nemmeno permesso di tenerli.
“Io mollo.” Eureka si era vergognata di farsi vedere con i polsi e le caviglie legati al letto. “Dica a Cat che può avere il mio armadietto.”
Il sorriso triste dell’allenatrice suggeriva l’idea che dopo un tentativo di suicidio le decisioni di una ragazza hanno minor peso, come i corpi sulla luna. “Sono passata per due divorzi e per la battaglia di mia sorella contro il cancro” le confidò. “Non te lo dico solo perché sei la ragazza più veloce della mia squadra. Te lo dico perché correre forse è proprio la terapia che ti ci vuole. Quando starai meglio vieni da me. E parleremo di quell’armadietto.”
Eureka non sapeva perché aveva accettato. Forse perché non voleva deludere un’altra persona. Così aveva promesso alla sua allenatrice che avrebbe cercato di rimettersi in forma per la gara contro la Manor di quel giorno, tanto per darsi un’ultima chance. Un tempo adorava correre. Ed era affezionata alla squadra. Ma tutto questo apparteneva al prima.
«Eureka» la sollecitò la dottoressa, «vorresti dirmi cosa ricordi del giorno dell’incidente?»
Eureka fissò i pannelli bianchi del soffitto come se d’incanto potesse apparirvi scritto qualche suggerimento. Ricordava così poco dell’incidente che era inutile anche solo aprire la bocca. Sulla parete opposta dello studio era appeso uno specchio. Eureka si alzò e ci si piazzò davanti.
«Cosa vedi?» le domandò la dottoressa Landry.
Tracce della ragazza che era stata: le stesse piccole orecchie a sventola dietro cui infilava i capelli, gli stessi occhi blu scuro che aveva ereditato dal padre, le stesse sopracciglia selvagge che domava a suon di pinzette… era tutto come prima. Eppure, appena arrivata nel parcheggio davanti allo studio, aveva sentito due donne dell’età di Diana bisbigliare fra di loro: «Sua madre non la riconoscerebbe.»
Era un modo di dire come un altro, non tanto diverso dalle frasi che circolavano su di lei a New Iberia: Potrebbe mettersi a discutere con la muraglia cinese e spuntarla. È stonata peggio di una campana. Corre più veloce del vento. Il problema delle frasi fatte è che escono troppo facilmente di bocca. Quelle donne non stavano davvero pensando a Diana: lei avrebbe riconosciuto la figlia ovunque, in qualsiasi momento e circostanza.
Tredici anni di scuola cattolica avevano insegnato a Eureka che Diana la osservava dall’alto dei cieli e l’avrebbe riconosciuta sempre. Non avrebbe fatto caso alla sua maglietta strappata di Joshua Tree sotto il cardigan col logo della scuola, alle unghie rosicchiate o al buco in corrispondenza dell’alluce nel tessuto pied-de-poule della sua scarpa sinistra. Forse però non le sarebbero piaciuti i capelli.
Nei quattro mesi dopo l’incidente, i capelli di Eureka erano passati dal biondo cenere al rosso tiziano (il colore naturale di sua madre) al biondo platino (un’idea di sua zia Maureen, che aveva un negozio di parrucchiera) al nero corvino (che sembrava quello più adatto al suo umore) e adesso stavano ricrescendo in un’accozzaglia di sfumature.
Eureka abbozzò un sorriso verso il proprio riflesso, ma l’immagine ricambiò con una smorfia grottesca come quella della maschera da commedia appesa nell’aula di recitazione l’anno prima.
«Parlami del tuo ricordo positivo più recente» disse la dottoressa.
Eureka tornò a sdraiarsi sul divano. Doveva essere stato quel giorno. Forse proprio il cd di Jelly Roll Morton che suonava dallo stereo dell’auto, con la voce stonata di sua mamma che tentava di armonizzarsi con la voce stonata di Eureka, mentre percorrevano un ponte dove non erano mai state prima con i finestrini abbassati. Ricordò che stavano ridendo per una strofa particolarmente buffa, più o meno a metà del ponte. Rammentò di aver oltrepassato un cartello bianco arrugginito: Miglio 4.
Poi… ...