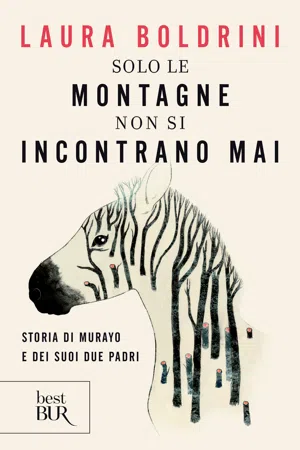![]()
Un mondo a parte
«Ciao Laurens, come va? Sono arrivata a Dadaab, qui tutto bene. Volevo parlarti della possibilità di allungare la missione di qualche giorno» dissi al mio capo, cercando di sondare il terreno.
«Ma perché vuoi rimanere di più?» mi chiese con il tono di chi non è convinto.
«Si tratta di un’opportunità che non vorrei perdere. Sono qui al confine con la Somalia, mi sembrerebbe un peccato non approfittarne…»
«Quale sarebbe l’opportunità da non perdere?» domandò con sospetto.
«Ieri ho parlato sia con Augustine Mahiga sia con Bruno Geddo ed entrambi mi hanno offerto la possibilità di andare a Mogadiscio. Bruno richiederebbe anche il security clearance a New York, quindi l’ufficio di Roma non dovrebbe occuparsi di nulla. Quante volte i somali arrivano a Lampedusa e devo parlare della situazione umanitaria, della guerra e della carestia in Somalia? Mi sembrerebbe utile andarci, rendermi conto di persona, non credi?»
«Sì, certo, senza dubbio interessante ma non era previsto. E poi è anche molto pericoloso.»
«Lo so, lo so ma i colleghi si spostano su mezzi blindati e con la scorta dell’Amisom, insomma con tutte le accortezze…»
«Se vogliono colpire non sarà il mezzo blindato a fargli cambiare idea… Non sono convinto Laura, il rischio è troppo alto e non credo ne valga la pena. Sono io a dovermi prendere la responsabilità e, ti dico la verità, non me la sento.» Capii che sarebbe stato inutile insistere, quindi lo salutai sbrigativamente e chiusi la chiamata. Non potevo andare a Mogadiscio, non ero autorizzata. Ero molto contrariata ma non potevo ignorare le sue osservazioni, anche se avrei preferito un’altra risposta. Laurens non si era mai tenuto lontano dai posti difficili, anzi, aveva lavorato in Darfur, nei Balcani, in Siria, in Iran e questo dava credito alle sue perplessità.
Già la sera prima Vittorio e Anastasia avevano manifestato la propria disapprovazione. Li avevo chiamati via Skype e con entusiasmo li avevo messi al corrente della mia idea.
«Dopo la missione a Dadaab pensavo di andare in Somalia, mi accodo alla missione di Bruno Geddo» avevo detto. Dall’altra parte avevo sentito il gelo.
«Ma sei sicura? Non mi sembra una buona idea andare a Mogadiscio. Fossi in te ci ripenserei» aveva tagliato corto Vittorio.
Anastasia, abituata alle mie partenze per luoghi difficili, era stata un po’ meno diretta ma soltanto per non deludermi. Dunque erano tutti d’accordo, non era il caso di sfidare la sorte. Accantonai quel viaggio non senza avvertire una certa frustrazione.
Uscii dalla mia stanza alle sei del mattino, la luce era tenue e dorata. Mi sedetti davanti alla porta della camera a osservare il paesaggio che sembrava ovattato e immobile. In lontananza vidi due persone che si dirigevano verso la mensa. In Africa la giornata comincia presto anche perché nelle zone remote, senza segnaletica stradale, con il buio non si può girare e in alcuni luoghi come Dadaab nel pomeriggio scatta il coprifuoco. Io faccio fatica a svegliarmi di buonora e ho sempre paura di riaddormentarmi e di arrivare in ritardo. Per questo quando sono in missione mi alzo immediatamente, appena suona la sveglia, senza indugiare come di solito mi piace fare.
Quella mattina partimmo in colonna alle otto in punto. Un pick-up della polizia, con sei uomini armati a bordo, apriva il convoglio di dieci macchine e un altro lo chiudeva. Nella jeep con me vennero Hassan e Sam, due colleghi kenioti che si occupavano del campo di Ifo, quello dove viveva Mahad.
Anche loro avevano lasciato le famiglie in villaggi a centinaia di chilometri.
«Tu Sam di dove sei?» chiesi. Mi rispose Hassan che era seduto davanti, accanto all’autista.
«Hai mai sentito parlare di Kogelo?»
«Il nome non mi è nuovo, non è la prima volta che lo sento… Kogelo, ma non riesco a collegarlo a nulla di preciso. Se mi aiutate magari ci arrivo» risposi. Si misero a ridere.
«Eppure anche in Europa dovreste conoscere Kogelo, è diventato molto famoso in tutto il mondo qualche anno fa…»
«Hai ragione Hassan, ma non ricordo perché, perdo i colpi…» dissi per scusarmi della mia carenza.
«Va bene, ti do un aiuto, oggi Kogelo lo chiamano Obamaland…»
«Certo!» esclamai. «È il paese d’origine del padre del presidente americano, ecco perché mi sembrava di conoscerlo, ho anche letto il suo libro I sogni di mio padre.»
Kogelo si trovava nella provincia di Nyanza, nella zona occidentale del Kenya, mentre Dadaab era nella parte opposta. Da sei anni Sam lavorava a Dadaab e una volta al mese tornava a casa da sua moglie e sua figlia.
«Com’è cambiata Kogelo dopo l’elezione di Obama?» gli chiesi incuriosita.
«Direi che la vita del paese si è radicalmente trasformata. Hanno portato l’energia elettrica. Ora ci sono alberghi e guest house perché tanti turisti e giornalisti vanno a visitare il posto. C’è più ricchezza.»
«Avreste mai creduto che il figlio di un uomo di Kogelo sarebbe un giorno diventato il presidente degli Stati Uniti d’America?»
«Lo speravamo ma ci sembrava troppo… Già che fosse diventato senatore americano ci aveva riempito di gioia. Peccato solo che suo padre non abbia potuto assistere alla scalata del figlio. Lui era un economista, un funzionario di Stato molto stimato che aveva lavorato con Tom Mboya e anche con l’attuale presidente Mwai Kibaki. È morto nel 1982, in un incidente stradale.»
«E come vi siete sentiti il giorno della vittoria di Obama?»
«Orgogliosi. Ognuno di noi si è sentito il presidente americano… Abbiamo pensato che i nostri problemi finalmente sarebbero stati presi sul serio dalle autorità di Nairobi. Ci ha dato una grande speranza per il futuro. Chissà, un giorno mio figlio potrebbe diventare presidente dell’Italia…» disse Sam ridendo.
Doveva essere stata una grande soddisfazione per Kogelo, per il Kenya e anche per l’Africa. Una sorta di riscatto per milioni di persone. Con amarezza pensai alla battuta di Sam. Era troppo lunga spiegare che nel nostro Paese le cose sono più complicate e che nascere in Italia non ti dà il diritto di diventare cittadino, come negli Stati Uniti. Da noi la strada a un certo punto si blocca. Quanto tempo dovrà ancora passare prima che il figlio di un immigrato africano possa accedere alle più alte cariche dello Stato o partecipare a un concorso nell’amministrazione pubblica? O più semplicemente, se nato in Italia, diventarne cittadino?
Immersa nei racconti di Sam e nelle mie riflessioni, arrivai all’ufficio Unhcr di Ifo senza che me ne accorgessi. Il convoglio di macchine si sciolse e noi rimanemmo con la nostra scorta. Dopo dieci minuti arrivò Ibrahim, di corsa. Non portava i jeans e le scarpe da ginnastica come a Nairobi, era vestito in modo più classico e teneva stretta una valigetta da lavoro. Sembrava più adulto e aveva un’espressione seria, quasi triste. Si scusò per il ritardo, e ci tenne a dirmi che lui e la sua famiglia abitavano a circa tre chilometri dall’ufficio, e che per essere in orario aveva chiesto un passaggio in moto, ma soltanto per un piccolo tratto, poi aveva dovuto camminare.
Ibrahim spiegò alla scorta dove si trovava il blocco di Mahad.
Il campo di Ifo era come un grande villaggio, un intreccio di strade e vicoli con capanne di fango, scuole, un mercato di bancarelle, moschee, un ambulatorio medico, bambini scalzi, donne con veli più o meno colorati, galline, capre. C’era molto fermento: motorini, carretti, tanta gente a piedi e qualche camioncino. Ci fermammo nella strada principale e parcheggiammo le auto. Poi c’inoltrammo per circa cento metri in un sentiero stretto che terminava davanti a un cancello di legno. Ibrahim lo aprì e noi entrammo. Nel cortile c’erano tre capanne di fango e tanti bambini; al nostro arrivo una donna si precipitò a mettere il velo che aveva appoggiato su una sedia. Ibrahim chiese qualcosa alla donna che immaginai essere la moglie di Mahad. Poi entrò in una delle capanne da cui si affacciò il padre di Murayo. Ci salutammo con calore e mi presentò la moglie Arfon, che intanto si era coperta la testa, e i cinque bambini, due femmine e tre maschi. Recuperò un banchetto e due sedie per farci sedere mentre altre persone si avvicinavano incuriosite. Ci disse che disponeva di quel cortile, di circa quaranta metri per trenta, perché tre famiglie se ne erano andate e non erano ancora state rimpiazzate. Una era partita per gli Stati Uniti grazie al progetto di reinsediamento e due avevano fatto rientro in Somalia. Nella capanna di fango con il tetto coperto da teloni di plastica c’era il suo letto, sotto una zanzariera, e una sedia di plastica. In quella un po’ più grande, con il tetto in lamiera, dormivano moglie e figli in un unico letto. Vi regnava una povertà assoluta, una totale assenza di suppellettili e utensili. Niente acqua corrente, niente elettricità, nessun mobile.
Mahad disse con soddisfazione che la sua mente aveva finalmente trovato pace. Per la prima volta dal 1994, adesso riusciva a dormire sereno.
«L’incontro con Murayo non sparirà mai più dai miei occhi. Dal suo aspetto e dal suo sorriso ho capito che è stata cresciuta bene e l’angoscia che mi ha accompagnato per tanti anni è scomparsa. È stato bello sentirle dire che desiderava rimanere più tempo assieme a me. Spero ci sarà un’altra occasione per farle conoscere i suoi fratelli» disse Mahad con un’espressione tenera. «La famiglia italiana che si è occupata di lei, con il suo operato, ha fatto molto più che allevare una bambina bisognosa di cure: ha messo un ponte tra Somalia e Italia.»
Annuii e gli dissi che aveva proprio ragione.
La storia di Murayo infatti aveva tanti significati. Di sicuro aveva creato un ponte tra due Paesi. Ma, non era tutto. Esaltava anche l’amore di due padri per la stessa figlia in un tempo in cui sempre più spesso le donne sono lasciate sole a crescere i bambini, a Nairobi come a New York o a Roma. Ricordavo che in più occasioni lo stesso Obama aveva pubblicamente denunciato il disimpegno dei padri e le conseguenze devastanti che questo causava ai figli. Adulti che non si assumevano le proprie responsabilità, comportandosi da ragazzini. A causa dei loro abbandoni – sottolineava il presidente americano –, i figli erano più esposti a vivere in povertà, a lasciare gli studi e a commettere crimini oltre che a diventare genitori in età prematura. Mi aveva colpito il modo diretto e privo di retorica con cui Obama aveva trattato l’argomento, senza esitare a far riferimento alla sua esperienza di ragazzo cresciuto insieme alla madre e ai nonni, con un padre lontano, in Kenya, che ogni tanto mandava qualche lettera.
La storia di Murayo invece andava controtendenza e rivalutava appieno il significato della paternità. C’erano intorno a lei due figure maschili, diverse e lontane. Due uomini che avevano agito per il suo bene, mossi dal desiderio di aiutarla.
Rimanemmo con Mahad nel cortile, seduti sotto l’unico albero, a parlare del suo Paese e là mi raccontò di un altro suo grande dispiacere: la perdita della terra.
«Il modo di vivere in Somalia è cambiato nel 1991. Con lo scoppio della guerra civile, per sopravvivere bisognava cercare la protezione del proprio clan. Noi abitavamo a Sakow, nel sud della Somalia, ma le nostre radici erano altrove, il nostro clan era originario del centro del Paese, dove avevamo lasciato gran parte della famiglia. A Sakow non avevamo riferimenti, eravamo soli. Per questo ci hanno potuto fare tutto quello che hanno voluto, sapevano che nessuno li avrebbe puniti. Prima se la sono presa con me, mi hanno picchiato a sangue, poi hanno ucciso mio fratello davanti ai miei occhi. A mia sorella non hanno risparmiato niente, si sono avventati su di lei come delle bestie fameliche» ricordò Mahad, con la testa bassa e un filo di voce. «E non si sono limitati a farci del male. Hanno portato via gli animali, le mucche e le capre e ci hanno ordinato di andarcene per sempre altrimenti ci avrebbero ammazzati tutti. Ma scacciarci dalla terra era come condannarci a morte: senza terra non c’è vita né futuro in Somalia. Per questo io e la mia famiglia siamo destinati a vivere qui, in questo cortile» concluse con un’espressione affranta.
Il profondo senso di sconfitta che si avvertiva nelle parole di Mahad mi commosse. Avrei voluto dargli conforto e fargli intravedere una speranza ma non sapevo cosa dire. Come si fa a consolare una persona quando tutte le strade sembrano sbarrate? Non volevo creare false aspettative ma gli dissi che non doveva perdere la fiducia, le cose in Somalia si stavano man mano muovendo in direzione della pace. E non era escluso che le terre sarebbero state riassegnate a coloro ai quali erano state arbitrariamente sottratte.
I colleghi mi fecero segno che si era fatto tardi. Ci alzammo e proposi di fare delle foto da portare a Murayo. Arfon chiamò i bambini, li raggruppò vicino a Mahad e si misero tutti in posa sotto un telo che riparava dal sole, mentre i vicini continuavano ad arrivare incuriositi. Prima di lasciarli chiesi se conoscevano Aden Sabrie, un giornalista somalo che viveva da tanti anni a Roma, con cui spesso lavoravo e che conduceva una trasmissione alla Bbc. Prima ancora di tradurre, Ibrahim esclamò:
«Certo che conosciamo Aden Sabrie, chi non lo conosce qui a Dadaab? Lui è una persona molto rispettata. Attraverso i suoi servizi alla radio sappiamo anche che tanti somali muoiono in mare vicino all’Italia».
Era infatti questo il motivo per cui Aden e io ci sentivamo di frequente: le imbarcazioni in difficoltà, le chiamate di soccorso, i parenti in cerca dei loro cari dispersi in mare, l’identificazione dei cadaveri da parte dei familiari. Aden, considerato un punto di riferimento della comunità somala, era sempre disponibile ad aiutare queste persone e a collaborare nelle ricerche. Spesso, per facilitare le operazioni di soccorso, ci scambiavamo informazioni sulle segnalazioni delle imbarcazioni e le passavamo alla Guardia costiera, così come davamo alla stampa le notizie relative agli sos che lui riceveva. Prima di partire per il Kenya c’eravamo sentiti e ridendo mi aveva detto: «A Dadaab prova a chiedere se conoscono Aden Sabrie…».
Rientrammo al compound nel pomeriggio verso le quattro. Ero sopraffatta dai racconti di Mahad, dalla condizione del campo, dal caldo e dalla sete. Dal senso di impotenza e dalla mancanza di prospettive per migliaia di persone il cui destino era deciso da altri. Pensai alle figlie di Ambyo: se non fossero riuscite a partire per gli Stati Uniti sarebbero anche loro cresciute e diventate mamme a Dadaab. Ibrahim era arrivato a Ifo da bambino, aveva studiato e imparato l’inglese, usava il computer e attraverso internet vedeva il mondo. La rete gli apriva i confini ma lui non poteva uscire da Dadaab, neanche per ritornare nel suo Paese. Una condizione che creava un’enorme frustrazione a lui come a tanti altri giovani, un intollerabile spreco di risorse umane.
La visita ad Ambyo, due giorni dopo, fu breve perché la piccola Ikhlasa, di cinque mesi, stava ancora male, aveva febbre e diarrea. Ambyo ci presentò suo marito Abdy e le cinque figlie che le stavano tutte intorno. Erano molto carine e allegre, due andavano già a scuola e avevano il capo coperto. Notai una spiccata somiglianza con Murayo negli occhi e nel sorriso. A differenza di Ibrahim, Abdy non parlava inglese e non sapeva usare il computer. Aveva studiato fino alla terza elementare. L’unica volta che era uscito da Hagadera, uno dei vecchi agglomerati di Dadaab, era stato per andare a Ifo per chiedere a Mahad la mano di sua figlia Ambyo. Suo padre e Mahad erano cugini ma non era stato un matrimonio combinato, avevano deciso loro. Abdy aveva ventitré anni e lei diciassette. Lui faceva qualche lavoretto quando capitava ma non aveva un’occupazione stabile e ciò si ripercuoteva sulla condizione della famiglia. Le bimbe non avevano scarpe e indossavano vestiti logori. Nel cortile non c’erano giochi di alcun tipo.
Vivevano tutti in una piccola capanna fatta di sterpaglie, con il tetto di stracci e teli di plastica sbrindellati. Lo spazio di cui disponevano non era chiuso e non riparava né dal vento né dalla sabbia. Stavano peggio di Mahad. Mi colpì vedere una coppia così giovane in una tale condizione di sottosviluppo e desolazione. La loro unica speranza era di essere trasferiti negli Stati Uniti con il programma di reinsediamento.
Pensai a loro in America, a come si sarebbero adattati a un’esistenza completamente diversa, allo shock culturale di vivere in una città piena di traffico, dove ogni servizio si richiedeva via internet, gli appartamenti si trovavano al ventesimo piano e gli elettrodomestici risolvevano gran parte delle mansioni domestiche. Dove il clima poteva essere molto rigido e la struttura sociale era basata sull’individuo più che sulla comunità. Ambyo e Abdy avrebbero fatto fatica a ricominciare ma le bambine no, loro avrebbero appreso la lingua e sarebbero diventate ben presto delle giovani americane: era un’opportunità che favoriva i figli più che i genitori.
Ambyo tirò fuori dalla capanna due piccoli banchetti di legno e ci fece accomodare. Le chiesi di Murayo.
«All’inizio non potevo credere che quella ragazza fosse mia sorella. Non so, mi sembrava strano… Ma poi mi sono accorta della somiglianza fisica tra noi e ho capito che era proprio lei. Anche se i vestiti erano così diversi…» disse Ambyo sorridendo con imbarazzo. «Murayo mi è mancata tanto, è la mia unica sorella. Per anni non ho saputo più niente di lei ed era come se avessi perso una parte di me. A volte temevo che fosse morta… Ora tutto si è ricomposto.»
«Che idea ti sei fatta della sua storia?» le chiesi.
«Murayo è stata fortunata, è guarita, ha ricevuto un’istruzione e non le manca nulla» rispose senza esitazione. «Ora che ci siamo ritrovate non ci perderemo più. Anche se non riusciamo a comunicare, resteremo in contatto. La sorella maggiore sostituisce la madre nella nostra cultura. Spero che Murayo si comporti come richiede il suo ruolo e non si dimentichi di noi» sottolineò con un’espressione triste.
La piccola Ikhlasa iniziò a piangere e noi ci alzammo per andare via. Abbracciai Ambyo che, come già accaduto a Nairobi, a malapena si avvicinò, come chi è troppo riservato per acconsentire a un contatto fisico.
Rientrai al compound con l’immagine delle bambine che ci salutavano e dei loro bei volti. Erano nate a Dadaab, in un mondo a parte, e là stavano crescendo. Quella era l’unica dimensione in cui c’era...