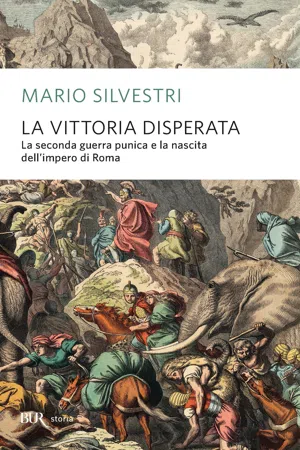![]()
1
Dieci miglia a nordest di Canosa
2 agosto dell’anno di Roma 538 (216 a.C.)
Il culmine della terribile epopea fu raggiunto in terra di Puglia il 2 agosto del 216 a.C., quando fu battaglia fra l’esercito romano, comandato dai consoli Caio Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo, e quello cartaginese guidato dal grande Annibale Barca.
Il comando, esercitato a giorni alterni dai due consoli, spetta oggi a Terenzio Varrone. Al primo sole sventola sulla sua tenda la tunica scarlatta. Per i legionari è il segnale di avviarsi ai posti di combattimento. I soldati sciamano dagli attendamenti e si schierano in ordine di battaglia, agli ordini dei centurioni e dei tribuni militari.
Finirà, essi sperano, la tensione che li opprime da mesi! E dovrebbe finire anche l’incubo che attanaglia Roma, il senato, l’intera cittadinanza. Da quando nella capitale è pervenuta la notizia che i due grandi eserciti si fronteggiano nuovamente nella Daunia, tutti sono preda dell’ansia: sperano nella vittoria, ma il timore di un’altra sconfitta li angoscia. Nella città echeggiano le invocazioni agli dei: preghiere, suppliche, i responsi degli aruspici sussurrati di bocca in orecchio.
Ma Caio Terenzio Varrone non ha dubbi e non ha paura. Egli non tollera che Annibale calpesti da padrone il suolo d’Italia. Oggi, volente o nolente, il suo pusillanime collega, il patrizio Lucio Emilio Paolo, eseguirà gli ordini suoi senza discuterli: e sarà vittoria. Egli comanda otto legioni – 80.000 fanti e 7200 cavalieri – per fronteggiare Annibale, che di uomini ne ha poco più di 50.000, pur dando il giusto peso alla sua fortissima cavalleria. Se fallirà la manovra, lo schiaccerà la forza bruta.
Anche Annibale sta disponendo perché i suoi soldati si rifocillino e si armino. Poi, con un drappello di cavalleggeri, si porta sul monte di Canne, dal quale può dominare la pianura. I suoi problemi sono immensi. Tre volte in due anni vincitore su suolo italiano, ha però un esercito in cui si parlano almeno quattro lingue: il celtico, i dialetti ispanici, il numida e il fenicio. E diverse sono anche le armi e quindi le tecniche con cui ha dovuto addestrare al combattimento i suoi soldati. I giganteschi galli, nudi fino alla cintola, sono equipaggiati con un grande scudo e una lunga daga a doppio taglio. Gli ispanici, vestiti con brevi tuniche di lino bianco orlate di porpora che rifulgono al sole, la spada l’han corta e letale soprattutto di punta. Quanto ai fanti d’Africa, da lontano li prenderesti per romani, armati come sono con le spoglie dei vinti, catturate sul Trebbia e sul lago Trasimeno. Sono genti diverse, animate da sentimenti diversi. Egli ha dovuto amalgamarli, colmando con il suo genio militare e con il suo carisma la grave inferiorità numerica.
Mentre osserva il campo, che comincia a brulicare di uomini per l’imminente battaglia, Annibale viene apostrofato da Gisgone: «Mi sembra che questi romani siano davvero un po’ troppi…». La replica di Annibale è pronta: «Hai trascurato un particolare importante». «Che mai?» «Che in quella moltitudine non ce n’è uno che valga Gisgone!»
Gli astanti ridono rumorosamente. E, scendendo dal colle, ripetono la battuta a quanti incontrano. Essa si sparge fulminea in tutto l’esercito: il sommo condottiero è di buon umore. Sicuro com’è del fatto suo, potrà soltanto vincere. Prima di attaccar battaglia Annibale cavalca lungo lo schieramento. Nelle parole che grida non c’è solo la promessa delle ricchezze d’Italia e dell’umiliazione di Roma: nelle sue esortazioni raggiunge anche vette di più alto valore civile. Ripete il grande impegno: «Ascoltate! Chi colpirà il nemico sarà cartaginese di diritto. Qualunque sia il suo nome o la sua patria!».
Con questa invocazione lo ricorderà il poeta Ennio, soldato di Roma nella guerra annibalica.
Annibale si colloca al centro del suo schieramento con 2000 cavalieri, e ha vicino il fratello Magone con altri 1000. Vuole controllare la manovra delle fanterie, cui è affidato il compito più delicato. Intanto, poco dopo l’alba, il suo esercito comincia a schierarsi con fronte a nord, non appena egli si è accorto che i romani sono intenzionati a dare battaglia. Deciso a controllare dal centro l’evolvere degli eventi, al centro colloca la fanteria celto-iberica, quasi 30.000 uomini, disposti a reparti alternati, perché i solidi iberici facciano da stecche d’acciaio al corsetto di questa fanteria, in cui essi non sono neppure 8000. Alle ali schiera, 6000 per parte, i fedeli libici, armati da opliti. Alle estremità, infine, la numerosa cavalleria. Essendosi riservati, lui e il fratello, 3000 cavalieri, gliene restano 7000 da suddividere fra le due ali: sulla sinistra, toccando l’Ofanto, la cavalleria celtica e iberica, al comando di Asdrubale Monomaco; sulla destra la cavalleria numidica sotto Annone, che giusto due anni prima gli aveva così abilmente facilitato il passaggio del Rodano.
Ma lo schieramento disposto da Annibale non è lineare. Con 40.000 fanti in linea – poiché a guardia del campo ha lasciato solo un pugno d’uomini – deve contenere un nemico quasi doppio. I gallo-ispani, che occupano il centro, egli li dispone a semicerchio o, se si vuole, a falce di luna rivolta verso i romani. Di conseguenza la fanteria pesante africana è arretrata ai due estremi della falce. La disposizione è disperata, come lo è la situazione di Annibale. A differenza dei romani, per lui l’alternativa non è fra la vittoria e la sconfitta, ma fra la vita e la morte.
Lo schieramento romano, rivolto a sud, è stato organizzata da Varrone. Al collega Emilio Paolo è affidata la debole cavalleria romana, 2400 uomini in tutto, sull’estrema destra che tocca il fiume. Varrone si colloca alla sinistra con la cavalleria italica, forte di 4800 cavalieri e quindi più consistente della contrapposta cavalleria numidica, seppur questa sia una considerazione a posteriori. Vi è comunque, in questa dislocazione, un abbozzo di tentativo per avvolgere sulla sinistra romana l’esercito cartaginese purché, resistendo l’ala destra, la fanteria romana riesca a tenere agganciata quella punica. L’enorme massa della fanteria, 70.000 uomini, è collocata al centro, a ranghi serrati, sotto il comando dei proconsoli Gneo Servilio Gemino e Marco Minucio Rufo, rispettivamente console e vicedittatore nell’anno precedente: dunque tutt’altro che novellini nell’affrontare Annibale. Fuori dalla mischia restano 2000 uomini nell’accampamento minore, e in quello maggiore 8000, ai quali è affidato il compito di attaccare ed espugnare, durante il combattimento, il campo cartaginese. Ad Annibale, dopo la sconfitta, non resterebbe un bastione intorno al quale far resistenza: se salvasse la vita, dovrebbe darsi al banditismo solitario.
Agli squilli delle trombe, i primi scontri hanno inizio verso le sette del mattino. Da parte cartaginese i frombolieri e la poca fanteria leggera, schierati davanti ai gallo-ispani, sono le prime formazioni che vengono alle armi con gli uomini di Roma. Violenta si appicca la lotta anche fra la cavalleria romana e la celto-iberica. Non è un torneare. Gli uomini scendono da cavallo e si avvinghiano corpo a corpo. Alfine i cartaginesi sopraffanno i romani meno numerosi: la maggior parte di questi sono uccisi, pochi fuggono, un gruppo guidato dal console Emilio si sposta verso il centro per proteggere e aiutare la fanteria. Il console vuole soprattutto farsi vedere, incoraggiare, esortare.
Le due fanterie sono venute allo scontro frontale. E la formazione romana, così profonda e stretta, che si estende per un fronte lineare poco superiore a un miglio, ha buon gioco contro la ben più sottile prominenza gallo-ispanica. A poco a poco, perciò, sotto la terribile spinta della fanteria legionaria, la falce di luna si schiaccia e, dopo qualche ora dall’inizio della battaglia, gallo-ispani e africani sono allineati su un’unica retta. E poiché la pressione romana non viene meno, il centro cartaginese continua a cedere e comincia la fase più delicata della manovra ideata da Annibale, quella per effettuare la quale è richiesto il virtuosismo addestrativo delle truppe africane, che sono le più veterane fra le sue formazioni. Il centro è costretto a ripiegare ancora e, ovviamente, comincia a estendersi a mezzaluna, in senso opposto alla curvatura iniziale. Estendendosi, però, si assottiglia, eppure non deve assolutamente spezzarsi, per non consentire ai romani di erompere nuovamente nella piana. Se i romani dilacerassero il cordone gallo-iberico e dilagassero in aperta pianura, allora la battaglia tornerebbe a essere quella di ogni uomo contro ogni uomo, e il numero soverchiante avrebbe partita vinta.
Mentre cedono i gallo-ispani, la fanteria pesante africana si allunga alle ali, affiancando e attaccando lateralmente la compatta massa romano-italica. Questa reagisce violentemente e gli africani faticano a contenerla. Nel frattempo, volta in fuga o distrutta la cavalleria romana salvo lo squadrone che attornia Emilio Paolo, Asdrubale Monomaco ha spostato i suoi cavalieri dalla parte opposta della linea di combattimento, in appoggio ai numidi. Finora costoro, trovandosi di fronte una cavalleria numerosa, non hanno avuto successo. Combattono alla loro maniera: veloci assalti, ritirata veloce e quindi nuova carica, così all’infinito, senza subire gravi perdite, ma senza neppure infliggerne. L’arrivo della cavalleria di Asdrubale concede all’ala destra punica una soverchiante superiorità numerica e la cavalleria italica è costretta a battere in ritirata, trascinando anche Varrone. I numidi si danno alla caccia dei cavalieri nemici isolati, mentre Asdrubale scaglia la sua cavalleria contro le spalle della quadrata formazione romana, cominciando a sfiancarla e alleggerendo la pressione sulla fanteria africana. Gli afri riescono finalmente a darsi una mano alle spalle dei romani, serrandoli in un cerchio di ferro, prima che i celto-iberici vengano spezzati. Così Annibale ha raggiunto lo scopo su cui ha giocato la vita: la moltitudine di soldati romani non può più schierarsi contro i meno numerosi nemici. Combattono solo coloro che sono disposti lungo la circonferenza, mentre all’interno gli altri, che non possono manovrare, sono un blocco di carne, vulnerabile alle lontane offese dei dardi, delle fionde e delle lance. Muoiono, questi, senza vedere i nemici, che macellano intanto la circonferenza esterna, avvicinandosi gradualmente al centro.
Anche Emilio Paolo, rimasto alla retroguardia del centro dello schieramento romano, è incapsulato nel nodo scorsoio degli africani, della cavalleria di Asdrubale e dei numidi che tornano sul campo di battaglia dopo avere annientato i fuggiaschi che inseguivano. Gli è accanto Servilio Gemino con 10.000 soldati, e anche Minucio Rufo si dà da fare per svincolarsi da quel serpente costrittore. Ma è tutto inutile. Nel combattimento ravvicinato cadono i due proconsoli, ed Emilio Paolo, già ferito, combatte ormai solo per vendere cara la pelle.
Nel pomeriggio, a esasperare le difficoltà delle legioni, si leva il vento Volturno, uno scirocco che spira da sudest e getta granelli di sabbia impalpabile negli occhi di coloro che vi hanno la faccia rivolta contro, e gli occhi sono romani: «E una nube di polvere si vede alta levarsi e par che giunga al cielo». Il vento contrario rallenta le lance scagliate dai romani, accelera le puniche; e poi, gli uni vedono, gli altri no. Ma per far fuori un esercito così immenso ci vuole del tempo. E la carneficina si protrae fino a poco prima del tramonto. Si è combattuto, sotto il sole ardente della Daunia estiva, per oltre 10 ore.
Finalmente i cartaginesi hanno stravinto, hanno schiacciato per la quarta volta consecutiva, sul suo suolo, la Confederazione italica. Il console Emilio Paolo, che è stato ferito da un colpo di fionda fin dalle prime schermaglie, con il suo squadrone di cavalleria romana ha cercato senza tregua di accorrere verso i punti pericolanti dello schieramento. Poiché questo è stato disfatto e travolto in poche ore, decimati i suoi uomini, ancora ripetutamente ferito il console stesso da dardi crudeli che scavano le precedenti ferite, martoriando le carni aperte, gli vengono meno le forze e non riesce più a tenere il cavallo. è costretto a smontare di sella. I cavalieri intorno a lui lo imitano per soccorrerlo e difenderlo. A quella vista gli altri più lontani fanno altrettanto, credendo che sia stato il console a impartire l’ordine di combattere appiedati. Nelle file cartaginesi qualcuno se ne accorge e riferisce ad Annibale che lo stesso console ha ordinato ai cavalleggeri di appiedarsi. Ora che li ha fatti scendere da cavallo, pensa il duce cartaginese, a lui non resta che la fatica di prenderli prigionieri e di legarli. E anche stavolta non rifugge dal sarcasmo: «Tanto valeva che me li preparasse legati».
Ma che potevan fare quel pugno di cavalieri? Potevano solo morire sul posto, come le decine di migliaia di fanti che già coprivano il terreno. E lo stavano facendo, compreso il console. Emilio Paolo, esausto e grondante sangue, si appoggiò a un macigno. I fuggiaschi gli scorrevano davanti e lo guardavano senza farci caso. Ma il tribuno Gneo Lentulo lo riconobbe: «Lucio Emilio, tu che solo sei innocente di questa strage, prendi il mio cavallo, finché ti rimangono le forze. Io ti farò da scorta. Non rendere più triste questa giornata con la morte di un console: di lacrime e di lutti ce n’è abbastanza, tutt’intorno».
«Sei davvero un prode, tribuno! Ma non perdere tempo prezioso a commiserarmi. Corri a Roma, invece, e avvisa il senato che la città sia posta immediatamente in stato di allerta. A Quinto Fabio dirai privatamente che ho seguito i suoi consigli fino alla morte. Preferisco cadere fra i miei soldati, che subire l’onta di un processo per questa disfatta, o recitare, per difendermi, la parte dell’accusatore del proprio collega.»
Il console si alza a fatica. Stringe la mano al tribuno. Una nuova ondata di fuggitivi li travolge. Il cavallo di Lentulo trascina quest’ultimo lontano, fra la marea. E intanto i nemici si avvicinano a Emilio Paolo, che si getta nella mischia. Ma ancora lo difende Lucio Bandio da Nola, facendo schermo al console con il suo corpo e con lo scudo. Quando questi cade trafitto, su di lui si rovescia anche Lucio Bandio, dopo aver fatto strage di nemici. Ma non muore: sopravvive e farà parlare ancora di sé.
Tutt’intorno e altrove la battaglia si è trasformata in uno sterminio selvaggio. Puoi vedere un legionario in fin di vita e con le braccia spezzate avventarsi rabbiosamente contro un numida e strappargli a morsi il naso e le orecchie, finché cadono entrambi, il romano ormai morto sull’africano sfigurato, che viene disseppellito dai cadaveri circostanti solo il giorno dopo. Altri si immolano in un suicidio collettivo: nel terreno friabile scavano affannosamente una buca, vi infilano la testa e poi riempiono nuovamente di terra la buca, per morire soffocati.
Mentre si svolgevano i combattimenti, i romani del campo maggiore avevano assalito il battaglione presidiario dell’accampamento di Annibale, riducendolo a mal partito e costringendolo a rinserrarsi dietro lo steccato. Ma intanto, mentre aveva luogo il gran finale, Annibale inviò soccorsi che liberarono il suo presidio e respinsero i romani, costretti a ripiegare nei loro campi. E agli stessi affluiscono, sul far della sera, molti superstiti. Dal campo maggiore giungono staffette, per invitare coloro che si trovano nel campo più piccolo a raggiungerli. Di lì avrebbero tentato di sfilare verso Canosa. Molti però sono disarmati, e poi manca l’ardire: fra loro e Canosa c’è il nemico che rastrella la campagna. Il tribuno militare Sempronio Tuditano si rivolge a un gruppo di incerti: «Cosa preferite? Essere catturati e interrogati dai nemici, per sapere se siete romani o latini, al fine di stabilire il diverso prezzo del vostro riscatto? Non lo credo, se siete concittadini del console Emilio che ha scelto di morir bene anziché vivere male; e non lo credo, se siete camerati di quei morti che giacciono accumulati sul campo di battaglia. Prima che faccia luce, prima che il nemico infesti la pianura con posti di blocco, erompiamo con le armi e l’audacia. Chi vuol salvare se stesso e la repubblica mi segua!».
Subito 600 cavalieri gli vanno dietro. E nel campo maggiore altri se ne trovano, disposti a correre il rischio. A riparare entro Canosa saranno quindi parecchie migliaia. Quelli che non osano, il giorno dopo cadranno prigionieri dei cartaginesi.
A Canosa erano pervenuti altri quattro tribuni militari superstiti: Quinto Fabio, tribuno della V legione, figlio del dittatore dell’anno precedente, Publicio Bibulo e Publio Cornelio Scipione, della III, e Appio Claudio Pulcro, della IV. Appio Claudio e Scipione vengono provvisoriamente eletti comandanti di quegli sbandati, quasi due piccoli consoli: l’ultimo aveva 18 anni, e suo padre era lontano, al comando delle legioni iberiche. Mentre discutono il da farsi, accorre Publio Furio Filo, che porta notizie deprimenti: «È inutile agitarsi. Roma è perduta. Persino giovani nobili, il più illustre Caio Cecilia Metello, pensano di fuggire verso la costa e abbandonare l’Italia. Sperano di trovare asilo politico presso qualche regnante transmarino». Cose da non credere! È il peggiore reato, la diserzione di fronte al nemico, ed è nuovo per i romani. Si propone di riunire un consiglio di guerra. Ma Scipione ha uno scatto: «Non è tempo di discutere, ma di agire. Venga con me chi vuol salvare la repubblica. Dove si complottano tali disegni, lì è il vero nemico!».
Seguito da pochi, balza verso la tenda di Metello e vi irrompe impugnando la spada: «Non abbandonerò le sorti della repubblica né tollererò che lo faccia un altro cittadino romano. Che gli dei mi maledicano, se verrò meno a questa solenne promessa. E tu, Caio Cecilio, e voi altri presenti giurerete con me. Chi non lo farà si troverà questo gladio piantato nel corpo».
Atterriti, quasi fosse loro apparso improvvisamente Annibale in persona, tutti giurarono e si consegnarono agli arresti in custodia di Scipione. Del loro comportamento fu inoltrato rapporto alle autorità superiori.
In campo cartaginese l’euforia trabocca al massimo. Il «cessate il combattimento» l’aveva ordinato lo stesso Annibale prima del calar del sole, vedendo i suoi soldati spossati ed esausti dal tanto uccidere. Congratulandosi con lui, il suo stato maggiore lo incita a darsi riposo e a concederlo alle truppe per il resto della giornata e della notte. Ma non è d’accordo Maarbale, comandante dell’intero corpo di cavalleria: «Annibale Barca, renditi conto della vittoria che hai conseguito: fra cinque giorni potresti pranzare in Campidoglio. Seguimi: io ti precederò con la cavalleria, perché ti credano giunto prima ancora del tuo arrivo».
Annibale si fa pensieroso: troppo bello per essere vero. L’obiettivo è eccessivamente ambizioso. Impossibile, comunque, prendere una decisione sull’istante: «Mio caro Maarbale, il tuo intendimento è degno di lode. Ma per valutare il consiglio mi occorre tempo».
Il comandante della cavalleria si rivoltò brusco e quasi iroso: «Davvero gli dei non tutto concedono a una sola persona: tu sai vincere Annibale, ma non sai sfruttare la vittoria!».
La mattina dopo, alla prima aurora, i soldati cartaginesi si sparpagliano per raccogliere il bottino e contemplare la spaventosa strage. Qua e là, dai mucchi di cadaveri, si alzano urlando dal dolore legionari orrendamente sfigurati, che sono subito trafitti con la spada. Altri, trovati ancor vivi con le caviglie o i femori tagliati, sono indotti a svenarsi: una crudele forma di eutanasia. È un’enorme distesa di cadaveri, ognuno freddato dove l’han portato il caso o la battaglia o la fuga. Per fortuna di Annibale, i più sono romani, pochi i cartaginesi. Tuttavia anch’egli è triste: fra i caduti, vi sono degli amici, dei soldati valorosi, dei commilitoni. Fa ricercare e trova il cadavere del console ucciso: gli rende le onoranze funebri.
Quando i censori e i funzionari romani fecero i conti, quando le supreme autorità li registrarono, quando gli storici trascrissero i dati, questi apparvero agghiaccianti: della gioventù italica erano caduti sul campo 45.000 fanti e 2700 cavalieri; 19.000 soldati erano stati presi prigionieri, molti di essi feriti: 14.500 furono conteggiati fra quelli che si salvarono con la fuga, di 5000 dispersi svanì la traccia: rientrati tardivamente nei campi forse, o forse anch’essi fuggiaschi, forse disertori, forse morti altrove. Fra i caduti, in egual numero romani e italici, i due questori dei due consoli, 29 tribuni militari su 48, 80 senatori o candidati al senato per le cariche ricoperte, 300 personalità della nobiltà patrizio-plebea. La repentina catastrofe aveva spinto Roma sull’orlo dell’abisso: in un sol giorno era andato perduto un decimo del potenziale combattente della Confederazione italica. Per tanta vittoria Annibale aveva pagato un prezzo davvero lieve: delle sue fanterie caddero 4000 celti e 1500 iberi, e solo 200 furono i morti fra i preziosi cavalieri numidi, moltissimi però i feriti. Il grande generale aveva speso con maggior larghezza la moneta per lui meno pregiata, i celti. Comunque, in un combattimento all’arma bianca fra soldati di pari valore, aveva inflitto al nemico, nonostante l’enorme inferiorità numerica, perdite nove volte superiori a quelle subite.
Il console superstite Terenzio Varrone, al quale il 2 agosto del 216 a.C. il destino aveva messo in mano la leva della decisione, abbandonò il campo di battaglia con una cinquantina di cavalleggeri. Non si mescolò alla fiumana dei fuggiaschi, ma prendendola più alla larga puntò verso Venosa, una trentina di miglia a sudovest della piana della strage. Varrone non era vile e la sua decisione di sopravvivere fu un atto di coraggio civile. Morto l’altro console, morti Minucio Rufo e Servilio Gemino comandanti della fanteria, senza di lui non sarebbe rimasto nessuno a rappre...