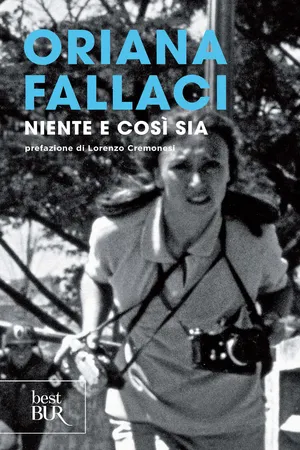Prefazione
di Lorenzo Cremonesi
«Non saprei spiegarti quando mi invaghii della guerra» scrive Oriana Fallaci riferendosi al suo primo viaggio in Vietnam nel novembre 1967. Un’affermazione che a prima vista stupisce, disorienta. Ma come? Lei che sin dalle prime battute del libro ci parla dell’orrore assurdo della guerra, che alla sorellina Elisabetta racconta del paradosso scandaloso di quando gli uomini in una parte del mondo investono sforzi infiniti e somme milionarie per salvare una vita mentre in un’altra massacrano e distruggono senza limiti, che quasi non lascia passare pagina senza descrivere l’ennesimo episodio di crudeltà inutile, come può proprio lei essere in realtà così attratta, affascinata, quasi innamorata della guerra?
La risposta è la chiave di lettura di Niente e così sia. Un libro sul Vietnam, certo. Un ritratto vivissimo del periodo precedente la caduta di Saigon, è già stato detto. Per molti versi un’opera morale di condanna a un conflitto che a sentire Oriana era già perso in partenza dagli americani, come hanno osservato in molti sin dalla prima pubblicazione nel 1969. Ma soprattutto vi si ritrova la descrizione affascinante, personalizzata eppure universale, del mestiere dell’inviato di guerra. Di continuo, rileggendolo, mi sono tornati alla memoria situazioni, discorsi, ragionamenti vissuti ripetutamente durante i miei reportage in zone di conflitto negli ultimi trent’anni. Di questa fascinazione per lo scontro all’ultimo sangue tra gli uomini Oriana discute a lungo con... con chi se non François Pelou? L’uomo della sua vita, l’amore più grande e perciò impossibile, la passione all’ennesima, nutrita di assoluto, paura, rischio, morte. Il responsabile della France Press a Saigon, che lei va a trovare subito dopo il suo arrivo. «Mi avevano detto che l’uomo da conoscere era il direttore François Pelou, così sono andata a cercarlo ed eccolo: un bel giovanotto dai capelli grigi e il corpo di atleta, il volto duro ed attento, due occhi cui non sfugge nulla, insieme dolorosi ed ironici.» Così lui irrompe nel racconto sin dalla quarta pagina del primo capitolo e ci rimane con prepotenza sempre, sino all’ultimo.
Di lui è stato detto poco. La sua figura fu poi inevitabilmente adombrata da quella di Alekos Panagulis, che la scrittrice ha immortalato in Un uomo. Ma, a sentire chi conobbe bene Oriana, era François l’uomo che lei avrebbe voluto come padre dei suoi figli, il sogno dei sogni, compagno di vita e d’avventure. Storia tipica delle situazioni di guerra la loro. Tutto è stravolto quando, ancora giovane, intorno a te impera la violenza e temi che potresti morire, o restare gravemente ferito. da un momento all’altro. E per di più per scelta, motivazione e impegno personale. In questo contesto tanto estremo anche i sentimenti cercano nuovi centri di gravità, necessitano equilibri interiori calibrati per affrontare l’eccezionale. I legami si fortificano nell’emergenza e l’esistenza corre sul filo del rasoio. Salvo poi rivelarsi inadatti, fuori luogo, incapaci di resistere una volta tornati a casa nella normalità del quotidiano.
Loro due parlano a lungo del “fascino” della guerra. Non è difficile immaginarli nei due stanzoni disordinati dell’agenzia stampa, oppure durante i momenti di relax sulla terrazza del Continental, con le notizie che si rincorrono e l’attenzione sempre pronta a recepirle, le pigne di giornali ingialliti, i rulli del telex, quell’atmosfera surreale dei locali per stranieri che hanno a disposizione fascette di dollari freschi di stampa in un Paese dove la guerra si può affrontare personalmente con qualche possibilità di successo solo con grossi somme di contante a disposizione, che diano accesso al meglio del mercato nero e permettano di ottenere permessi di ogni tipo dagli ufficiali sempre più corrotti.
Amore, guerra e morte: un classico della letteratura. E un tema ben noto ai reporter che per periodi prolungati si trovano a dover lavorare esposti allo stress del pericolo continuo. Oriana ci dice che la sua attrazione fatale per il conflitto è probabilmente emersa dopo i giorni sul campo di battaglia a Dak To. Il brivido sulla jeep che corre nelle strade deserte; i volti tesi dei suoi militari di scorta quando attraversano i villaggi distrutti e abbandonati, con il dito sempre pronto sul grilletto; oppure l’incontro con i plotoni d’esecuzione sudvietnamiti mentre fucilano i vietcong appena catturati: sta di fatto che è lei stessa a confessarcelo, «d’un tratto avvertii un sospetto terribile, poi un capogiro esaltante, e mi piacque trovarmi in Vietnam». Il legame con Pelou e l’esperienza professionale si sovrappongono. Le lunghe conversazioni tra i due sulle loro emozioni, il concetto di eroismo e il significato del rischiare la vita per raccontare il Vietnam sono parte centrale della trama. Passionale, alla ricerca del metro di valutazione per distinguere il bene dal male, laica impenitente eppure pronta a tirare in ballo il giudizio di Dio, Oriana vuole gli eroi da raccontare, sa che la bella storia giornalistica ha sempre un personaggio centrale. E in guerra sono più facili da trovare che altrove. È nelle situazioni estreme che scopri l’uomo. Osserva: «Nessuno resta insensibile all’eroismo, e l’ambiente naturale dell’eroismo è la guerra... dove esso ha un unico insostituibile prezzo: la morte».
Dunque la morte la eccita. La racconta in tutte le sue forme, in ogni dettaglio, si compiace a descriverne l’orrore, il dolore, la plasticità, l’odore e persino il colore. Si coglie un’ossessione che sembra eccessiva, quasi perversa, per il particolare delle pupille dei cadaveri diventati sentieri per le larve della putrefazione avvolti nella calura umida della giungla. C’è quasi poesia quando scrive del fumo “carnoso” del napalm, o di quando salta dall’elicottero per raggiungere l’unità dei Marines sulla collinetta appena conquistata ai nordvietnamiti e si ritrova a sprofondare coi mocassini nel cadavere in decomposizione, gonfio e molle, di un vietcong morto da tre giorni. Oppure nella descrizione del rogo «alto e trasparente» nel quale bruciano i bonzi e le sacerdotesse buddisti in segno di protesta contro il regime burattino di Washington e contro «il massacro del popolo vietnamita». È il suo modo per raccontare a chi sta a casa in Occidente cosa sia la guerra. E ha un effetto dirompente, affascinante. Non te ne staccheresti mai.
Oriana ha trovato il linguaggio giusto per il suo tempo, incisivo e accattivante, la cui magia incantatrice dura sino ad oggi. Molto facilmente, se questi reportage fossero stati scritti per il pubblico italiano ed europeo subito dopo la Seconda guerra mondiale, la loro valenza sarebbe stata minore. Un po’ come Primo Levi, che fu obbligato a pagare di tasca sua la prima pubblicazione di Se questo è un uomo al suo ritorno da Auschwitz. I lettori di allora erano stanchi di guerre, di cadaveri e orrori. Li avevano vissuti sino a poco prima. Perché avrebbero dovuto interessarsi un’altra volta a storie terribili tanto immanenti, così prossime al loro vissuto appena trascorso? Tutta un’altra cosa è la società occidentale alla fine degli anni Sessanta. Non è trascorso neppure un quarto di secolo dalla caduta di Berlino, eppure la guerra sembra ormai un fatto lontano, remoto. Il pubblico è adesso molto più aperto ad ascoltare l’epopea dei conflitti e delle sofferenze altrui. La guerra, vista come il caos della razionalità umana, come universo opposto al nostro sistema di vita regolato da leggi e autorità, raccoglie audience. Il diverso attira, specie se almeno per un attimo ci spinge a ragionare sui principi primi del nostro mondo ordinato. E oggi, quarant’anni dopo, ancora di più. Andate in qualsiasi libreria, leggete le pagine dei giornali, e vedrete che i titoli sulla guerra si sprecano. Le immagini a colori del bombardamento di Baghdad nell’aprile 2003 furono un gigantesco e plateale spettacolo. L’affabulazione di Oriana ha potenzialmente oggi ancora più pubblico di quello che leggeva le sue cronache su «L’Europeo», quando lei ancora non era quarantenne.
Questo realismo romanzato, il continuo intercalare tra cronaca e autobiografia, fornisce al testo il filo rosso e la forza di un grande libro. La nuda annotazione episodica del conflitto potrebbe ridursi a un lungo elenco di violenze, spesso simili (che differenza c’è tra il massacro causato da un carretto bomba nel cuore di Saigon 1968 e quello di un kamikaze a Kabul 2010?), inframmezzate da tedio e attesa. E infatti lo nota anche lei, specificando però il suo modo di concepire il racconto. «Poi, la noia. Graham Greene ha scritto che gran parte della guerra consiste nello star fermi senza far nulla, in attesa di qualcos’altro. Ed è vero. Ma non ha scritto che anche quando stai fermo non ti ci annoi. Perché alla guerra, vedi, non sei mai seduto in platea ad osservare: sei sempre sul palcoscenico. Fai sempre parte dello spettacolo. Perfino se bevi un caffè sulla terrazza dell’hotel Continental. Potrebbe scoppiare una mina su quella terrazza, piombare una granata: ciò ti rende partecipe di un’atmosfera eroica, ti impegna in una continua attenzione che esclude ogni forma di noia.» Ecco la differenza: lei è capace con arte e stile di comunicare l’essenza del conflitto anche nel tedio delle lunghe attese, sa sempre cogliere l’“eroico” della situazione. La noia semmai l’assale a New York, «dove le giornate schizzavano via in una corsa affannosa».
Parte e ritorna. Guerra e pace si rincorrono con ritmi schizofrenici. È un altro aspetto tipico della condizione del giornalista sul campo. Per un mese c’è e per un altro torna a casa. Dunque è partita. Se ne è andata via. Ha messo in pratica anche lei l’antica prerogativa dell’inviato di guerra che, come ben scrive Robert Fisk nella sua gigantesca autobiografia di testimone per quasi quarant’anni di conflitti in Medio Oriente, gode dell’immenso privilegio di scegliere, più o meno in ogni momento, di abbandonare gli orrori dove lavora e per di più con il calice di champagne in mano su di un volo di prima classe. Oriana talvolta in Vietnam non ne poteva più, stanca di sangue e polvere, stanca di morti inutili, di assurdità e paura. Ce lo dice in diverse occasioni. A ogni partenza. Ma appena arrivata si ritrova a seguire nervosamente le notizie che giungono da laggiù. Non ne può fare a meno. È una droga, un’ossessione. Telefona, scrive agli amici rimasti, ai contatti locali, si inventa servizi da proporre. Vuole tornare. Deve assolutamente ritornare a Saigon. Quella storia è sua. Non ne può perdere neppure un capitolo. Attenzione: non è invidia, anche se certo la indispettisce che qualcuno possa prendere il suo posto, piuttosto si tratta di essere stata completamente assorbita da una vicenda totalizzante quale è la guerra. Il resto le sembra acqua tiepida. In Vietnam viveva al cento per cento, piena, carica, al centro degli eventi. La storia era lei, non doveva neppure leggerla sui giornali. A New York o Firenze torna a esistere di riflesso, tutto ha un gusto insipido, inadeguato. Da attrice torna spettatrice. Le mancano i materassi e il nastro adesivo alle finestre per rallentare le schegge; le mancano l’adrenalina dei viaggi a velocità folle per dribblare i cecchini, il silenzio minaccioso del coprifuoco, la tensione costante, i contatti con i dirigenti sudvietnamiti, il braccio di ferro con i portavoce americani per essere embedded (accreditata e aggregata) alle unità impegnate nelle prossime operazioni belliche. Chi va e ama le storie dal fronte può ben capire queste emozioni.
Certo c’è il pericolo che tutto questo divenga droga, assuefazione al puro rischio in quanto tale, come quei fotografi (perlopiù francesi e americani) che si incontravano a Beirut negli anni Ottanta e la sera non andavano a letto soddisfatti se almeno una pallottola non gli era fischiata vicino al cranio anche quel giorno. Sono personaggi fac...