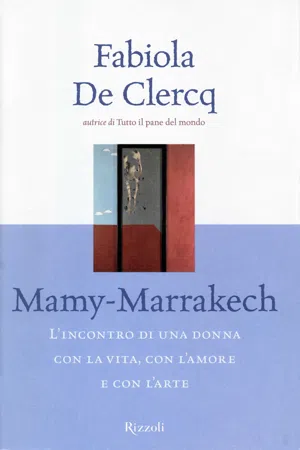«SONO UNA PARALUMAIA»
AVEVO DECISO DI ASPETTARE ancora un paio di mesi prima di portare Luca alla scuola materna. Pensavo che crescendo ancora avrebbe tollerato meglio la mia assenza. Cercavo di elaborare questa prima separazione. Attendere qualche tempo dopo l’inizio della scuola significava inserirlo quando i bambini avrebbero pianto meno e proporgli così un ambiente più tranquillo e pacificato.
Ero consapevole della mia difficoltà a separarmi da lui, non mi sentivo pronta. L’inizio dell’asilo, lo sapevo bene, era una tappa per entrambi.
A metà novembre Luca aveva tre anni. Era entrato all’asilo senza difficoltà, le maestre erano disponibili, meno stremate dei primi giorni. Il pianto contagioso dei suoi piccoli compagni si era ridotto, ormai giocavano allegramente sotto i pini di un parco romano.
I primi giorni, nonostante tutto, non riuscivo ad allontanarmi molto dal cancello, pronta ad andarlo a riprendere se avessi riconosciuto il suo pianto. I suoi sorrisi all’uscita non mi rassicuravano del tutto.
Ora dovevo fare i conti con il tempo che inaspettatamente avevo a disposizione. Avevo dovuto rifiutare una possibilità di lavoro all’Ansa, Giorgio non voleva che io la prendessi in considerazione.
Una mattina ero entrata senza esitazione nel negozio di arredamento più importante di Roma. «Sono una paralumaia»: sentivo uscire queste parole dalla mia bocca senza neanche avere pensato al loro effetto. Mi stavo rivolgendo al proprietario dello show-room, un architetto milanese, di cui tutta la città parlava. Dopo pochi minuti ero uscita con un’ordinazione di dodici paralumi. Non li sapevo fare. Non ne avevo fatto neanche mezzo da sola.
Un’avventura totale e drammatica. Per quattro giorni non avevo ceduto allo sconforto, ero rimasta fino a tarda notte china sul tavolo da lavoro improvvisato. Un lavoro complesso, il primo paralume doveva essere cucito a mano e a macchina. Non avevo mai cucito, meno che mai a macchina, e non mi piaceva doverlo fare. La stoffa che mi era stata data era bianca e trasparente. I piccoli quadri che formavano la trama della stoffa, leggera come quella di una camicia, dovevano essere perfettamente allineati.
Cucivo e scucivo incessantemente, dovevo farcela. Avevo recuperato una vecchia macchina da cucire che non ero capace di usare. Non sapevo neanche come si infilasse l’ago. Scendevo dalla portiera ogni volta che si sfilava. Nel frattempo nuove ordinazioni fioccavano: le prendevo tutte guardandomi bene dal rivelare la mia inesperienza. Avevo deciso e basta, era questa la sola certezza su cui potessi contare. L’angoscia di non rispettare i tempi di consegna faceva da contraltare all’entusiasmo.
La tecnica era spietata. Bisognava calcolare il diametro, nel tempo sarei diventata una calcolatrice vivente di diametri. Un millimetro moltiplicato per 3,14 era una catastrofe. La precisione doveva essere totale. Tagliare al millimetro il cartoncino per paralumi, stenderlo sul tavolo con le puntine, attenta ai buchi, applicare la stoffa sul cartone ricoperto di colla liquida, stesa velocemente e in modo omogeneo con una spugna, appoggiandola lentamente senza bagnarla – per nessuna ragione –, poi fissarla per sempre con il ferro da stiro tiepido. Trattenevo il fiato, staccavo il telefono, per qualche minuto nessuno poteva avvicinarsi a me.
La stanza dove lavoravo era pulita come una camera operatoria. Dovevo combattere con i peli della lana scura sospesi nell’aria, che potevano depositarsi tra il cartone immacolato e la pura seta bianca.
Un paralume ospita una lampadina che denuncia qualsiasi traccia, qualsiasi ombra di sporcizia. Anche un innocuo pelo in sospensione diventa una catastrofe, e poi è tutto da rifare. Con lo sconforto di chi si è assunto un compito più grande di sé sempre incombente, minaccioso. Tenuto a distanza dalla mia determinazione a fare un lavoro perfetto.
Mio figlio aveva solo tre anni, ma aveva visto arrivare il mio nuovo lavoro come un rivale che spostava altrove la mia attenzione.
In pochi attimi aveva distrutto il rivale. Aveva tagliato minuziosamente il mio primo capolavoro con le forbici che non aveva ancora mai toccato. A modo suo lo aveva tagliato con la stessa creatività che avevo messo nel mio lavoro. I tagli erano delle frange perfettamente uguali, senza sfaldature.
Ero incredula e furente allo stesso tempo. Mi ero arrabbiata così tanto che pensavo di non riprendermi più.
Quella stessa sera avevo ricominciato tutto. Avrei stroncato sul nascere la possibilità di diventare paralumaia se non avessi ricostruito il paralume quella notte. All’alba era pronto, perfetto e incartato nella carta velina immacolata, quella che usano gli orefici. Ogni paralume era un gioiello.
Una mattina Giorgio mi chiede di salire al piano superiore della nostra casa, l’ultimo di una palazzina ai margini di Villa Borghese. Vuole mostrarmi qualcosa, dice; salgo senza averne voglia, sono anni che non vado lassù.
È tutto cambiato, ma non capisco ancora in che modo. Giorgio mi porge una chiave, i suoi occhi sorridono, e riconosco qualcosa nel suo sguardo. Capisco sempre di meno mentre guardo una porta nuova in ferro grigio scuro, laccata di fresco.
Mentre la porta si schiude, appare una stanza piena di sole appesa nel cielo, lambita dai pini marittimi e da due palme piene di datteri. Il pavimento è ricoperto da una moquette carta da zucchero, le pareti bianchissime, una porticina nasconde un piccolo bagno con una doccia. Sotto alla finestra del mio laboratorio, un tavolo da lavoro grande, illuminato da una lampada orientabile. In mezzo alla stanza, tra le due finestre, una porta a vetri si apre sul grande terrazzo che domina i pini scuri e folti di Villa Borghese.
Mi era stato appena regalato uno scrigno. Al suo interno, un atelier formidabile ricavato nel tetto che per anni mi avrebbe dato una pace e una felicità intensa ogni volta che ci avrei messo piede.
Dopo qualche mese ero diventata capace di creare qualsiasi paralume, di calcolare le proporzioni in rapporto alla lampada. Era quest’ultima la difficoltà maggiore di questo mestiere. Le dimensioni di un paralume non devono ridurre l’importanza della base ma rispettare un equilibrio con essa.
La sfida era vinta, nonostante ogni creazione fosse un’incognita. Lavoravo per i negozi più importanti di Roma. Ogni mattina partivo a ritirare le armature dei paralumi che ordinavo per telefono a un artigiano di Campo de’ Fiori. Attraversavo la città passando sopra il Tevere e infilandomi nel cuore di Roma. I vicoli stretti e rastremati, intasati da ogni sorta di mezzi dove non è permesso sostare, lui che mi aspetta, sempre incredibilmente puntuale, spostando biciclette, motorini e scatoloni di cartone per farmi posto. Il cappuccino bollente arriva insieme a me, al vetro, nel bicchiere dei bar di Campo de’ Fiori.
Nel laboratorio di via dei Balestrari ho un posto, il mio posto, sono attesa tutti i giorni con la stessa modalità. Dieci metri quadri in un vicolo buio e stretto, tra i rumori quasi insopportabili della mola e del martello, la polvere di ferro, per dieci anni un appuntamento con il mio desiderio di vivere.
Ho persino il mio sgabello, è stato comperato per me, ogni giorno mi si dice che è solo per me. In paglia e legno, molto alto, compare appena entro. Quando vado via viene coperto da un foglio di plastica e nascosto sotto un tavolo del laboratorio. La stufetta elettrica viene accesa al mio arrivo per trattenermi, dal momento che ho sempre freddo.
Moreno batte il ferro, lo salda e lo passa nella mola per cancellare le bave. Mentre lavora si impegna a farmi ridere raccontandomi in dialetto, da attore consumato, eventi della sua vita, della vita del quartiere di cui conosce ogni segreto. Ogni giorno ho il sospetto che non termini il lavoro affinché mi fermi a chiacchierare con lui. Siamo giovanissimi entrambi, ci diamo del lei. È essenziale proteggere quest’amicizia dalla banalità, è prioritario distinguerla da altri rapporti. Moreno passa al tu con chiunque mi accompagni. Nel tempo ci accorgiamo – non perde occasione di dirlo – che l’uso del lei restituisce al nostro rapporto qualcosa di molto speciale.
Quando Moreno si ostina a rifinire le armature a oltranza, sono costretta a scappare dall’analista che nel frattempo da piazza del Gesù ha spostato lo studio a pochi passi da Campo de’ Fiori.
Quando guardo l’orologio capisce, si ferma, mi osserva interdetto mentre scappo. Un’ora dopo, spesso sconvolta dalla seduta, torno. Moreno non dice niente, il suo tatto è toccante, la sua sensibilità e educazione mi arrivano al cuore.
È una fortuna per me avere la seduta a pochi metri da lì, ci vado a piedi. Per anni, tre volte alla settimana, si ripete la stessa scena.
Quando ero andata alla Società di psicoanalisi, avevo chiesto un’analista sotto casa. Per anni avevo inseguito analisti che avevano lo studio in quartieri diffìcili da raggiungere. Il traffico romano e la distanza richiedevano un tempo infinito per attraversare la città. Avevo un bambino piccolo al quale mi sembrava di rubare il tempo che passavo in macchina.
L’avevo trovata vicina, la mia nuova analista, e questo cambiamento era per me molto comodo. Poco più di un anno dopo, però, il suo trasferimento a piazza del Gesù, dove aveva lo studio in casa sua.
A qualche metro dal portone c’era la sede della Democrazia Cristiana. Andavo lì da pochi mesi, quando ci fu il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta. La stampa e la televisione del mondo intero parlavano dell’evento. Piazza del Gesù era presidiata dalla Polizia e dai militari.
Per andare alle sedute dovevo passare tre, quattro volte a settimana i blocchi di polizia. Attraversare il quartiere e arrivare puntuale era ogni volta una scommessa. Molte automobili venivano perquisite e, nonostante avessi una macchina molto piccola, spesso mi chiedevano di aprire il bagagliaio.
Arrivavo a piazza del Gesù e cercavo un posto per la macchina sotto la scalinata della chiesa, dove giovani militari con gli scudi in plexiglas proteggevano la sede della De. Era il mio aspetto, probabilmente, che li spingeva ad aiutarmi a trovare una soluzione veloce per il posteggio. Parcheggiavo spesso senza tenere conto dei divieti. Mi vedevano scendere senza dire niente. Pensavo che fossero ipnotizzati dal mio aspetto fisico. Molte volte al ritorno dalla seduta trovavo la mia macchina spostata, l’avevano sollevata e parcheggiata contro i gradini della chiesa. Li ringraziavo con un’occhiata e un cenno della testa per non metterli in imbarazzo.
Mi chiedevo che idea si potessero fare del mio stato, era una domanda che d’altronde mi ponevo spesso in molte circostanze. Il mio disagio non era conosciuto come ora. Molti anni fa non aveva un nome, non aveva un’identità.
Anni dopo Moreno mi racconterà sorridendo di essersi tormentato per scoprire quale sofferenza avessi e mi confesserà di avermi seguita in motorino fino sotto il portone dell’analista dove mi infilavo furtivamente, vinto da una curiosità che non conteneva più, ma di non aver capito niente. Mai uno sguardo che non fosse affettuoso, mai un’allusione alla mia magrezza. Non avrei avuto alcuna difficoltà a dirgli qualcosa se non avessi avuto paura dei pregiudizi che forse anche lui aveva nei confronti della psicoanalisi. Ero costretta a sostenere con tutti l’utilità della terapia che facevo, non ero tenuta a farlo con lui.
Questo giovane poco più che ventenne, già sposato e con due bambini, mi ha trattata come una ragazza, normale, regalandomi momenti di formidabile leggerezza.
Le sedute di psicoanalisi incominciavano nella sua bottega. Non lo ha mai saputo, non lo sapeva neanche l’analista, alla quale non raccontavo niente di questi momenti. Forse non lo sapevo nemmeno io.
Non sapevo ancora quanto fosse importante per il mio equilibrio il tempo passato nella bottega.
Tornavo a casa da Campo de’ Fiori con la macchina piena di armature senza le quali non potevo lavorare. Dovevo attraversare per qualche metro la grande piazza durante le ore di mercato. Ero costretta a inoltrarmi in mezzo ai banchi di pesce, non c’erano altri modi di uscire dal labirinto dei vicoli intorno a piazza Farnese. Quasi ogni volta, il muso di un pesce spada entrava nella macchina dal finestrino. Le donne che lo vendevano scansavano come se niente fosse le cassette di legno, si creavano immediate complicità per eludere il controllo del vigile.
Con il tempo ero riuscita a curare anche l’aspetto elettrico delle lampade per rendermi del tutto autonoma dagli artigiani. Luca aveva imparato ad avvitare le rondelle di ottone sulle canne filettate nelle quali si infilava il filo elettrico. Qualche volta si sedeva per terra e voleva aiutarmi. Le manine impanavano i piccoli dadi sulle canne filettate e ottonate sulle quali si avvitava il portalampada e infine anche il paralume. Così per qualche minuto si stava insieme nel mio laboratorio. Luca saliva e scendeva quando aveva bisogno di me. Talvolta si sedeva sullo sgabello e disegnava su uno dei tavoli da lavoro.
Avevo imparato a bucare con la punta del trapano la ceramica e il vetro, il rame e l’ottone. Passavo pressoché ogni giorno qualche ora nel ghetto dove si trovavano quasi tutte le mercerie e ferramenterie che vendevano all’ingrosso. Con il motorino rastrellavo i meandri del quartiere cercando nuove botteghe che potessero contenere soluzioni per snellire il lavoro.
Ogni tanto andavo da Carlo Ugolini. Era nella sua bottega buia nei pressi del Pantheon che mi calavo nei segreti dell’artigianato dei paralumi. Carlo era piccolo, stempiato e vivace per i suoi anni. Tra la sorpresa e la curiosità per tanta determinazione, mi accoglieva e mi cedeva i segreti del mestiere. Era affettuoso e generoso con me. Nel suo laboratorio, la testimonianza di ogni lavoro eseguito fin da ragazzo, quando aveva iniziato la sua attività. Erano cinquantanni che...