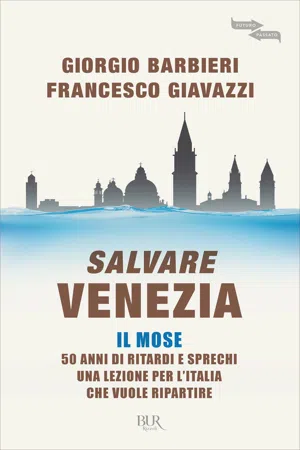La laguna è a rischio
La Repubblica di Venezia ha da sempre dovuto fare i conti con il precario equilibrio tra terra e mare. Una sola certezza: salvaguardare la laguna ha significato, nei secoli, salvare Venezia stessa, perché lo specchio d’acqua che separa la città dalla terraferma l’ha resa praticamente inespugnabile.
Certa dunque di non essere minacciata via terra, la Repubblica fu libera di allestire una potente flotta, che le permise di estendere il suo dominio sui mari fino al Mar Nero e all’Egeo.
L’unico pericolo che poteva venire dalla terraferma era rappresentato dai fiumi che sfociavano in laguna: il Brenta, il Sile e il Piave, le cui esondazioni vi trasportavano sabbia e altri detriti che col tempo, come è accaduto poi a Ravenna, rischiavano di trasformare la laguna in una pianura fangosa.
Nella sua Historia Langobardorum, una storia del popolo longobardo, scritta nell’abbazia di Montecassino fra il 787 e il 799, Paolo Diacono descrive gli effetti dell’esondazione dell’Adige e osserva che a causa di «un diluvio d’acqua [...] che si ritiene non ci fosse stato dal tempo di Noè, furono ridotti in rovina campagne e borghi, ci furono grosse perdite di vite umane e animali. Furono spazzati via i sentieri e distrutte le strade; il livello dell’Adige salì fino a raggiungere le finestre superiori della basilica di San Zeno martire, che si trova fuori le mura della città di Verona [...]. Anche una parte delle mura della stessa città di Verona fu distrutta dall’inondazione».1
Preoccupato che qualcosa di simile potesse accadere a Venezia, il Senato della Repubblica il 16 febbraio del 1330 promulgò una legge per la conservazione della laguna. Il problema più urgente erano il Brenta e il suo delta; il fiume scaricava in laguna grandi quantità di detriti, ostruendo i canali e inibendo la navigazione. Nel 1336 iniziarono gli interventi e venne scavato un canale per deviare le acque dal corso originale così che sfociasse lontano da Venezia. Tre anni più tardi venne poi realizzata la prima grande opera: un lunghissimo argine che aveva il compito di sbarrare la foce del Brenta, dei suoi alvei e di altri corsi d’acqua, convogliare in un canale artificiale le acque e spostare in questo modo a ovest la nuova foce del fiume.
Questi primi interventi però non furono risolutivi per il problema dei detriti, i canali spesso si ostruivano e l’acqua esondava ritornando in laguna. Poiché «i progetti dei secoli precedenti non davano sufficiente garanzia, il Maggior Consiglio diede ordine a Gianluigi Gallesi, nel 1604, di sistemare definitivamente il problema Brenta. L’architetto si mise subito all’opera e il suo progetto vide la luce nove anni dopo, nel 1613, quando venne inaugurato il Taglio Nuovo del Musone. L’intervento seguiva la vecchia politica della divisione dei fiumi per ridurne la forza e l’impeto, e questa volta non fu da meno. Vennero creati il Muson Vecchio e il Muson dei Sassi e le loro acque convogliate nel Brenta. A Mira, dove avveniva la confluenza tra i tre fiumi, venne costruito un nuovo canale, che portava le acque fino a Chioggia. Lo stesso procedimento venne utilizzato per il Piave. L’architetto nominato fu Sebastiano Benoti. Nel 1642 venne costruito un grande Argine de Intestadura, nelle vicinanze di Musile, con un canale che spostava la foce ancora più a nord. Il sistema non durò molto, ebbe un grosso problema nel 1683 e questo fece decidere per un ulteriore intervento che, oltre al Piave, allontanò pure il Sile dalla laguna. Fu così che Brenta, Adige, Piave e Sile vennero definitivamente dirottati verso il mare aperto lasciando così intatta la laguna. Senza questi interventi poderosi e assai invasivi, Venezia sarebbe stata sepolta dai detriti naturali e oggi sarebbe una comunissima città di terra. Invece il governo della Serenissima investì una fortuna nella tutela della laguna, cambiando il corso dei fiumi e costruendo canali. È grazie a queste opere, costosissime per l’epoca (anche per la loro manutenzione), che Venezia come oggi la conosciamo sopravvisse nella sua straordinaria e unica bellezza».2
Indro Montanelli considerò il salvataggio della laguna un’impresa non inferiore, per dimensioni e portata, allo scavo del canale di Panama: «Quel miracolo fu dovuto in parti uguali all’abnegazione del popolo, alla sagacia dei governanti e alla coscienza di una burocrazia che per il proprio dovere sapeva rischiare non soltanto il “posto” ma la pelle (i veneziani di allora erano gente seria e avevano la forca facile)».3
Nel 1817 lo storico Jacopo Filiasi scrisse che i lavori per deviare il corso del Piave erano durati vent’anni e costati 800.000 ducati,4 uno sforzo economico enorme per l’epoca. È quindi possibile azzardare, seppure in maniera molto indicativa, un confronto tra l’investimento effettuato dalla Repubblica di Venezia secoli fa e quello dei governi italiani degli ultimi quarant’anni per realizzare il MoSE: allora si trattava di difendere la laguna dai pericoli che provenivano dalla terraferma, oggi dalle insidie del mare. Un utile strumento di paragone è il salario di maestri e lavoranti della Scuola di San Rocco. Lo storico Brian Pullan, nel suo articolo Wage-earners and the Venetian Economy, 1530-1630, afferma che nel 1630 i maestri avevano un salario annuale di 126 ducati, mentre i lavoratori si fermavano a 87.5 Ne consegue che il costo per la deviazione del Piave rappresentò circa 9125 anni di lavoro di un lavorante della Scuola di San Rocco nel 1630.
Ora spostiamoci ai giorni nostri: il reddito medio di un operaio è di 23.000 euro lordi l’anno. La spesa definitiva per la costruzione del MoSE, che attualmente ammonta a 6,4 miliardi di euro circa, equivale a quasi 280.000 anni di lavoro di un lavoratore dell’industria. Questo confronto, seppur con tutti i limiti del caso, dimostra come i lavori per la costruzione delle dighe mobili siano costati oltre trenta volte la monumentale deviazione del fiume Piave di cinque secoli fa.
Un altro metro di paragone può essere il reddito pro capite. Luciano Pezzolo, professore di Storia a Ca’ Foscari, ipotizza che nella Repubblica di Venezia del 1670 si aggirasse intorno ai 40 ducati l’anno.6 Utilizzando questo parametro la deviazione del Piave sarebbe costata l’equivalente del reddito annuo medio di 20.000 cittadini veneziani. Posto che il reddito medio oggi si aggira sui 21.000 euro, la costruzione del MoSE rappresenta una spesa corrispondente al reddito annuo medio di un numero di cittadini oltre dieci volte maggiore: quasi 305.000. Come si può vedere, anche utilizzando criteri diversi, le dighe risultano essere un investimento molto più oneroso della deviazione di un fiume avvenuta secoli fa.
Da questi episodi della storia della città si traggono due insegnamenti. Primo: la laguna è un ambiente naturale molto delicato, senza le grandi opere della Repubblica, Venezia, come la conosciamo, non esisterebbe, come non esiste più la Ravenna immersa nell’acqua di epoca romana. Sarebbe probabilmente una città come Treviso, lontana dal mare. E non basta evitare che la laguna si riempia di detriti: occorre far sì che resti viva, e ciò è possibile se l’acqua affluisce e poi defluisce nel mare. E questo la Repubblica lo aveva capito molto bene. Il secondo insegnamento è più una curiosità: come fece l’architetto Gallesi in soli nove anni – e con i mezzi dei primi decenni del Seicento – a deviare un fiume delle dimensioni del Brenta, spostandone la foce fino a Chioggia? Con quali risorse economiche, con quali tecniche di aggiudicazione degli appalti, con quale sistema di controlli da parte della Repubblica?
Come la Serenissima sconfisse la peste
A metà del XIV secolo, attraverso le vie carovaniere e navali, la peste fece il suo ingresso in laguna proveniente dalla colonia genovese di Kaffa (l’odierna Feodosia), in Crimea, che era assediata dai tartari. L’epidemia era giunta dalla Mongolia lungo la via della Seta e si era diffusa tra gli assedianti che avevano poi gettato con le catapulte all’interno delle mura alcuni cadaveri di appestati.
Fuggiti per mare, i coloni intrapresero un’odissea fino al porto di Messina. La città dello Stretto li lasciò sbarcare, ma ben presto il morbo cominciò a fare vittime anche lì. Allontanati dalla Sicilia, i superstiti fecero rotta verso Genova, ma la loro stessa città li respinse. Marsiglia, invece, concesse loro ospitalità e in breve tempo la peste fece il suo ingresso a Venezia dove i morti, su un totale di 110.000 abitanti circa, furono, a seconda delle stime, fra 38.000 e 70.000.7
La provenienza del contagio fu evidente, così come la sua diffusione, avvenuta per il tramite di mercanti e marinai che avevano contratto la malattia. In un primo tempo come unico rimedio venne utilizzato la fuga dalle città. «Ogni rapporto umano e ogni relazione sociale furono stravolti dal terrore, che minò la stabilità socio-economica e gli equilibri politici» ha scritto Nelli-Elena Vanzan Marchini, presidente del Centro italiano di Storia sanitaria e ospedaliera del Veneto. Processioni, fiere, mercati e riti pubblici furono sospesi, in quanto occasioni di contagio. Si inchiodarono le porte delle case degli appestati e si chiusero interi quartieri.
Tra il XIV e il XV secolo, l’epidemia di peste si ripresentò in più occasioni. Nel 1423, dopo che in tre mesi si raggiunsero i quaranta decessi al giorno, il Senato decise di blindare i confini, bloccando l’ingresso a forestieri e mercanti provenienti dai territori contagiati. I capitani di nave avevano l’obbligo di denunciare i malati, pena sei mesi di carcere, 100 lire di multa e cinque anni di sospensione dalla carica, e fu stabilito il divieto di accogliere gli infetti. Ma, soprattutto, fu creato il primo lazzaretto della storia: una struttura ospedaliera pubblica ad alto isolamento sull’isola periferica di Santa Maria di Nazareth, al quale ne seguì nel 1468, un secondo detto «Nuovo», in cui venivano tenuti, per un periodo di contumacia, sia i guariti sia quanti erano entrati in contatto con luoghi e persone infette.
In questa fase venne anche creata la cosiddetta «polizia sanitaria marittima» che obbligava le imbarcazioni sospette di avere a bordo dei malati a ormeggiarsi nei canali di Fisolo e Spignon, tra la bocca di porto di Malamocco e l’isola di Poveglia, mentre gli infetti erano costretti a una quarantena (veneziano per quarantina) di giorni nell’isola di Santa Maria di Nazareth.
Per la gestione dei due lazzaretti fu creato, nel 1486, un organo apposito, il Magistrato alla Sanità – composto da tre patrizi eletti ogni anno, un ufficio tecnico, un protomedico e un braccio armato – che monitorava l’andamento dei flussi epidemici attraverso una rete di diplomatici e le sue «spie di sanità».
In una città come Venezia, infatti, non era semplice raccogliere in maniera tempestiva le informazioni su tutti i casi sospetti, perciò si incoraggiavano le denunce segrete, firmate e convalidate da due o più testimoni, che in un primo momento venivano infilate sotto la porta della sede del Magistrato, poi imbucate in apposite caselle. Già dal Trecento per le strade di Venezia e sulla terraferma erano state poste le cosiddette «bocche di leone», bassorilievi raffiguranti il muso dell’animale allegorico dove si inserivano le lettere. Il denunciante, la cui identità rimaneva segreta, veniva ricompensato con una percentuale sulla sanzione pecuniaria che il reo era chiamato a corrispondere. In rari casi si accettavano anche denuncie orbe, cioè anonime, come quella che nel 1576 smascherò alcuni ministri del lazzaretto che facevano uscire e vendevano oggetti dei ricoverati, e dunque potenziali veicoli di trasmissione dell’infezione, mettendo in pericolo la salute dei cittadini.
La rete di controlli messa in atto dalla Serenissima assurse a modello, per altri Stati, nella prevenzione del contagio epidemico. Ad esempio il Magistrato alla Sanità inviò alcuni suoi uomini per verificare l’insorgere dell’epidemia a Salisburgo nel 1553, a Mantova e a Trento nel 1576 e a Marsiglia nel 1720, prima che la pandemia dilagasse in tutta la Provenza. Queste operazioni, che oggi definiremmo «di intelligence», avevano lo scopo di bloccare preventivamente le vie di terra e di mare e isolare i focolai dell’infezione. Ne è la prova il fatto che dal 1630 la peste, pur continuando a flagellare fino al XIX secolo i Paesi con cui Venezia intratteneva rapporti commerciali, non fece più la sua comparsa in laguna.
In conclusione, il controllo della peste mediante misure atte a prevenire il contagio fu introdotto in Italia, e segnatamente a Milano e a Veneiza, nel XV secolo, prima che nell’Europa del Nord, dove queste misure vennero introdotte nel secolo successivo.8
La terra sfida il mare
Ai tempi della Repubblica, come ai giorni nostri, in laguna si scontravano forti interessi sociali ed economici. Da una parte il «partito della mercatura», che, come spiega il professor Luigi D’Alpaos, vedeva nella tradizione marinara e nel commercio per mare il futuro della Repubblica. Dall’altra il «partito degli agrari», che esaltava il ruolo dell’agricoltura come decisivo per il destino di Venezia, grazie alla conquista di nuove terre da bonificare e coltivare, in modo da rendere maggiormente autonoma la Repubblica soprattutto dal punto di vista alimentare. «Non va da ultimo sottaciuto» continua D’Alpaos «che le opere della bonifica si prestavano a facili operazioni speculative da parte della ricca aristocrazia veneziana, soprattutto per il massiccio afflusso di danaro pubblico che poteva essere convogliato sugli interventi volti a redimere le terre paludose dalle acque. La storia racconta che vinsero le ragioni del mare su quelle del “retrazar”, cioè della bonifica.»9
Il regolamento delle acque della laguna era materia talmente centrale per gli equilibri economici e politici della Repubblica che, nel 1505, si ritenne necessario istituire un Collegio solenne cui affidare tutte le decisioni. Nacque così il primo Magistrato alle Acque, un organo con una forte autonomia e rigide regole per impedire eventuali conflitti d’interesse, che aveva competenza sulla manutenzione delle acque lagunari e dei fiumi che vi sfociavano. Lo storico Piero Bevilacqua spiega che «una delle singolari prerogative del Collegio solenne sopra le acque fu la facoltà di eleggersi i membri che di volta in volta erano chiamati a dirigerlo, a testimonianza del potere assegnato a tale Magistrato e della relativa indipendenza operativa di cui esso godeva all’interno delle istituzioni veneziane». Si ritenevano così importanti l’indipendenza e l’assoluta autonomia di giudizio del Magistrato «che a comporlo furono dichiarati inabili tutti i nobili che possiedono beni, che possano anteporre il proprio al pubblico bene». Il 22 aprile 1527, al fine di mantenere costantemente distinto il «pubblico servizio» dall’interesse privato, venne deliberato di scegliere tra i membri del Senato tre nobili con il compito di sostituire i provveditori nel caso questi avessero «beni, o padre, figlioli, fratelli, suoceri, generi, germani et cuginati [...] che fussero interessati nel Retrato (consorzio) che si facesse».10
Un sistema ferreo, quello del Cinquecento, disegnato per evitare possibili conflitti d’interesse, che dimostra come la salvaguardia della laguna fosse un tema centrale nelle politiche della Repubblica, da affrontare al riparo dalle pressioni delle lobby economiche che esistevano anche all’epoca. Con una particolarità decisiva: per chi «sgarrava» la sanzione era immediata. «Le varie magistrature inventate dai veneziani nel corso dei secoli» aggiunge Bevilacqua «sono organismi particolari di controllo e di indirizzo improntati, nel loro funzionamento, a quel criterio di collegialità e temporaneità delle cariche che costituisce un e...