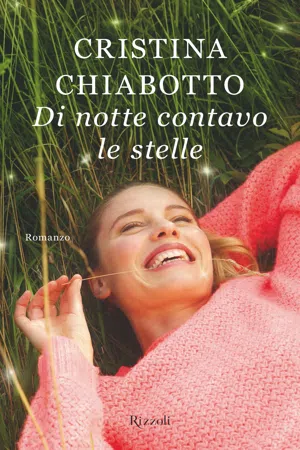![]()
1
Il malocchio
Nonna Maria toglie il malocchio. Non sa leggere né scrivere, sa fare solo la sua firma, ma sa togliere il malocchio. Ogni volta che vado da lei, le chiedo di praticarmi la formula magica. Allora si mette in piedi di fronte a me, mi tocca la fronte tre volte, la cima della testa e la nuca, e per tre volte recita in un bisbiglio: «Io te sciopero ra capo a’ pere, chi t’è fatt’ male te pozza fa’ bene. Uocchio contruocchio mittingill a’ l’uocchio, schiatta riavol e crepa l’uocchio!».
Poi si arrotola una ciocca intorno all’indice destro e tira forte. Se si sente uno schiocco secco vuol dire che avevo il malocchio e lei me l’ha tolto, altrimenti tra le dita le resta solo qualche capello: «C’hai dormito sopra, ce l’avevi da ieri. Adesso puoi star tranquilla, però se non te lo facevo e ci dormivi sopra un’altra notte ti alzavi distrutta, non c’avevi forza, figlia mia».
Alla fine mi sorride e mi dà un bacio sulla fronte.
Da quando la mia vita è cambiata, i miei capelli schioccano quasi sempre. Sono sotto lo sguardo di così tante persone che è impossibile non attirare invidie, pensieri negativi e frustrazioni. Ora ci ho fatto l’abitudine, ma per un paio d’anni ho sofferto parecchio. Lontana da casa per 330 giorni l’anno, è stato difficile mantenere un equilibrio. La famiglia, la casa, il paese: è da qui che vengo ed è qui che torno quando ho bisogno di fare il punto, fermarmi, rimettere ordine. E funziona, funziona sempre.
Come Dorothy nel Mago di Oz, per tornare a casa mi basta battere i tacchi tre volte e dire la formula magica: «Nessun posto è come casa mia, nessun posto è come casa mia, nessun posto è come casa mia…».
![]()
2
Casa dolce casa
Sembrava che le pareti del bagno mi crollassero addosso. Mi guardai intorno e riconobbi la piastrella scheggiata sul muro di destra, la terza dall’alto, con la scritta minuscola a matita: MARTA 4ª C SEI LA PIÙ FIGA, e la macchia ingiallita sul pavimento sotto i miei piedi. Ero seduta sul water e contavo i minuti che mancavano alla fine dell’intervallo. Se potevo mi chiudevo sempre nello stesso bagno, l’ultimo in fondo a sinistra, quello che veniva usato di meno, forse perché era il più lontano dall’entrata. All’inizio dell’intervallo era scoppiato un putiferio, la prof. di latino ci aveva dato la possibilità di scegliere tra due date per la versione e la classe si era spaccata a metà, un gruppo voleva posticiparla il più possibile, un altro voleva anticiparla per non sovrapporla al compito di matematica. Alla fine qualcuno aveva proposto di fare per alzata di mano. Mi ero tenuta in disparte per tutta la discussione, ora avrei dovuto schierarmi. Senza che nessuno mi vedesse, sgusciai fuori dalla classe e mi nascosi in bagno, pensando che così avrebbero votato e io me la sarei scampata. Lo facevo sempre, quando bisognava fare un passo avanti scappavo e mi nascondevo. Non me la sentivo proprio, preferivo far parte della tappezzeria.
«Signora, sua figlia è davvero una brava ragazza» si complimentava suor Maria quando mia mamma andava al ricevimento. Ma io avrei voluto essere diversa, più sveglia e sfacciata. La scuola poi non mi aiutava: era un istituto femminile, che frequentavo fin dalle elementari. In alcuni momenti mi sembrava di trascorrere il mio tempo in una prigione invece che in una scuola, e avrei solo voluto scappare da lì per non tornarci mai più.
Avevo sedici anni, appena suonava la campanella le mie compagne si precipitavano al parchetto dietro l’edificio a truccarsi, a raccontarsi storie di baci da film e a parlare dei maschi che vedevamo all’uscita. Io le guardavo da lontano, restando in disparte.
Il mondo si era ribaltato e io senza accorgermene ero rimasta a testa in giù.
Un giorno, durante l’intervallo, origliai la conversazione tra due mie compagne.
«Guarda quella.»
«Sembra una vecchia, con quegli orecchini.»
«E poi qualcuno dovrebbe dirle che esistono i reggiseni.»
«Anche se è piatta come una tavola da surf.»
«Appunto, proprio per quello se lo dovrebbe mettere, così lo riempie con qualcosa e può far finta di averle!»
Fu una pugnalata. Mi sentivo così bella nel vestito nuovo turchese, mamma mi aveva prestato i suoi orecchini pendenti e credevo che un cambio di look mi avrebbe aiutato a essere considerata dal gruppetto delle più popolari. Invece mi freddarono con risatine e occhiatacce. Feci finta di non sentire, ma dentro di me ero in fiamme e bruciavo di vergogna. Non sapevo come reagire, non avevo parole taglienti da rifilare, non ero capace di menare le mani. Mi appiccicai un sorriso sulla faccia per il resto della giornata, a rischio di sembrare stupida.
Appena arrivai a casa mi precipitai in camera senza neanche salutare i miei, chiusi la porta a chiave e sprofondai la faccia dentro il cuscino.
Mia madre mi seguì, e iniziò a chiamarmi da dietro la porta.
«Tesoro, cosa succede?»
«Niente mamma, lasciami stare.»
Mamma non avrebbe mai lasciato stare, era una guerriera di luce. Ogni tanto mi sarebbe piaciuto che fosse andata lei a scuola al posto mio. Avrebbe sicuramente saputo come sistemare tutte quante, con il suo mantello e la spada di Guerre Stellari.
«Guarda che se non apri butto giù la porta.»
Sapevo che l’avrebbe fatto. Mi alzai, diedi un giro alla chiave e mi rituffai a letto a faccia in giù, mi vergognavo.
Mamma non disse nulla, si sedette accanto a me e mi accarezzò la testa piano. Mi sentii subito meglio, come se in tutto il mio corpo scorresse un liquido caldo.
«Dài, amore, cosa ci sarà mai di così tremendo?»
Non risposi, le parole mi si seccavano in gola, non volevo darle il dispiacere di sapere che la scuola, che lei stessa aveva scelto e che credeva essere il posto migliore dove farmi studiare, era popolata da perfide streghe a cui non piacevo affatto e che facevano di tutto per escludermi.
La mia condizione di emarginata era peggiorata dal fatto che abitavamo in provincia. Ogni giorno papà accompagnava in auto me e Sofia e ci veniva a prendere all’uscita, così non potevo mai fermarmi fuori con le compagne.
«Mamma, voglio restare a Torino dopo la scuola.»
«Tesoro, sai che non è possibile. Come facciamo con Sofia? Papà non può venire a prendere lei, tornare a casa e poi venire a prendere te.»
Borgaro Torinese è solo a una decina di chilometri dalla città, ma quando vivi fuori dieci o cinquanta chilometri sono la stessa cosa, se non hai l’età per guidare e non hai nemmeno il motorino.
Premetti forte la faccia contro il cuscino, volevo vedere quanto tempo ci sarebbe voluto per soffocare.
Tutto d’un fiato mormorai: «Voglio il motorino».
Mia madre mi guardò sorpresa: «Ma se non te n’è mai importato niente… cos’è questa storia, Clara?».
Non risposi, pensai che in fondo anche se mi fossi fermata fuori non sarebbe cambiato niente, nessuno mi avrebbe degnato di uno sguardo. La tristezza mi afferrò alla gola, sentivo un gran magone.
Mamma mi prese, lunga lunga com’ero, e mi tenne tra le braccia cullandomi. Piansi contro il suo petto, così, senza neanche sapere perché.
«Ho fatto le cotolette alla milanese. E anche le patatine fritte.»
Smisi di piangere, il cibo aveva sempre avuto un effetto magico su di me. «Davvero?»
Mi diede un bacio, si alzò e fece per uscire: «Dài, asciuga via tutto e vieni di là».
Mi guardai intorno, nella mia stanza ero al sicuro, protetta, sentii il profumo del cibo arrivare dalla cucina. Gettai il vestito turchese sulla sedia, infilai una tuta e mi misi di fronte allo specchio.
Ero molto alta per la mia età, lunga e secca, e questo non aiutava, l’altezza mi faceva sentire a disagio. Mi avvicinai di più, vidi un viso armonioso, due vivi occhi chiari, la pelle luminosa e i capelli biondi che mi ricadevano morbidi sulle spalle. Per un attimo ebbi la sensazione di non riconoscere la persona riflessa nello specchio. Ero cresciuta e potevo intravedere la donna che sarei diventata. Buttai un’occhiata fuori dalla finestra, il sole illuminava la magnolia quasi in fiore.
Andai in cucina e sedetti al mio posto. Papà mi diede un colpetto sulla mano: «Ah, pensavamo di dover iniziare senza la principessa e invece eccoti qui!».
Gli piaceva chiamarmi così, anche se mamma non voleva perché aveva paura che Sofia s’ingelosisse troppo. Ma questa volta nessuno disse niente, si erano accorti che avevo avuto una giornata difficile.
Seduta di fronte a me, Sofia allungò il collo e mi scrutò: «Perché hai pianto?».
«Sofia, lascia stare tua sorella.»
«Ho solo chiesto perché ha pianto» rispose lei piccata.
Sofia è così: decisa ruvida diretta, abbiamo quattro anni di differenza ma ho sempre avuto la sensazione che fosse lei la più matura.
«Aspetta di avere sedici anni, poi capirai anche tu, tesoro» le disse mamma con grande dolcezza.
Sofia non rispose e mise la testa nel piatto, lasciandosi rapire dalle cotolette. Mamma, che corre frenetica tra casa e ufficio, è il cuore, l’amore incondizionato.
Papà, con i suoi due baffi da russo, è la ragione, le scelte ponderate.
Sofia, lo scricciolo con il viso da angelo e la lingua da diavolo, è dar conto a qualcuno che è diverso da te, ed è anche più piccolo.
Io ho acchiappato cinquanta e cinquanta, ho il sorriso e la solarità di mia mamma e la diplomazia e la riflessività di mio padre. È un miscuglio difficile da decifrare, molte persone restano spiazzate. Sono sempre stata cordiale con tutti, ma quasi a nessuno è permesso avvicinarsi davvero.
La voce acuta di Sofia mi distolse dai miei pensieri. «Stasera c’è l’ultima puntata della mia serie preferita in tv, mangio sul divano!»
«Sofia, quante volte te lo devo ripetere, non si mangia sul divano!» la rimproverò mia mamma.
Sofia sbuffò. «Uffa, mamma, che palle!»
«E non si dicono parolacce!»
Mi intromisi nella conversazione, esitante. «Se tu e papà non volete vedere niente, stasera dopo cena mi piacerebbe guardare un programma in tv…» dissi.
Sarebbe andata in onda una trasmissione sui casi di cronaca nera, la mia passione. Mi interessava capire tutti i meccanismi della mente umana, il punto esatto in cui la psiche inciampa fino a prendere una deviazione e a oltrepassare il confine. Volevo diventare psicologa, mi vedevo già in tailleur scuro, valigetta di pelle, occhiali.
Quando ero bambina stavo a osservare, non prendevo parte ai giochi, alle gare, ai litigi. Mamma invitava le compagne di scuola e preparava la merenda in giardino sotto la magnolia, io restavo sulla porta a mangiarmi le unghie e a sorridere. Ma sentivo che nella vita sarebbe arrivato il momento in cui sarei sbocciata, tutto quel sorridere doveva pur servire a qualcosa.
Da piccola non reagivo, tenevo tutto dentro. In mensa all’asilo bevevo l’acqua in un bicchiere con l’adesivo della Chiquita. Avevo provato a toglierlo e buttarlo, il giorno dopo qualcuno ne appiccicava un altro. Non dicevo niente, non mi andava di far sgridare le compagne. Nemmeno quando, durante la ricreazione, mi guardavano da lontano e ruotavano il pollice dall’alto verso il basso, come avevano visto fare a Nerone sul libro di storia.
Una parte nascosta del mio corpo sapeva che un giorno le cose si sarebbero rovesciate, senza rancore, senza fretta.
«Va bene, tesoro» mi rispose mio padre dandomi un buffetto sulla guancia.
«Costantino, puoi passare tu a prendere mia madre a casa dei tuoi?» chiese mamma a papà mentre lavava i piatti e aspettava che salisse il caffè.
«Dipende da che ora.»
Per aiutare mamma e farla stare un po’ con noi, nonna Maria andava a occuparsi di nonna Vittoria nella vecchia casa di mio padre.
Nonna Vittoria da giovane aveva avuto un forte esaurimento nervoso mai curato. Lei diceva che erano stati i tedeschi, l’avevano fatta cadere giù per le scale quando era incinta di mio padre, sotto gli occhi dello zio Paolo, che all’epoca era molto piccolo. Nessuno sa se fosse davvero per questa ragione, fatto sta che era sempre malata, chiusa in casa, e non poteva essere lasciata sola.
«Intorno alle cinque.»
«Sì, certo.» Poi si era voltato verso mia madre e guardandola aveva aggiunto: «Ma che cosa si dicono tutto il tempo quelle due?».
Per noi era un mistero come le nonne potessero capirsi: nonna Maria parlava solo dialetto beneventano e nonna Vittoria un italiano impeccabile. Non potevano esistere due persone più diverse: una arrivata dalla provincia di Benevento a Torino all’inizio degli anni Settanta su un camion di traslochi, vedova, giovane, con tre figli piccoli; l’altra una madamina sposata all’uomo più in vista di Borgaro, tanto che il sabato pomeriggio le donne del paese l’aspettavano dietro i vetri per vederla tutta agghindata.
«Che ne so, Costa! Io le chiedo: mamma ma vi capite? E lei mi dice: eeeeehhh, quella mi risponde!»
Scoppiammo tutti a ridere. Riuscivamo a immaginarcele, nonna Maria uno scricciolo pieno di vitalità con la sua tinta color prugna, seduta nel salotto lugubre e soffocante, zeppo di chincaglierie preziose lucidate e in bella mostra. Nonna Vittoria stesa sul divano nella vestaglia rosa cipria di cachemire, pronta a lamentarsi: «Sto male, sto mor...