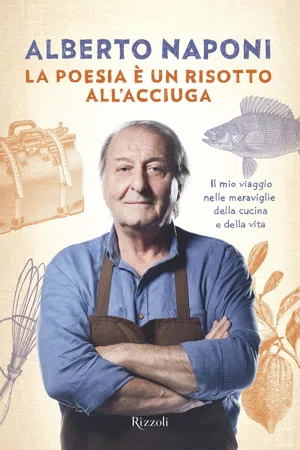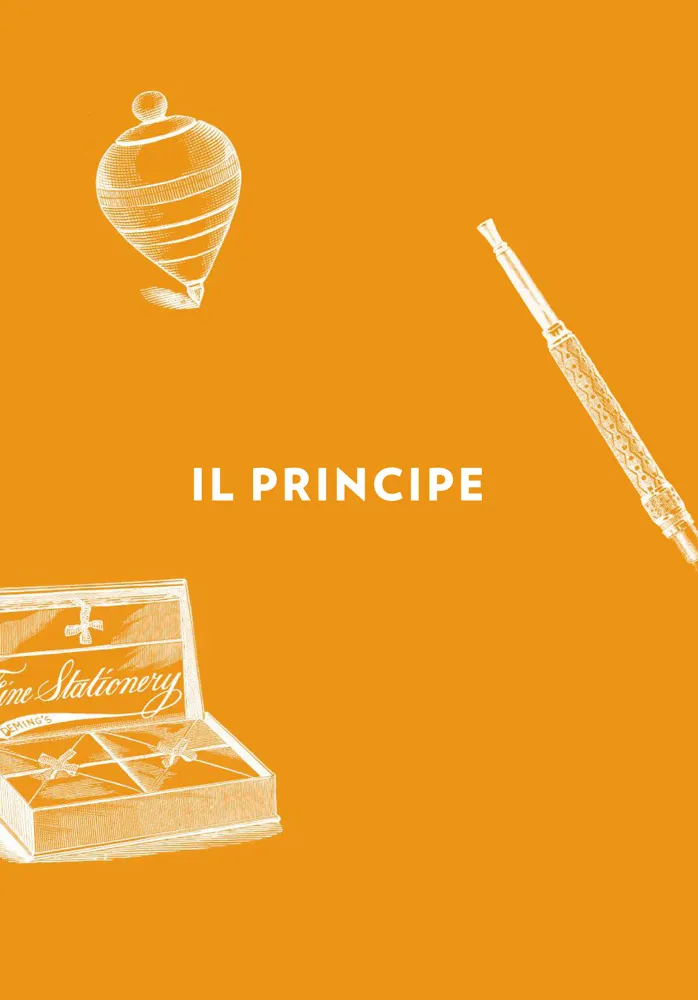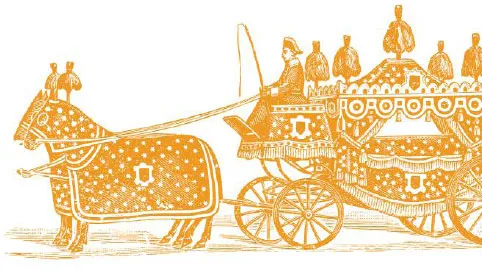![]()
“Tutti i grandi sono stati bambini una volta.
(Ma pochi di essi se ne ricordano.)”
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, Il piccolo principe
«Questa sera sei a mangiare da me.» Mia madre non chiedeva, ma aveva un modo elegante nel farlo.
«Sì, mamma, ci sono!»
«Perché stasera ti faccio la pasta alla zingara.»
«Ma quella vera?»
«Sì» rispondeva, «stasera è proprio quella alla zingara!»
Avevo poco più di dieci anni. Come succedeva spesso quando tornava dalla Svizzera o dai suoi viaggi di lavoro, mangiavo a casa sua e la guardavo cucinare una delle specialità di cui andava fiera. La mia famiglia si era già sfaldata: papà e mamma si erano amati moltissimo ma erano due mondi diversi, due persone fondamentalmente distanti. Entrambi artisti: lei però molto aperta, una cui piaceva la conversazione di sentimento come a me; lui chiuso, almeno in casa.
Dopo la separazione mia madre si era trasferita a Lugano, dove era redattrice alla «Donna», un femminile che aveva contribuito a fondare. Faceva la giornalista e la scrittrice, era già stata collaboratrice di «Novella», «Grazia» e del «Corriere della Sera» in cui pubblicava racconti e poesie. Un lavoro speciale, per quei tempi, che la rendeva indipendente. Scriveva anche per il cinema e la televisione, e, nel suo parlare di lavoro, ricordo due soggetti televisivi con Valentina Cortese e di aver più volte sentito nominare Raffaello Matarazzo.
“Tra noi c’era
un racconto continuo
di emozioni
e sensazioni.”
Andava e veniva continuamente da Cremona, e forse quello era anche un modo per fuggire da me e mia sorella, non so, ma io mi sono sentito sempre amato, c’era poesia tra noi e un dialogo fatto di sensazioni, un racconto emotivo continuo. Eravamo simili: lei capiva il mio mondo interiore meglio di tutti, in me si rivedeva e specchiava.
Alta, fascinosa, vestita come se fosse sempre lì lì per andare a una festa, oppure come la Streep nella Mia Africa, con camicie e foulard di seta color sabbia anche quando cucinava, si muoveva con disinvoltura dietro i fornelli. Era una capace, e lo era in tutte le cose che faceva.
La pasta alla zingara era il piatto dei suoi ritorni.
«Ma stasera è davvero alla zingara?» insistevo.
«Sì, è proprio quella.»
Solo sentire la parola «zingara» mi faceva scoppiare la testa. Improvvisamente vedevo cavalli, carrozzoni da circo, il fuoco e Mangiafuoco, orsi che ballavano. Poi, a un certo punto, mia madre mi faceva sedere su una seggiola e mi diceva: «Chiudi gli occhi».
Mi metteva in bocca una caramellina al lampone. «Tieni, è quella che mi ha dato il principe per te.»
«Il principe? Ma uno vero?»
«Sì, un principe come te!»
Da allora sono sempre stato il principe, per mia madre, per i miei nonni e poi, negli anni, per gli amici e le donne che mi hanno amato e sorretto.
Mentre succhiavo la caramellina e avevo visioni fantastiche, lei andava avanti a preparare.
Quando era pronto, mi mettevo a tavola e mi ritrovavo davanti pasta e fagioli. Ci cascavo sempre! Mi immaginavo chissà cosa, e poi c’era sempre questa pastasciutta con i fagioli, ma così buona che sin dal primo assaggio scomparivano i carrozzoni, Mangiafuoco e gli orsi fuggivano, il fuoco si spegneva e io cominciavo a sognare un altro sogno. Perché per quelli non c’è un orizzonte, e la pasta di mia madre non era mai una delusione.
PASTASCIUTTA ALLA ZINGARA
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
360 g di mezze maniche
250 g di borlotti secchi
20 pomodori di Pachino ciliegino
1 cipolla bianca
100 g di pancetta
200 ml di vino rosso
1 foglia di alloro
⅔ filetti di acciuga sott’olio
senape di Digione
1 ciuffetto di prezzemolo
olio extravergine di oliva
sale
pepe
Quella di mia madre, così come la mia zingara, non è la classica pasta e fagioli brodosa, ma una pastasciutta vera e propria con il sugo di fagioli, una cosa ben diversa. Lei, mia madre, ci metteva i perini, a volte anche l’acciuga, magari qualche cappero, i borlotti locali che brasava con il vino rosso e tante cipolline intorno. Io la faccio più o meno così, ma con un’aggiunta finale di senape.
Prima di tutto occorre lessare i borlotti con l’alloro dopo averli fatti ammollare per una notte nell’acqua. Poi si parte con il soffritto: in una padella disegnare un bel cerchio di olio e spargere le rondelle di cipolla e le foglie di pancetta (vale a dire la pancetta affettata fine e poi tagliata a pezzi ancora più piccoli) in modo che sfarfallino a contatto con l’olio caldo. Dopo qualche minuto, unire i pomodorini tagliati in quattro, il vino rosso e un pizzico di sale. Quando si ottiene una bella polpa di sugo, aggiungere i borlotti per tempo preparati e farli brasare lentamente, a fuoco basso. Assaggiare e aggiungere i filetti di acciuga a seconda di quanto abbia fatto effetto la pancetta, che a volte sala bene a volte no. Il tocco finale è uno schizzetto di senape (la quantità si può variare in base al gusto). Nel frattempo cuocere le mezze maniche (oppure un tipo di pasta che si possa raccogliere in un cucchiaio con tutto il sugo intorno), e quando sono pronte passarle in padella con il sugo. Ah, completare il piatto con una bella prezzemolata a freddo e il pepe, se piace.
FAGIOLI IN SALSA
(una variante di sugo più veloce)
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
250 g di borlotti secchi
1 cipolla bianca
1 spicchio di aglio
50 g di pancetta
⅔ filetti di acciuga sott’olio
senape di Digione
1 ciuffetto di prezzemolo olio
extravergine di oliva
sale
pepe
Può capitare di fare più fagioli, di avanzarli perché se ne gradiscono meno nel sugo. Allora si può fare un’insalata di fagioli: condire semplicemente con olio, sale, aceto e servire come contorno (se gradita, unire anche mezza cipolla affettata a rondelle). Oppure è possibile realizzare un altro tipo di sugo, più veloce e sbrigativo perché i fagioli non vanno brasati nel vino. Fare un soffritto con un filo d’olio, l’aglio, la cipolla e aggiungere un po’ di pancetta sfarfallata. Unire i filetti di acciuga e, una volta che si sono sciolti nel soffritto, aggiungere i fagioli lessati e muoverli in padella affinché prendano sapore. Completare con uno schizzetto di senape, il sale se necessario, versarvi la pasta appena scolata e spadellare. Completare con una pioggia di prezzemolo tritato, e il pepe a gusto. Pronta.
Dovessi mangiare oggi la pasta di mia madre, vedrei il Rinascimento o forse i terreni sabbiosi lungo il Po dove una volta si coltivavano i fagioli, tanto da far scrivere a Teofilo Folengo nel secondo libro del Baldus: «Si mangiare cupis fasolos vade Cremonam».
La presenza di costruttori di navigli da guerra unita a una configurazione particolare della città, che vede Cremona allungata sul Po con il Torrazzo a fare da albero come in una specie di grande veliero, ha fatto sì che anticamente la città venisse chiamata «Magna Phaselus», cioè «Grande vascello».
Folengo con la sua lingua maccheronica scherza su questo nome facendolo diventare, non a caso, «magna faselus» ovvero mangia fagioli. Io, e non solo io, continuo a pensare che i fagioli con la storia della mia città c’entrino di più dei vascelli e delle guerre fluviali, ma forse perché sono un pacifico.
Coltivati lungo il Po, in una terra sabbiosa, resa molto fertile dalle esondazioni del fiume, i bei borlotti e in seguito anche i fagiolini dall’occhio, quelli piccoli, teneri, bianchi e con una macchiolina nera sull’attaccatura del baccello, non sono mai mancati sulle tavole dei contadini.
Con i fagiolini dall’occhio anche a Cremona, come in molte parti d’Italia, si faceva una zuppa con le cotiche che si offriva nelle osterie il 2 novembre, dopo aver ammazzato il maiale nelle cascine.
FAGIOLINI DALL’OCCHIO E COTENNE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 g di fagiolini dall’occhio secchi
400 g di cotenne
1 foglia di alloro
concentrato di pomodoro
½ bicchiere di Marsala secco Florio
olio extravergine di oliva
strutto (facoltativo)
Parmigiano Reggiano grattugiato
farina
brodo di carne (circa 1 l)
sale
pepe
I fagiolini dall’occhio sono teneri ma necessitano anch’essi di una notte in ammollo per ammorbidirsi. Il giorno seguente, o comunque dopo almeno dodici ore, scolarli e lessarli in tanta acqua con una foglia di alloro. Attenzione alla cottura, perché non devono rompersi, e quanto al sale aggiungerne un poco solo alla fine. Pronti i fagioli, tocca alle cotenne. Occorre sceglierle belle, poi lavarle, bruciacchiarle sul fuoco per eliminare i peli e tagliarle a striscioline so...