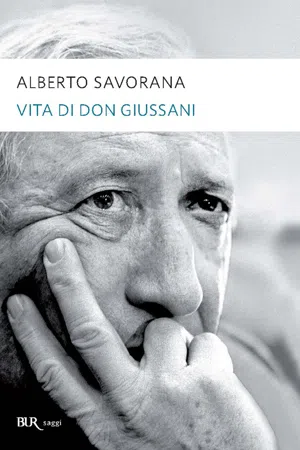![]()
TERZA PARTE
1986-2005
![]()
25
Sulle tracce di Cristo
I viaggi in Terra santa, Giappone e Grecia
(1986-1987)
«È un caldo giorno di fine estate quando il volo della El Al scarica sulla pista il piccolo gruppo di una quarantina di italiani. Siamo approdati in Israele per un pellegrinaggio attraverso i luoghi in cui visse Gesù.»1 Chi parla è Luigi Amicone, che con alcuni amici è in Terra santa, «sulle tracce di Cristo» come dice Giussani, guida e riferimento del gruppo. Il viaggio si svolge dal 14 al 21 settembre 1986. Ideato da don Giorgio Pontiggia e dal dottor Angiolino Bigoni, tocca Cesarea, Meghiddo, il Monte Carmelo, Nazareth, Cana, Tiberiade, Cafarnao, il Monte delle Beatitudini, il Monte Tabor, Sichem, Betlemme, Emmaus, Gerusalemme, Gerico, Masada, Qumrân, Betania. È un vero e proprio tour de force che dà l’opportunità a Giussani di rileggere i passi del Vangelo che parlano di quei luoghi, permettendo così di rivivere gli episodi dei quali quelle pietre – spesso ridotte a ruderi – sono state testimoni silenziose. A ogni tappa, don Pontiggia legge il brano corrispondente del Nuovo Testamento e Giussani lo commenta.
Si comincia da Cesarea di Filippi, centro politico dell’impero romano e residenza di Ponzio Pilato, della quale parlano gli Atti degli Apostoli. Giussani osserva: «Paolo, Stefano, il centurione, Pietro, sono tutte persone che sono passate di qui. E cosa le dominava? Cosa pensavano? Sentivano addosso che c’era un movimento nuovo nel mondo, […] che passava attraverso di loro. E ciò che è stupefacente è che erano tre, quattro gatti, nel senso letterale del termine», eppure «la loro era una sicurezza, una profezia, che sfidava il tempo, tanto che noi oggi stiamo realizzando la loro profezia».2
La comitiva si trasferisce, poi, dove «l’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria», cioè a Nazareth. Sul marmo del piccolo altare della grotta dell’Annunciazione campeggia la scritta Verbum caro hic factum est – «Qui il Verbo si è fatto carne». Pensando alla Madonna, Giussani osserva come la grandezza di Maria non sia consistita nell’essere diventata la madre del Signore, «perché questa è la grandezza di Dio», ma semplicemente «nell’aver detto “sì” al grande incontro che le ha toccato il cuore. Nessuno di noi può immaginare come è stato quell’incontro». E, sostando davanti alla sinagoga nella quale Gesù si dichiarò come il «mandato» del Padre e fu cacciato per questo, sottolinea che «quello che accade non è secondo le nostre previsioni, quello che accade è Grazia, è una gratuità, ha una forma gratuita, nuova, non prevista» e proprio per questo gli uomini del suo tempo «non l’hanno riconosciuto perché la risposta a quello che attendevano […] è stata diversa da quella che immaginavano».3
Trasferitisi a Cana, dove Gesù trasformò l’acqua in vino durante un banchetto di nozze, Giussani fa notare come la cosa più impressionante di tutte sia che «l’incontro che fa diventare viva la fede è dentro lo svolgimento solito della vita». Che cosa c’è di più banale di un pranzo? Ebbene, proprio questo è «il miracolo che porta Cristo vicino all’uomo, dentro la sua vita concreta. Senza il vino non si fa un matrimonio. È una cosa necessaria dentro la vita normale».4
Durante una serata sul terrazzo dell’albergo di Tiberiade che ospita il gruppo di pellegrini, Giussani confida agli amici la cosa che lo colpisce maggiormente: «Tutto è nato da quei “buchi”, da una povertà assoluta» e aggiunge che «per sua natura il cristianesimo comincia così, sempre. Una vitalità di fede comincia sempre in questi termini, non ha bisogno di giornali, di settimanali, di grandi strutture». Per Giussani «vedere quella grotta di Nazareth come il significato ultimo di tutto l’enorme sviluppo della città, questa è la fede».5
Poco distante da Tiberiade, il gruppo visita la chiesa del Primato, nel luogo dove Gesù per tre volte domandò a Pietro: «Mi ami tu?», sentendosi rispondere di sì: «Siamo nel punto in cui nella compagnia, l’amicizia, il movimento umano di cui abbiamo parlato, improvvisamente – improvvisamente perché Gesù era un uomo come tutti gli altri, perciò le idee gli venivano dalle circostanze – s’aderge l’idea di una costruzione storica. […] L’idea gli è venuta quando, percorrendo questo viottolo che costeggia il lago, si è imbattuto in questa roccia emergente. È come se avesse detto: “Su essa costruirò questo movimento destinato ad abbracciare tutto il mondo. Che nessun uomo sia isolato e lasciato solo in questo abbraccio […]”». E aggiunge che l’itinerario del movimento umano iniziato attorno a Gesù «è fatto di pietre miliari, di pietre come quelle usate dai romani per costruire le loro strade. E la pietra miliare per eccellenza è Pietro, il punto di riferimento vivente che è il Papa. Sopra i marosi della storia emerge questo promontorio che custodisce e indica la strada al Destino».6
Arrivati a Cafarnao, la città di Pietro, di Giairo – al quale Gesù resuscitò la figlia – e dell’evangelista Matteo, Giussani fa leggere l’episodio del paralitico guarito da Gesù; quindi dice: «Quella compagnia che si era creata attorno a Gesù […] in questa occasione per la prima volta sperimenta il brivido di un potere inconcepibile. Da questo momento si diffonde la fama di Gesù. […] Proviamo a immaginare la reazione degli amici di Gesù al vedere questo loro compagno autorevole dimostrare un potere che loro non avrebbero mai immaginato».7
Cambia la scena, il gruppo è a bordo di una imbarcazione sul lago di Tiberiade, quello della tempesta notturna durante la traversata in barca, coi discepoli terrorizzati mentre Gesù dormiva a poppa. Ascoltato il brano del Vangelo che riferisce che proprio in quel luogo Cristo placò le acque e che i discepoli, superato il grande timore, si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?», Giussani osserva che alla domanda su chi fosse Gesù, «dal punto di vista amministrativo e anagrafico, potevano rispondere precisamente». Eppure «quell’Uomo aveva una tale potenza, così sproporzionata all’immaginazione dell’uomo, che sono stati costretti a porsi quelle domande».8
Percorrendo la riva orientale del lago di Tiberiade i pellegrini raggiungono il luogo dove Giovanni battezzò Gesù, sul fiume Giordano, un piccolo specchio d’acqua circondato dalla vegetazione. Visitando quei luoghi, Giussani è sorpreso dal fatto che «la vera novità avviene attraverso le circostanze ordinarie. […] Gesù è venuto qui come tutti gli altri ebrei che seguivano il profeta, così come sono venuti qui Giovanni e Andrea. È in questa adesione umile [di Gesù] al comportamento di tutti che è scaturita la grande circostanza, cioè l’avvenimento della salvezza».
In Samaria, a Sichem, Giussani visita il pozzo di Giacobbe, dove la samaritana si sentì dire da Cristo tutto quello che aveva fatto, e commenta l’episodio evangelico: «Non c’è nessun miracolo più grande che sentirsi guardati e percepiti […] nella profondità della propria persona, guardati e percepiti sia come esigenza, come sete, sia come limite, come male che impedisce la soddisfazione vera delle esigenze, della nostra sete».9
Finalmente il gruppo raggiunge Betlemme. Nella basilica della Natività Giussani fa leggere il brano a cui è legata la sua memoria di giovane seminarista, cioè il Prologo del Vangelo di Giovanni: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. […] E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». Giussani ha commentato un numero infinito di volte questo passo, ma qui, dove Cristo è nato, le sue parole non possono che acquistare un peso specifico particolare: «Io credo che il contraccolpo più immediato di fronte a questo messaggio, su cui si fonda il significato stesso della vita, è questa domanda: ma come è possibile che Dio possa diventare presenza umana, un uomo tra noi, e i suoi, sia coloro che erano più consapevoli, sia coloro che navigavano nell’angoscia delle tenebre, non l’abbiano riconosciuto?».
Anche lì trova conferma l’impressione che il viaggio, a ogni tappa, sta facendo crescere in lui: «Tutto è avvenuto senza alcun clamore umano. Tutto il popolo ebraico e il grande Giovanni Battista […] aspettavano il Messia come qualcosa di clamoroso. Come qualcosa di eccezionale che avrebbe realizzato la giustizia nel mondo». E invece è accaduto come «un seme vivo che prorompe nella terra a dispetto di tutti i passaggi delle stagioni. E dapprima sembra una cosa di cui si può benissimo non tenere conto. Così come hanno fatto tutti gli annalisti del I secolo, compresi gli scrittori romani che, come Tacito e Svetonio, riferiscono di quella “setta il cui fondatore Cristo fu suppliziato sotto l’impero di Tiberio”. Questo seme prorompe dapprima in modo apparentemente insensibile, ma poi, dopo duemila anni, ne siamo investiti umanamente, ragionevolmente, affettivamente».
Betlemme e Nazareth, il metodo di Dio
Betlemme è per Giussani la documentazione del metodo che Dio utilizza per farsi conoscere: «Sant’Agostino diceva che il mondo potrebbe essere stato creato come un piccolo punto nel quale fossero contenute le rationes seminales, vale a dire i semi di tutti gli sviluppi ulteriori (millecinquecento anni prima di Darwin una concezione evolutiva del mondo che nessuno cita mai!). Ma è proprio il metodo che ha usato Dio venendo nel mondo, facendosi una realtà assolutamente impercettibile». E come mai il Signore usa questo metodo? «Per dimostrare che la potenza non è nostra, non sta nella nostra intelligenza, non è una nostra forza, ma è Suo Potere. Dal nulla ha tratto tutto.» E davanti alla grotta dei Santi Innocenti, Giussani ricorda che questo seme si è sviluppato come testimonianza, «si tratti del vivere o del morire: vita e morte non avrebbero nessun significato se non ci fosse Cristo».10
Dice ancora Giussani: «Quando si pensa che la salvezza viene da quello sconosciuto paese di Nazareth è quasi istintivo pensare: “Da qui?”. E quando si visita la casa di Giuseppe uno si dice: “Da qui?”. E quando si pensa a quella dozzina di gente smarrita e ignorante che lo seguiva, e comunque senza alcun potere, viene da dire: “Da lì?”». Questo gli fa concludere che «è un altro fattore che a un certo punto agisce. E non accanto o sopra all’umano, ma attraverso la carne, le ossa, le tasche e tutto ciò che coincide con la vita dell’uomo».11
Appena giunto a Gerusalemme, Giussani legge e spiega il brano di san Luca che narra la visita di Maria alla cugina Elisabetta, in un villaggio a pochi chilometri dalla città. Egli ne parla come una delle cose umanamente più commoventi del cristianesimo: «Dopo l’Annuncio scatta in lei un impeto di disponibilità assoluta, totale. Pensiamo ai più di centocinquanta chilometri di strada che percorse per giungere fin qui, non per una divagazione, ma, dice il vangelo, “camminando veloce per la strada” tutta presa dal suo scopo». E aggiunge: «Quello che ha meravigliato Elisabetta meraviglia anche noi: “A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?”. È il grido di ammirazione per la gratuità assoluta, perché nessun parente avrebbe fatto tanta strada per venire ad aiutarla!». Questo significa che «la fede fa vivere l’umano e rinsalda i suoi nessi, fa essere una cosa sola».12
Tappa obbligata della visita a Gerusalemme è il Muro del pianto, ciò che resta dell’antico tempio distrutto dai romani nel 70 d.C., meta del pellegrinaggio continuo di ebrei, da duemila anni centro spirituale dell’ebraismo. Questo offre l’occasione a Giussani, da una parte, di sottolineare il significato che deve avere per tutti la storia di Israele: «Dio ha eletto questo popolo, lo ha eletto con un fine messianico e ora gli ebrei pregano perché il loro popolo possa permanere e possa ricostruire il tempio che ne è il simbolo. Prega perché il senso della vita di ogni ebreo è legato alle vicende del proprio popolo. Il Muro del pianto è umanamente una delle cose più commoventi e drammatiche che esistano […]. Recitando i salmi o i profeti o l’Esodo, chi va al Muro del pianto chiede a Dio che il suo popolo rimanga perché è l’unica testimonianza al Dio vivente nel mondo». Dall’altra parte, osservando la processione di fedeli che sostano ondeggiando davanti al Muro, a Giussani sembra che, «nonostante la grande coscienza di popolo, ogni ebreo presso il Muro del pianto reciti i suoi salmi in una solitudine tremenda, quasi che il dolore della situazione sia tale, e l’emozione per la condizione in cui versa il suo popolo sia così profonda, che non possa ottenere forme comunitarie». E conclude che «forse la più grande alternativa nella storia delle religioni è proprio sotto questo muro: se l’attesa dell’adempimento della Promessa è accaduta o non è accaduta».13
I pellegrini percorrono in silenzio la Via Dolorosa, cioè il cammino fatto da Gesù verso il Calvario, tra i vicoli di Gerusalemme; ascoltano il vangelo della Passione e le meditazioni di Giussani: «La vita di ognuno ha un destino di Via Crucis […]. Tutti a quel tempo aspettavano il Redentore. Ma il Redentore ha una faccia, è cioè condizionato in modo tale che a noi, come agli ebrei di allora, non garba, perché è diverso da ciò che ci aspettiamo». La Via Crucis è determinata da questa «ribellione»14 al volto con cui Cristo si presenta sulla scena del mondo.
La sosta a Gerusalemme si conclude riandando con la memoria alla sera di Pasqua e a quei due uomini sulla via di Emmaus, allorché furono affiancati da un estraneo, che solo a cena avrebbero riconosciuto come il Signore risorto. Giussani invita a immedesimarsi con la scena descritta dall’evangelista Luca: come i discepoli di Emmaus, anche «noi camminiamo come cristiani tristi. La tristezza non viene dalla prova e dal dolore, la tristezza viene sempre dall’assenza di significato o dalla fragilità della ragione. La tristezza è sempre un interrogativo sul “vale ...