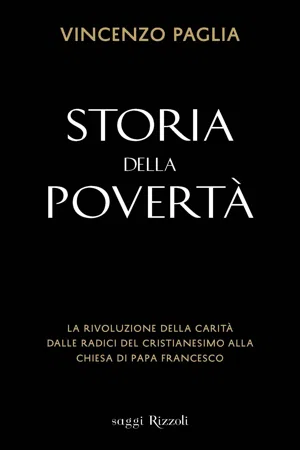![]()
1
Povertà e carità
Il «mistero» dei poveri
Gesù era ancora in vita quando Giuda, mentre una donna un po’ equivoca versava un vaso di unguento prezioso sui piedi del giovane profeta invitato a cena da un facoltoso fariseo, sbottò: «Si poteva vendere tutto e il ricavato darlo ai poveri». Gesù rispose fermo: «I poveri li avete sempre con voi!». In effetti, i poveri accompagnano la storia del cristianesimo come una domanda o, se si vuole, una contraddizione permanente. I loro volti cambiano, come pure cambiano le definizioni. Si potrebbe dire che la povertà si è sempre nutrita delle nuove povertà, modificandosi incessantemente e costituendo una sorta di fiume ininterrotto che ha percorso i secoli e si è ramificato in ogni terra; un fiume che talora si ingrossa sino a straripare, tal’altra si riduce, mai però è in secca. La povertà è larga. In sintesi, però, è povero chi in modo permanente o temporaneo si trova in condizione di debolezza, di dipendenza contraddistinta dalla mancanza di strumenti di potere e di considerazione sociale, ossia di denaro, di relazioni, di influenza, di qualificazione tecnica, di vigore fisico, di capacità, di cultura, di libertà e dignità personale. Insomma, la folla dei poveri coincide con le larghe schiere dei rifiutati, degli asociali, degli emarginati.1
Talora c’è anche chi si chiede: se i poveri sono tali non sarà per colpa loro o per qualche maledizione prima di loro? Qualcuno azzarda: non è meglio che i poveri restino poveri per guadagnare il regno di Dio? Tra i credenti ci si chiede: quale segreto è contenuto nel paradosso delle Beatitudini? È possibile aiutare i poveri senza umiliarne la dignità? L’assistenza e la solidarietà non rischiano di perpetuare, anziché annullare, la condizione di povertà? Gli interrogativi possono moltiplicarsi ancora. Resta vero che «i poveri li avete sempre con voi». In effetti, c’è un mistero nascosto nella loro presenza.
Alcuni filosofi – penso a Gianni Vattimo, uno dei sostenitori del «pensiero debole» – sono attratti da tale prospettiva. Sino a ritenere che le istanze più profonde del pensiero debole trovino una ragione coerente nell’orizzonte della kenosi evangelica e del privilegium pauperum proprio della tradizione cristiana. Il filosofo torinese, come a volersi legare ancor più a tale prospettiva filosofica, parla ora più che di «pensiero debole» di «pensiero dei deboli»: nei confronti di quest’ultimi si spalanca – per opera appunto della visione cristiana – la porta di quell’amore che solo trasforma il mondo.2 Si allarga, in effetti, la schiera di coloro che ritengono l’amore come una straordinaria forza di cambiamento. Basti scorrere l’opus magnum del filosofo tedesco del secolo scorso, Dietrich von Hildebrand. Nell’opera Essenza dell’amore3 mostra a quali vertici morali questo spinga. Anche le riflessioni di Miguel de Unamuno sull’amore di Dio sono particolarmente suggestive.4 E di non poco interesse è l’opera, questa volta teologica, di Werner G. Jeanrond, Teologia dell’amore5 che lega l’amore di Dio e l’amore umano in una feconda prospettiva.
Il «mistero» della carità
Legare l’amore e i poveri significa cogliere la dimensione centrale del cristianesimo. È in questo rapporto che si pone la stessa questione di Dio. La carità sa penetrare nel «mistero» dei poveri. Ecco perché è l’altra protagonista delle pagine che seguono. Sul «fare la carità» si giocano, per venti secoli, l’organizzazione concreta della società, l’evangelizzazione, la riforma religiosa, la sanità e lo spirito del capitalismo, le utopie secolarizzate di un mondo senza sfruttati e senza sfruttatori. Scorrendo questa storia passata si scorge l’energia potente della carità che, nel corso dei tempi, ha cercato i modi concreti di raccordarsi con i poveri e rendere il mondo più solidale.
Tra la povertà e la carità sarebbe importante trovare uno spazio più largo per la terza protagonista, ossia la «ricchezza». La bibliografia sul tema è vasta, sebbene non vi sia una completa ricerca storica sulla ricchezza e sulla sua vicenda.6 Ma scorrendo il lungo lavoro storico di Peter Brown nel volume Per la cruna di un ago7, si comprende la forza di uno dei grandi paradossi dell’Occidente: per un verso la nostra cultura è permeata dal messaggio evangelico nella sua radicalità che oppone la ricchezza a Dio, per l’altro appare la complessità del rapporto dei cristiani e della stessa comunità con la ricchezza. Il tema traversa l’intera storia della Chiesa e ha la sua origine già nei Vangeli: basti pensare alla sfida rivolta da Gesù al giovane ricco, insieme con il suo commento altrettanto inquietante sull’impossibilità che quel giovane accettasse la sfida, poiché «è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio» (Mt 19, 24). La letteratura in materia è abbondante: si scorge la forza della spinta al cambiamento anche solo di questa breve affermazione di Gesù. Una schiera innumerevole di credenti ha cambiato vita osservandola alla lettera.8
Nel momento in cui i ricchi iniziarono a entrare massicciamente nella comunità cristiana – come accadde in maniera robusta già nel II secolo ad Alessandria di Egitto – il problema si pose in maniera impellente. Clemente Alessandrino, pagano convertito, venuto alla fede dalla filosofia, affrontò la questione in modo deciso e scrisse un opuscolo: Quale ricco può salvarsi?9
Certo, nel corso dei secoli non pochi compromessi sono stati messi in atto. C’è ancora oggi chi auspica una rinnovata teologia dei beni materiali per uscire da una scomoda contraddizione. Il biblista Craig L. Blomberg, nel volume Né povertà né ricchezza10, propone una nuova lettura biblica di queste tematiche e, assieme a Brown, avverte di non svalutare l’elemosina, le donazioni alle chiese, le offerte settimanali e così oltre.
Certo è comunque che la carità spinge a dirigere la ricchezza verso i più poveri. La vedremo infatti indurre i cristiani, fin dai primi passi, a trovare forme organizzative e a convincere i credenti a farsi «prossimi» ai più poveri. E non si deve dimenticare che «prossimo» è il superlativo di prope: quindi, i più vicini. Questa tensione porta i cristiani a elaborare una vera e propria cultura della solidarietà e a trovare alleati ovunque perché ispiri le società a organizzarsi di conseguenza. Nei secoli a seguire, attraverso i suoi attori la carità si scopre talora più legata alle istituzioni civili, altre volte più libera e contestatrice. In suo nome si è avviato il rinnovamento della Chiesa, esortata a riscoprire il tesoro dei poveri e l’ideale della povertà. La carità è stata un fattore importante dell’impegno, complesso e non sempre lineare, volto a quella cristianizzazione della società moderna che a sua volta ha plasmato la società europea e la scoperta di nuovi mondi. Negli ultimi secoli – quelli della modernità – il percorso si è fatto più travagliato, poiché i credenti si sono dovuti destreggiare tra autonomie, appiattimenti e opposizioni fino al Concilio Vaticano II grazie a cui la carità – e quindi anche il suo rapporto con i poveri – sembra aver trovato una nuova primavera.11
Il rapporto tra la carità e la povertà è segnato da un insito dinamismo che è difficilmente inquadrabile in schemi prefissati. La carità trascende la stessa organizzazione della società, sebbene non ne sia estranea; al contrario, la carità entra nelle pieghe più nascoste e dimenticate della società. Non di rado gli uomini di carità hanno individuato per primi i bisogni dei poveri e proposto le soluzioni. Alla carità non si deve chiedere, anzitutto, l’organicità negli interventi (che è responsabilità, piuttosto, della società civile o delle istituzioni pubbliche) o una semplice supplenza alla società civile, perché essa va oltre le regole anche se non le rifiuta; va anche al di là delle istituzioni, pur non facendone a meno.
Del resto, la stessa povertà straripa gli argini che le istituzioni le impongono. Di tempo in tempo, ad esempio, con interventi legislativi e provvedimenti restrittivi le autorità civili hanno cercato di «costringere» i poveri all’interno di appositi istituti o comunque di regole per governare più che per cancellare la povertà. Eppure in nessun Paese e in nessuna epoca, piani del genere hanno debellato la povertà nella sua globalità. È ovvio che non si debbono sottovalutare tali sforzi, ma la vicenda storica ci porta a dire che esiste, appunto, un «oltre» della povertà che non può essere cancellato. C’è un «mistero» dei poveri, con il quale bisogna fare i conti e che sfugge alle istituzioni, alle leggi, alle consuetudini, ma non alla carità. È proprio della carità essere oltre. La carità è persino oltre lo stesso cristianesimo, come ci suggeriscono le parole evangeliche «ho avuto fame e mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e mi avete dato da bere…» (Mt 25, 35); gesti come questi sono compiuti anche da persone che si dichiarano esplicitamente non credenti.
Il legame con i poveri è a tal punto costitutivo del Vangelo da collocarsi nel cuore stesso dell’esperienza. La stessa questione di Dio va posta in tale orizzonte. Alain Durand, teologo domenicano, scrive con nettezza: «La questione di Dio per noi cristiani è inseparabile da quella dei poveri», e ancora: «La scelta prioritaria in favore dei poveri, che caratterizza fin dalle origini l’annuncio della vicinanza del Regno di Dio attuato da Gesù è una questione così fondamentale nel cristianesimo che riguarda l’intero campo della teologia».12 Tale scelta è teologica non solo perché l’amore è la via che più di ogni altra avvicina a Dio, ma soprattutto perché è quella che Dio stesso ha percorso per giungere sino a noi. Non di rado si hanno immagini sbagliate di Dio: molti pensano a un Giudice severo e implacabile, altri a un Essere lontano e altri ancora a un’Entità impassibile o che insidia la nostra libertà, o magari che ci ruba la felicità, oppure che interferisce «troppo» nella vita degli uomini, al punto che vien detto ai cristiani di mettere da parte Dio se vogliono essere bravi cittadini, e così oltre. Ma come possono i credenti mettere da parte Dio? Se chi non crede comprendesse che il Dio che Gesù mostra «è» l’amore, forse chiederebbe di renderlo ancor più presente. È quel che sta accadendo con papa Francesco. Molti non credenti accorrono e plaudono alla sua predicazione di un Dio che è anzitutto e soprattutto «misericordia».
L’amore prima della fede?
L’insistenza di papa Francesco nel presentare un Dio che ama, che è esperto di amore, che sa amare gli uomini sino a morire è tra i doni più preziosi che sta offrendo alla Chiesa e al mondo. Ecco perché oggi si può dire con più vigore che l’amore viene «prima» della fede. Viene prima perché Dio, che è amore, sta all’origine della fede stessa. Dio, scrive l’apostolo Giovanni, «ci ha amati per primo» (1Gv 4, 19). Scrive con sapienza Abraham J. Heschel: «Tutta la storia umana, come è descritta dalla Bibbia, può sintetizzarsi in una frase: Dio è alla ricerca dell’uomo. La fede in Dio è una risposta all’interrogativo di Dio».13
Ma l’amore viene prima non solo ontologicamente, anche esistenzialmente. L’amore, infatti, è l’energia che avvicina a Dio. Ed è sempre più urgente seguirla: essa porta sempre a Dio. Prima o poi, ma sempre. Il messaggio evangelico non può essere affidato solo al ragionamento o, peggio, a strategie umane. La via più sicura per il Vangelo è quella dell’amore. Percorrerla vuol dire giungere più facilmente sia a Dio, sia al cuore dell’uomo di oggi, sovrastato dalla solitudine e dalla paura. La crisi di questo inizio di millennio – crisi che comprende trasversalmente l’intera società umana – è chiaramente una crisi per mancanza di amore: ce n’è poco sia nelle persone che nel tessuto delle società. E la sua mancanza indebolisce l’intero tessuto umano. Senza di esso ogni pace è pericolante; e le grandi questioni della bioetica come quelle dell’ecologia saranno affrontate in maniera inadeguata. L’amore non è solo la via per una nuova evangelizzazione, lo è anche per un nuovo umanesimo.
L’amore di cui parliamo è quello disegnato nel Vangelo: un amore che lega Dio e i poveri in maniera indissolubile. Quando vanno a chiedere a Gesù di indicare i segni della presenza di Dio nella vita degli uomini, egli risponde: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo» (Mt 11, 4-5). Questi, e solo questi, sono i segni con i quali Gesù indica che Dio è entrato nella storia degli uomini.
La fede, perciò, inizia il suo cammino nella storia proprio attraverso questi segni, ossia nell’incontro con i poveri che sono aiutati, con i malati che vengono guariti, con gli afflitti che trovano consolazione. In tal senso l’annuncio del Vangelo ai poveri e la concreta vicinanza a loro si trovano all’origine stessa della fede. Il rapporto della Chiesa con i poveri non è pertanto una aggiunta morale, non è una delle dimensioni della pastorale: è la ragione stessa della fede. Nella misura, infatti, in cui la Chiesa è «corpo di Cristo» necessariamente deve assumersi come sua carne anche i poveri. Potremmo dire che l’amore per i poveri è la garanzia evangelica della Chiesa. Per questo essa è radicalmente diversa da qualsiasi organizzazione umanitaria, da qualsiasi Ong, come dice papa Francesco.
Una bella tradizione russa dice: «Dalla festa della luminosa Resurrezione fino alla festa dell’Ascensione ogni anno Gesù Cristo percorre la terra, passa per i villaggi, fermandosi sotto le finestre e ascoltando i discorsi dei contadini […] Nelle vesti di un mendicante che chiede l’elemosina, di un vecchio canuto, il Figlio di Dio si presenta alle case di ricchi e poveri, di avari e generosi, di crudeli e compassionevoli. La gente si comporta come al solito, secondo la propria natura, non sapendo di essere messa alla prova dell’amore cristiano da Dio stesso».
C’è purtroppo una strana attitudine, che è ben radicata in uno spirito egocentrico, la quale ammanta di una malintesa equità, annebbia la vista e falsa lo sguardo e il giudizio verso i poveri. Nei Vangeli è chiaro il principio di predilezione di Gesù verso i poveri, non perché sono giusti e onesti ma semplicemente perché poveri e bisognosi. Deve far riflettere il fatto che Gesù usi il termine «fratello» solo per i discepoli e per i poveri, come a unirli in un unico legame. Lo fece notare bene l’allora giovane teologo Ratzinger in un libricino della fine degli anni Sessanta, La fraternità cristiana. «I discepoli di Gesù e i poveri sono tra loro fratelli». Per questo, i poveri non sono gli «utenti» o l’oggetto della nostra carità: sono i primi fratelli a cui mostrare l’amore, i primi con cui vivere l’amicizia che nasce dalla predicazione evangelica.
La charitas verso i poveri – è bene ripeterlo – non è un’aggiunta all’esperienza della Chiesa e dei singoli cristiani, ne è la garanzia evangelica. Potremmo dire che il legame inscindibile tra Gesù e i poveri diviene anche quello tra i poveri e i credenti. E si riflette nell’immagine stessa di Dio.14 La pietas cristiana (che va anche oltre i confini visibili della Chiesa) manifesta, seppure pallidamente, la pietas divina che si piega commossa anzitutto sui poveri. Il primato dei poveri nella vita della Chiesa si fonda, perciò, sul primato che essi hanno nella stessa vita di Dio. Tale predilezione – lo vedremo più avanti – non relativizza la paternità universale di Dio, e neppure attutisce l’urgenza della missione universale. Vuol dire soltanto che la salvezza si realizza a partire dall’incontro con i poveri: il movimento religioso promosso da Gesù parte dall’annuncio del Regno ai poveri e si prolunga in missione universale. Ed è come un filo rosso che lega l’intera storia cristiana. La vicenda di Francesco d’Assisi – il suo essere tra i minores (gli esclusi del suo tempo), il suo bacio al lebbroso con il suo «matrimonio con Madonna Povertà» (il Sacrum commercium cum domina Paupertate) – è forse la testimonianza più alta e universale della radice evangelica del rapporto del credente con i poveri.
Ripartire dall’amore per i poveri
Confesso che fui colpito dal fatto che la prima enciclica di Benedetto XVI – in genere con essa si esprime la tonalità del nuovo papa – fosse sull’amore, Deus Caritas Est. In un mondo segnato dalla paura e dalla solitudine, travolto dalla tragedia delle guerre e dei terrorismi, per papa Benedetto XVI l’amore restava la via più chiara e forte per costruire un futuro nuovo per i popoli. Era un messaggio che i cristiani dovevano portare come il loro specifico contributo per edificare una società più umana. Il papa chiedeva che anche le religioni riscoprissero l’energia d’amore nascosta nelle profondità dei loro credo, abbandonando ogni tentazione di cedere all’odio e alla violenza: «In un mondo in cui al nome di Dio viene a volte collegata la vendetta e perfino il dovere dell’odio e della violenza, questo è un messaggio di grande attualità e di significato molto concreto».15 Si trattava – continuava Benedetto XVI – di «suscitare nel mondo un rinnovato dinamismo di impegno nella risposta umana all’amore divino».16 È da questo amore che l’enciclica chiedeva di ripartire.
Il papa sottolineava inoltre che l’amore evangelico aveva una sua originalità che andava riproposta agli uomini d’oggi con coraggio. E affermava con chiarezza che l’amore cristiano non si contrappone all’amore umano, come qualcuno potrebbe credere. L’amore evangelico non è il con...