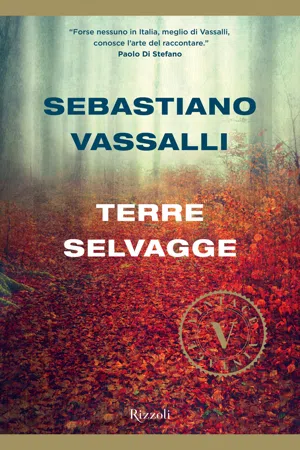
- 300 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Una terra a sud delle Alpi, disabitata e talmente inospitale che nel 101 a.C. non ha ancora un nome. Duecentomila uomini pronti a combattere corpo a corpo, a massacrarsi fino allo stremo: da una parte un popolo di invasori, i Cimbri, invincibili in Europa da vent'anni e decisi, forse, ad attaccare persino Roma; dall'altra parte i plebei e gli ex schiavi del console Caio Mario, ultimo avamposto in difesa dell'Urbe. Una storia mai raccontata, un evento destinato a cambiare la Storia, nelle pagine epiche di un grande narratore italiano.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Terre selvagge (VINTAGE) di Sebastiano Vassalli in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788817080729eBook ISBN
9788858662250Capitolo primo
Il fabbro di Proh
Era maggio, il mese più bello dell’anno. Era il settimo giorno del mese: le nonae. C’era il sole. C’erano i fiori sugli alberi e nei prati, c’erano, a chiudere l’orizzonte, le grandi montagne: le Alpi, ancora bianche di neve. C’erano gli uccelli che tornavano dai paesi lontani. Su tutto quello che si vedeva, però, e anche su quella parte del paesaggio che rimaneva nascosta dietro le colline coperte di boschi, incombeva l’ombra di una minaccia: così grande, da occupare tutti i pensieri degli uomini e da determinare tutti i loro comportamenti. La gente scappava. Da tre, quattro giorni: per la strada che attraversava il villaggio di Proh venendo da Novara e dagli altri borghi della pianura si snodava una processione ininterrotta di uomini e di donne curvi sotto il peso delle cose che dovevano assolutamente essere portate in salvo e che i più ricchi avevano potuto caricare su un asino, su un cavallo o addirittura su un carro. C’erano molti bambini, molti vecchi. C’erano anche molti animali: cani, pecore, capre. Ogni tanto, in quel fiume di uomini e di bestie, arrivava qualcuno che si faceva largo a suon di frustate e superava tutti con la sua raeda o il suo carpentum che erano le carrozze dell’epoca, lasciandosi alle spalle una scia di insulti e di maledizioni. Molti gli gridavano:
«Dove credi di poter arrivare, prima degli altri? Perché corri?».
Molti gli auguravano di andare in malora o in altri luoghi altrettanto piacevoli; o di morire di morte violenta; o di fare comunque una brutta fine.
Davanti all’officina del nostro primo personaggio, il fabbro Tasgezio, non si era mai visto un tale transito di persone e di animali e di veicoli che andavano tutti nella stessa direzione, verso le montagne: e, naturalmente, c’era qualcosa di terribile che spingeva tutta quella gente a fuggire. Si diceva che laggiù, in pianura, fosse arrivato un popolo di invasori anzi di diavoli, che rubavano e incendiavano e uccidevano: il popolo dei Cimbri. Quando non era impegnato a sistemare una ruota o ad aggiustare la stanga di un carro, Tasgezio stava davanti alla sua officina, appoggiato a uno dei pali che reggevano la tettoia, a guardare quelli che passavano. Rispondeva con un cenno del viso o agitando una mano ai tanti che lo salutavano senza conoscerlo. Gli diceva:
«Buona fortuna. Buon viaggio».
«La strada per attraversare le montagne, e per i laghi» spiegava a chi gli chiedeva un’informazione, «è quella che gira a destra. Andando a sinistra, invece, si va verso il borgo di Agamio e verso la montagna più grande di tutte le altre: il monte Ros.»
«Si va nella valle del fiume Sesia. Una valle senza vie d’uscita.»
«E tu, ragazzo, perché non chiudi l’officina e scappi?» gli chiedevano i vecchi. «Lo sai che giù nella pianura tra i fiumi Ticino e Po sono arrivati i Cimbri, che saccheggiano e bruciano i villaggi e ammazzano tutti quelli che trovano? Non te l’ha detto nessuno?»
«Sono ancora lontani» rispondeva Tasgezio. «Per quel che ne so io, si sono accampati a sud di Vercelli. Non credo che arriveranno fin qui.»
«Roma manderà un esercito a fermarli.» Ma chi stava scappando gli obiettava: «Hanno già vinto i Romani quando sono arrivati in Italia, sull’Adige». E c’era perfino chi gli dava ragione, per convincerlo:
«È vero» gli diceva, «che il grosso di quei diavoli è fermo di là da Vercelli, ma si sono visti anche attorno a Novara. Dacci retta: scappa».
«Sono così tanti che gli ci sono volute due settimane per attraversare il Ticino» aggiungeva un altro. E altri ancora si fermavano a dire la loro. Raccontavano:
«Hanno cento carri carichi d’oro e d’argento: un tesoro immenso!».
«Hanno mille e mille giovenche e mille buoi rubati nelle nostre stalle. In tutta la pianura del Po, non è rimasto nemmeno un animale da carne o da latte».
«Dove passano loro non cresce più l’erba. Come ai tempi di Annibale!».
Tasgezio ascoltava e scuoteva la testa. Pensava che la paura ingrandisce tutto. «Mi è stato detto» replicava, «che c’è già di qua dal Po un esercito romano, quello del proconsole Lutazio Catulo, e che tra poco arriveranno dalla Gallia anche le legioni di Mario…»
«Una ragione in più per andarsene!» gridavano quelli che fuggivano: «Non capisci? I Cimbri hanno già vinto i Romani quattro volte, e hanno distrutto l’esercito dei consoli Manlio e Cepione. Nessuno, mai, è riuscito a fermarli. Nessuno può vincerli!».
Insistevano: «Fai come abbiamo fatto noi. Metti le tue cose su un carro, se ce l’hai, e se non ce l’hai mettile su un asino o mettitele in spalla, e vai verso le montagne. Lassù, forse, quei diavoli non arriveranno: ma non è detto».
«Con quel genere di invasori, nessun posto è sicuro!»
Il fabbro continuava a scuotere la testa e non rispondeva. Pensava: “Là dove sta andando tutta questa gente ci sono soltanto sassi e uomini induriti dalle difficoltà della vita, che difenderanno con le unghie e con i denti quel poco che hanno. Se chi scappa dovrà fermarsi in montagna per un po’ di tempo, come farà a sopravvivere?”.
“Cosa mangerà?”.
Molti viandanti raccontavano storie di uomini che avevano tentato di difendere le loro case e i loro congiunti, e avevano fatto una fine orribile. Storie di villaggi dati alle fiamme. Chi aveva avuto la possibilità di vedere i Cimbri diceva che erano dei giganti, molto più grandi dei Romani e anche dei Galli; che avevano delle spade enormi e che si nascondevano il viso con degli elmi, in forma di maschere demoniache.
«Resistergli» dicevano, «significa andare incontro alla morte. Bisogna fare come abbiamo fatto noi: bisogna scappare.»
Tutti quei viaggiatori, e tutti gli abitanti della grande pianura erano Celti, cioè Galli: come lo stesso Tasgezio e come la madre di Tasgezio, la signora Lunilla. Che abitava nella sua stessa casa e che ogni tanto, spinta dalla curiosità, veniva ad ascoltare i discorsi che si facevano sotto la tettoia del fabbro o nella sua officina. Anche lei, come il figlio, cercava di capire chi fossero quegli invasori che a Proh nessuno aveva mai visto e di cui, in pratica, non si sapeva niente di certo. Si diceva che venissero dall’estremo limite del mondo abitato, e che fossero originari di un paese dove il sole si vedeva soltanto d’estate. Si diceva che nella loro patria non crescessero né il grano né la vite né le altre piante che servono all’alimentazione degli uomini. Chissà, si chiedeva Tasgezio, cosa c’era di vero in quelle voci, e cosa poteva avere indotto così tante persone ad abbandonare una terra che per quanto disagevole era pur sempre la loro patria. Cercavano davvero una nuova patria, come sosteneva qualcuno, o a spingerli sulle strade del mondo era stata soltanto quella smania che i Romani chiamavano cupiditas, e che è l’avidità delle cose degli altri? Cosa se ne facevano delle cose degli altri? Chiedeva a quelli che scappavano:
«È vero ciò che ho sentito dire, che gli uomini di quel popolo considerano disonorevole qualsiasi lavoro, e che sanno usare solamente le armi?».
«È vero che le loro donne combattono insieme agli uomini, o comunque li assistono e li incitano durante le battaglie?».
Nessuno però sapeva rispondergli, perché nessuno era vissuto con i Cimbri e nessuno li aveva visti combattere. Nessuno, almeno, che fosse rimasto vivo. Prima di rimettersi in cammino, i viandanti cercavano per l’ultima volta di convincere il fabbro a seguirli. Gli dicevano:
«Chiudi tutto e vieni con noi verso le montagne. Se non vuoi farlo per te, fallo almeno per tua madre».
«Siete rimasti voi due soli in questo villaggio». Lo ammonivano:
«Se quei diavoli arrivano fin qui, per voi due è finita».
«Ci salveranno le Matrone», rispondeva Lunilla. Era una signora placida e bionda, un po’ appesantita dagli anni. Spiegava a chi la stava ascoltando:
«Le Matrone sono quelle donne di pietra che i nostri antenati hanno messo lassù in cima alla collina, perché si vedessero da lontano e perché ci proteggessero. Quando io e mio figlio abbiamo saputo che in pianura era arrivato un popolo di invasori, siamo saliti a interrogarle e loro ci hanno dato dei segni per rassicurarci. Dei segni positivi. Perciò» concludeva sorridendo e allargando le braccia, «siamo rimasti nel nostro villaggio e continueremo a vivere nella nostra casa, finché le Matrone ci diranno che possiamo restare qui».
«Io e mio figlio siamo molto devoti a quelle dee. Ci sono sempre state vicine nei momenti difficili e ci aiuteranno anche in questa occasione: ne sono sicura».
Le Matrone erano una divinità campestre dei Galli, venerata un po’ dappertutto ai piedi delle Alpi e particolarmente presente nel villaggio dov’è incominciata la nostra storia. Il villaggio di Proh aveva e ha tuttora questa particolarità, di trovarsi all’estremo limite della pianura del Po, sotto un’ultima propaggine delle montagne. Ancora oggi il terreno dietro le sue case si incurva e si alza: forma una collina dal profilo arrotondato, un promontorio su cui all’epoca di Tasgezio e Lunilla c’era un masso di pietra gialla che nella parte inferiore serviva da altare e nella parte superiore aveva tre figure femminili rozzamente scolpite. Quel masso, scomparso da tempo immemorabile, era il segno della presenza delle Matrone su quel primo rilievo delle Alpi ed era anche la cosa più notevole di un villaggio, che esiste tuttora con quel nome: Proh. Un nome antico come le piramidi d’Egitto o come le incisioni rupestri della Valcamonica. Un nome misterioso anche nella pronuncia. Il cartello stradale scrive Proh, la parlata locale legge “Pru”: perché? Rispondere non è facile e forse non è nemmeno possibile. Ci troviamo di fronte a una parola dei Celti: a un fossile linguistico, che deve essere accettato così com’è senza la pretesa di capirlo o addirittura di spiegarne l’origine.
(In quanto all’ipotesi, attestata dalle guide turistiche e dai libri degli storici locali, per cui il nome Proh deriverebbe dal latino “petrurium”: pietraia, luogo sassoso, possiamo dire in tutta tranquillità che è una stupidaggine. I nomi, qui, non li davano i Romani ma i Celti: e chissà cosa voleva dire nella loro lingua, se voleva dire qualcosa, la parola Proh! Nel Medioevo, poi, sono arrivati i sacerdoti cristiani, che celebravano i loro riti in latino e quando dovevano scrivere nei registri le parole dei Celti le latinizzavano al momento, secondo la fantasia e la scienza di ognuno. È dalle loro invenzioni che sono nate etimologie strampalate come questa, lontane dalla realtà e anche dal buonsenso. I terreni intorno al villaggio di Proh, anche quelli delle colline che hanno origine morenica, non sono particolarmente pietrosi e non lo sono mai stati.)
In ventuno secoli il mondo è cambiato: è cambiato tutto. Ma Proh-Pru si chiama ancora con il nome che gli avevano dato i Celti e il paesaggio che lo circonda ha conservato la sua piacevolezza anzi l’ha vista accentuarsi per contrasto, da quando la coltivazione del riso ha reso ancora più piatta e più vuota una pianura che nell’anno seicentocinquantaduesimo dalla fondazione di Roma: l’anno dei Cimbri, era ancora ondulata e coperta in parte di foreste. Nei primi mesi di quell’anno, i Cimbri avevano attraversato le Alpi ed erano entrati in Italia: dopo aver sconfitto gli eserciti romani in varie parti d’Europa, e dopo essersi creati una fama di invincibilità, che li precedeva ovunque andassero e rendeva ancora più difficile il compito di chi doveva affrontarli. L’ultima loro vittoria era stata quella che avevano riportato nella valle del fiume Adige contro l’esercito del proconsole romano Lutazio Catulo, mandato a sbarrargli la strada perché non entrassero in Italia. I Romani, in quella circostanza, si erano dati alla fuga e i Cimbri erano dilagati nella valle del Po e nella regione che noi oggi chiamiamo Lombardia, saccheggiando città e villaggi e terrorizzando le popolazioni locali: che non avevano alcuna possibilità di contrastarli e potevano cercare una via di scampo soltanto tra le montagne.
Anche il villaggio di Proh era stato abbandonato dai suoi abitanti e Tasgezio e Lunilla erano le uniche persone rimaste in quelle casupole con i tetti di paglia, che si raggruppavano lungo la strada principale e sotto il promontorio delle Matrone. Il primo ad andarsene era stato il mugnaio con i suoi sacchi di grano e dopo di lui se ne erano andati tutti, ognuno con il suo fardello di coperte e di pentole e di legumi secchi, portato in spalla o caricato sull’asino di casa. Se ne erano andati con i loro animali: con le pecore e le capre e perfino con le oche e le galline, che nessuno aveva voluto abbandonare al loro destino lasciandole libere. «Tutt’al più» dicevano, «le mangeremo per strada. Il viaggio è lungo.»
Il paese, che di solito era pieno di rumori e di vita, adesso era silenzioso. Soltanto il fabbro era rimasto nella sua officina, a tenere accesa la forgia con il mantice o a guardare chi passava per strada, stando appoggiato all’uno o all’altro dei pali che reggevano la tettoia. Diceva di avere fiducia nelle Matrone, come sua madre Lunilla; non diceva, ma sarebbe stata la verità, che aveva fiducia nei Romani. Anche se non li amava come non li amavano la maggior parte dei suoi connazionali. Quegli uomini così presuntuosi e così poco simpatici per chi doveva trattare con loro, avevano però il genio dell’organizzazione. Erano un’entità collettiva come le formiche o le api: presi uno per uno non valevano granché, ma tutti insieme erano invincibili. Nessun popolo, e nemmeno i Cimbri, sarebbe riuscito a scalzarli dalla pianura del Po! Tasgezio ne era sicuro. Pensava che i Romani sarebbero arrivati di lì a qualche giorno, al massimo di lì a qualche settimana. Ci sarebbe stata una grande battaglia, la più grande battaglia che si fosse mai combattuta sotto la montagna ombelico del mondo; e poi, pian piano, tutto sarebbe ritornato com’era prima dell’invasione. I villaggi distrutti sarebbero stati ricostruiti, i morti sarebbero stati dimenticati. Le guerre passano, la vita continua.
Il protagonista della nostra storia, il fabbro Tasgezio, all’epoca di questi fatti era un giovane uomo d’età tra i venti e i trent’anni, con gli occhi azzurri e i capelli biondi come la maggior parte dei suoi connazionali. Era alto di statura e robusto: un vero fabbro, capace di sollevare un carro e di appoggiarlo sui ceppi per staccargli le ruote, e di piegare una sbarra di ferro larga un pollice senza bisogno di scaldarla. Aveva ereditato l’officina e il mestiere di fabbro da suo padre Vidomaro, che gli aveva fatto il torto di morire mentre ancora era giovane e in quel modo lo aveva costretto a continuare la tradizione di famiglia, anche se le sue aspirazioni sarebbero state diverse. Finché era stato vivo il padre, infatti, Tasgezio si era limitato ad aiutarlo in officina quando lui glielo chiedeva, e aveva studiato (ma si era trattato di uno studio senza aule scolastiche e senza libri) per diventare medico secondo la scienza dei Galli. Dai dodici ai diciassette anni era andato a scuola dai druidi, i sacerdoti dell’antica religione del suo popolo, in un cascinale vicino al fiume Sesia dove c’era il loro tempio all’aperto: un bosco sacro, e dove aveva incominciato a orientarsi nei segreti della natura. I maestri lo consideravano un allievo molto promettente; poi però, come si è già detto, i suoi studi delle antiche discipline si erano interrotti dopo la morte del padre, perché non c’era più stata la possibilità di continuarli.
Aveva dovuto lavorare. Era diventato un fabbro, come suo padre e suo nonno.
Il fabbro di Proh.
A vent’anni, Tasgezio si era sposato con una ragazza del suo paese: una certa Decezia che tutti chiamavano Lisca, anzi “la Lisca”. La Lisca aveva un paio d’anni meno di lui; era alta di statura e ben fatta, con una caratteristica che la rendeva diversa da quasi tutte le donne dei Galli e che le veniva certamente da un antenato forestiero: i capelli castani cioè scuri. Sul suo conto, in passato, si erano fatte delle chiacchiere, perché per un certo periodo di tempo era vissuta a Novara in casa di una sorella del padre, e aveva avuto dei fidanzati. (Così, almeno, dicevano le chiacchiere.) Quelle voci, secondo le donne di Proh avrebbero dovuto impedire al fabbro di sposare la Lisca; e anche sua madre Lunilla continuava a chiedergli: «Ci hai pensato bene? Sei sicuro di volerla prendere in moglie?». Lui, però, non aveva dato retta a nessuno. La ragazza gli piaceva e gli piaceva anche il suo carattere, così vivace e superficiale, almeno in apparenza: così allegro, da essere quasi l’opposto del suo. Il matrimonio però era durato poco, perché la sposa non andava d’accordo con Lunilla e non andava d’accordo con Proh. Un giorno d’estate era scomparsa senza salutare nemmeno i suoi genitori e senza che nessuno in paese, tranne Tasgezio, sentisse la sua mancanza. Si era poi saputo che era tornata a vivere a Novara, e che stava con un commerciante di terraglie di origine etrusca, vedovo e con dei figli già grandi. Gli Etruschi, nella pianura sotto il monte Ros, avevano fama di essere persone depravate; e le voci che arrivavano in paese sulla Lisca e sul suo convivente parlavano di “banchetti alla maniera etrusca”, con schiave e schiavi costretti a servire nudi i commensali, o addirittura di orge. Si trattava di voci, cioè di chiacchiere: e chissà poi cosa c’era di vero! Tasgezio ne aveva sofferto; ma non aveva citato in giudizio il commerciante di terraglie, e non aveva fatto niente per riprendersi la moglie. Non era nemmeno andato a cercarla.
«Per me» diceva quando qualcuno gliene parlava, «è come se fosse morta. Stia dov’è.»
In realtà, il fabbro non aveva mai smesso di pensare alla Lisca, nemmeno in quei giorni della grande paura e della fuga di tutti verso le montagne. Guardava tra i carri che sfilavano davanti alla sua casa se ce n’era uno carico di terraglie, con un uomo scuro di pelle e di capelli e una donna molto più giovane. Si diceva:
“Se la Lisca dovrà passare qui davanti si coprirà il viso e farà finta di non vedermi perché si vergognerà, ma io le farò ugualmente un cenno di saluto. Nonostante tutto, non sono ancora riuscito a odiarla: cosa posso farci?”.
“Ci siamo voluti bene e anche lei mi ha voluto bene; a modo suo, ma gliene sono grato lo stesso. Se ne è andata perché non sopportava le chiacchiere del paese e perché ha ceduto a un impulso. È ancora ingenua, e si è lasciata incantare da un uomo che, per quello che mi dicono, potrebbe essere suo padre”.
“Prima o poi tornerà a cercarmi. Le persone cambiano, con l’età, e lei è ancora così giovane!”.
Sua madre ogni tanto lo rimproverava. Sopr...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Premessa. Ieri
- 1. Il fabbro di Proh
- 2. Una battaglia persa, anzi vinta
- 3. La fine di Teutobod
- 4. L’“uomo nuovo”
- 5. Sigrun e il bosco sacro
- 6. Campi Raudii
- 7. Il mostro della palude
- 8. Il sacerdote della Madre Terra
- 9. L’incontro
- 10. I giocolieri etruschi
- 11. L’ultimo dei Teutoni
- 12. Le due sorelle
- 13. Il consiglio di guerra
- 14. L’intruso
- 15. La battaglia secondo gli antichi
- 16. La battaglia secondo noi
- 17. La pioggia e gli arcobaleni
- 18. L’arcus marianus
- 19. Il ritorno di Mario
- 20. Una storia d’amore, anzi due storie
- Congedo. Domani