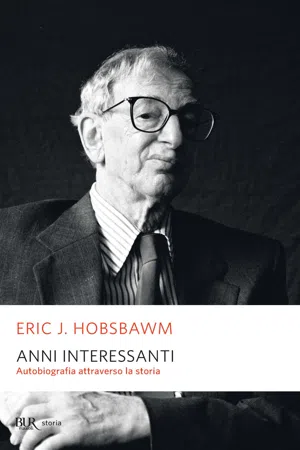![]()
Dedica
Ai miei nipoti
![]()
PREFAZIONE
GLI SCRITTORI DI AUTOBIOGRAFIE devono essere necessariamente anche lettori di autobiografie altrui. Mentre scrivevo questo libro mi ha sorpreso scoprire quanti uomini e donne che ho conosciuto avessero dato alle stampe le loro vite, per non parlare dei personaggi solitamente più in vista o scandalosi che le hanno fatte scrivere da altri. Non contiamo poi il gran numero di scritti di contemporanei che sono autobiografie camuffate da romanzi. Forse la sorpresa è ingiustificata. Le persone la cui professione implica scrivere e comunicare tendono a frequentare altre persone che scrivono e comunicano. Comunque sia, ecco una mole di articoli, interviste, opuscoli, cassette, persino videocassette e volumi come questo, dei quali un numero sorprendente è opera di uomini e donne che hanno trascorso la loro carriera nelle università. Non sono il solo.
Sorge però il problema del perché una persona come me dovrebbe scrivere un’autobiografia o, più precisamente, perché altri, senza particolari collegamenti con me, o che potrebbero non aver saputo della mia esistenza prima di aver visto la copertina in libreria, dovrebbero pensare che valga la pena di leggerla. Non appartengo a quella categoria di individui a cui almeno una catena di librerie londinesi riserva una particolare sottoclasse nella sezione biografie con l’etichetta «Personalità» o, nel gergo odierno, «Celebrità»: cioè non appartengo a quelle persone talmente conosciute per qualsivoglia motivo che il loro nome suscita curiosità attorno alla loro vita. Non appartengo alla classe di persone autorizzate dalla propria vita pubblica a intitolare la propria autobiografia «memorie»; si tratta in genere di uomini e donne che hanno compiuto azioni che vogliono giustificare o documentare dinanzi all’opinione pubblica o che sono vissuti a contatto con i grandi eventi e con le persone che con le loro decisioni hanno influito su questi eventi. Non ho fatto parte di questa schiera. Probabilmente il mio nome apparirà nelle storie di qualche argomento specialistico come il marxismo e la storiografia del ventesimo secolo e forse finirà in qualche libro sugli intellettuali britannici del Novecento. A parte questo, se il mio nome dovesse in qualche modo scomparire completamente, come la lapide dei miei genitori nel Cimitero centrale di Vienna, che ho cercato invano cinque anni orsono, non si aprirebbero vuoti apprezzabili nella narrazione di quel che è successo nella storia del Novecento in Gran Bretagna e altrove.
Inoltre, questo libro non è scritto con quello stile da confessione intima che oggi dà ottimi risultati di vendita, in parte perché l’unica giustificazione di una simile esibizione dell’io è il genio – e io non sono né sant’Agostino né Rousseau – e in parte perché nessun autobiografo vivente potrebbe rivelare verità private su questioni che coinvolgono altre persone viventi senza urtare in maniera ingiustificata la sensibilità di alcune di loro. Non ho un buon motivo per comportarmi in questo modo. Quel genere di rivelazioni appartiene alle biografie postume e non all’autobiografia. In ogni caso, per quanto curiosi, gli storici non tengono rubriche di pettegolezzi. I meriti militari di un generale non devono essere giudicati in base a quello che fa o che non riesce a fare a letto. Tutti i tentativi di spiegare l’economia di Keynes o di Schumpeter in base alle loro vite sessuali, piuttosto intense ma affatto diverse, sono destinati a fallire. Inoltre sospetto che i lettori che amano le biografie scandalistiche troverebbero la mia vita deludente.
Questo libro non è stato scritto nemmeno come apologia della vita dell’autore. Se non volete capire il Novecento, leggete le autobiografie di chi sente il bisogno di autogiustificarsi, di chi perora la propria causa e anche di chi fa esattamente il contrario, cioè il peccatore pentito. Sono solo autopsie in cui il cadavere pretende di essere il medico legale. L’autobiografia di un intellettuale parla necessariamente anche delle sue idee, delle sue inclinazioni e delle sue azioni, ma non dovrebbe essere una perorazione. Penso che questo libro contenga risposte alle domande che molto spesso mi sono state fatte da giornalisti e da altri interessati al caso piuttosto insolito di un comunista che è rimasto tale per tutta la vita benché in maniera anomala, al caso di «Hobsbawm lo storico marxista», ma il mio obiettivo non è stato rispondere a esse. La storia potrà giudicare le mie opinioni – in realtà le ha sostanzialmente giudicate –, i lettori potranno giudicare i miei libri. Cerco di capire la storia, non cerco consenso, approvazione o simpatia.
Ci sono però alcune ragioni per cui potrebbe valere la pena di leggere questo libro, a prescindere dalla curiosità di ogni essere umano per altri esseri umani. Ho vissuto quasi tutto il secolo più straordinario e terribile della storia umana. Ho vissuto in paesi diversi e ne ho visitati parecchi altri in tre continenti. Forse, nel corso di questa lunga vita, non ho lasciato nel mondo un’impronta visibile, anche se ho lasciato una notevole quantità di tracce impresse sulla carta, ma da quando, all’età di sedici anni, mi sono reso conto di essere uno storico, ho osservato e ascoltato per la maggior parte della mia vita e ho cercato di capire la storia del mio tempo.
Quando, dopo aver scritto sulla storia del mondo dalla fine del Settecento al 1914, ho finalmente cercato di esporre la storia di quello che ho chiamato Il Secolo breve,1 penso che quel libro abbia tratto beneficio dal fatto di essere stato scritto non solo da uno studioso, ma da quello che gli antropologi chiamano «osservatore partecipe». Due sono stati i vantaggi di questa condizione: i miei ricordi personali di eventi lontani nel tempo e nello spazio hanno chiaramente avvicinato la storia del ventesimo secolo ai lettori più giovani, mentre hanno ravvivato i ricordi di quelli più anziani; inoltre, più di ogni altro mio libro, Il Secolo breve è stato scritto con la passione propria dell’età dei grandi cataclismi, per quanto cogenti siano gli obblighi della ricerca storica. Me l’hanno confermato tutt’e due i tipi di lettore. Ma al di là di questo c’è un modo più profondo in cui l’intrecciarsi della vita e dell’epoca di una persona, e la sua personale osservazione di entrambe, contribuisce a conformare un’analisi storica che spero si renda indipendente da entrambe.
È esattamente quello che può fare un’autobiografia. In un certo senso questo libro è l’altra faccia del Secolo breve: non una storia mondiale illustrata dall’esperienza di un individuo, ma la storia mondiale che conforma l’esperienza o meglio che offre un insieme mutevole ma sempre limitato di scelte a partire dalle quali, per adattare una frase di Karl Marx, «gli uomini costruiscono [la loro vita], ma non [la] costruiscono come meglio preferiscono, non [la] costruiscono nelle circostanze scelte da loro stessi, ma nelle circostanze incontrate, date e trasmesse dal passato» e, si potrebbe aggiungere, dal mondo che li circonda.
Sotto un altro aspetto l’autobiografia di uno storico è un pezzo importante della costruzione del suo lavoro. Accanto a una fiducia nella ragione e nella differenza tra fatto e finzione, la consapevolezza di sé – cioè la capacità di vedere le cose sia dal proprio punto di vista sia da quello altrui – è una virtù necessaria a chiunque si occupi di storia e di scienze sociali, e in particolare a uno storico che, come me, ha scelto i suoi argomenti intuitivamente e casualmente, ma ha finito per conformarli, almeno spero, in un insieme coerente. Alcuni storici potrebbero prestare maggiore attenzione a questi aspetti più professionali del mio libro, ma spero che altri lettori lo leggeranno come un’introduzione al secolo più straordinario della storia del mondo attraverso il percorso di un essere umano la cui vita non sarebbe potuta accadere in alcun’altra epoca.
La storia, come dice la mia collega e filosofa Agnes Heller, «riguarda quello che succede visto dall’esterno, mentre le memorie riguardano quello che succede visto dall’interno». Questo non è un libro nel quale io debba riconoscere il mio debito verso altri studiosi, ma può essere solo l’occasione per porgere ringraziamenti e chiedere scusa. I ringraziamenti vanno innanzitutto a mia moglie Marlene, compagna di metà della mia vita, che ha letto e criticato tutti i capitoli allo scopo di migliorarli e ha sopportato gli anni in cui un marito spesso distratto, di cattivo umore e a volte scoraggiato, ha vissuto meno nel presente che in quel passato che cercava di mettere sulla carta. Ringrazio anche Stuart Proffitt, un principe tra gli editor. Le persone che ho consultato nel corso degli anni su questioni pertinenti a questa autobiografia sono troppo numerose per essere ricordate, anche se molti sono morti da quando ho cominciato la stesura del libro. Loro sanno perché li ringrazio.
Le mie scuse vanno anche a Marlene e alla mia famiglia. Questa non è l’autobiografia che avrebbero potuto preferire, perché, anche se sono costantemente presenti (almeno fin dal momento in cui sono entrati nella mia vita e io nella loro), questo libro parla più dell’uomo pubblico che di quello privato. Dovrei scusarmi anche con quegli amici, quei colleghi, quegli studiosi e tutti coloro che sono assenti da queste pagine e che avrebbero potuto aspettarsi di essere qui citati o ricordati più a lungo.
Ho organizzato il libro in tre parti. Dopo una breve ouverture, i capitoli da 1 a 16, che trattano di vicende personali e politiche più o meno in ordine cronologico, coprono il periodo che va da quando cominciano i miei ricordi – i primi anni Venti – fino all’inizio degli anni Novanta. Ma non sono pure e semplici cronache. I capitoli 17 e 18 parlano della mia carriera di storico. I capitoli da 19 a 22 trattano di quattro paesi o regioni (diversi dalla mia natia Mitteleuropa e dall’Inghilterra) con cui ho avuto rapporti per lunghi periodi della mia vita: Francia, Spagna e Italia, America latina e altre zone del Terzo Mondo, e gli Stati Uniti. Siccome coprono per intero i miei rapporti con quei paesi, non si adattano facilmente alla narrazione cronologica principale, anche se vi si sovrappongono. Perciò ho ritenuto opportuno tenerli separati.
Londra, febbraio 2002
ERIC HOBSBAWM
![]()
CAPITOLO 1
Ouverture
UN GIORNO DELL’AUTUNNO 1994 mia moglie Marlene – che a Londra si occupava della corrispondenza mentre io tenevo un corso alla New School di New York – mi telefonò per dirmi che era arrivata una lettera da Amburgo, ma che non poteva leggerla perché era scritta in tedesco. Veniva da un persona che si firmava Melitta. Era il caso di inoltrarmela? Non conoscevo nessuno ad Amburgo, ma senza un attimo di esitazione capii chi l’aveva scritta, anche se erano trascorsi quasi tre quarti di secolo dall’ultima volta che avevo visto la mittente. Poteva essere solo la piccola Litta – in realtà maggiore di me di un anno circa – che abitava nella villa Seutter a Vienna. Non mi sbagliavo. Scriveva di aver visto il mio nome in un articolo su Die Zeit, il settimanale liberal-intellettuale tedesco. Era giunta subito alla conclusione che dovevo essere quell’Eric con cui lei e le sue sorelle avevano giocato da piccole, molto tempo addietro. Aveva sfogliato gli album di fotografie e le era capitata sottomano una foto, che aveva allegato alla lettera. Nell’immagine apparivano cinque bambini in posa sulla terrazza inondata di sole della villa, insieme con le rispettive Fräulein. Le bambine – e forse anch’io – portavano in testa ghirlande di fiori. Litta vi era raffigurata con le due sorelle più piccole Ruth ed Eva (Susie, sempre chiamata Peter, non era ancora nata), e io ero con mia sorella Nancy. Il padre di Litta aveva scritto una data sul retro della foto: 1922. Nella lettera Litta mi chiedeva come stava Nancy. Come poteva sapere che Nancy, più giovane di me di tre anni e mezzo, era morta un paio d’anni prima? Durante la mia ultima visita a Vienna ero andato a cercare le case in cui avevamo vissuto e avevo mandato a Nancy delle foto di quelle abitazioni. Avevo pensato che fosse la sola a condividere i miei ricordi di villa Seutter. E ora, invece, l’immagine di quella villa tornava a farsi viva davanti ai miei occhi.
Anch’io ho una copia di quella foto. Nell’album fotografico di famiglia che è rimasto a me, poiché i miei genitori e i miei fratelli e sorelle sono ormai morti, gli scatti presi sulla terrazza di villa Seutter costituiscono il secondo documento iconografico della mia esistenza e il primo dell’esistenza di mia sorella Nancy, nata a Vienna nel 1920. La prima immagine che mi ritrae è la foto di un bambino in un’enorme carrozzella di vimini senza nulla e nessuno intorno e che presumo sia stata scattata ad Alessandria d’Egitto – dov’ero nato nel giugno 1917 – per far registrare la mia nascita al consolato britannico (dove, peraltro, il funzionario riuscì a sbagliare data e cognome). Le istituzioni diplomatiche del Regno Unito presiedettero così sia al mio concepimento, sia alla mia nascita: era stato infatti in un altro consolato britannico, quello di Zurigo, che mio padre e mia madre si erano sposati. Il loro matrimonio aveva richiesto una dispensa ufficiale firmata personalmente da Sir Edward Grey, ministro degli Esteri, che permetteva a Leopold Percy Hobsbaum, suddito di Giorgio V, di unirsi in matrimonio con Nelly Grün, suddita dell’imperatore Francesco Giuseppe, in un’epoca in cui i due imperi erano in guerra tra loro – un conflitto al quale il mio futuro padre reagì con quel che gli restava di patriottismo britannico, ma che la mia futura madre aborrì. Nel 1915 in Gran Bretagna non c’era la leva obbligatoria ma, se ci fosse stata – disse mia madre a mio padre – lui avrebbe dovuto dichiararsi obiettore di coscienza. 1 Mi piacerebbe che fossero stati uniti in matrimonio da quel console che è il personaggio principale della commedia di Tom Stoppard Travesties. Mi piacerebbe anche che, mentre attendevano a Zurigo che Sir Edward Grey, mettendo da parte per un momento affari molto più urgenti, si occupasse del loro matrimonio, sapessero quali erano i loro compagni di esilio nella città: Lenin, James Joyce e i dadaisti. In realtà non lo sapevano e quasi certamente, in quel momento, la cosa non li avrebbe neppure interessati: com’è ovvio, tutti i loro pensieri erano rivolti all’imminente luna di miele a Lugano.
Come sarebbe stata la mia vita se la diciottenne Fraülein Grün – una delle tre figlie di un gioielliere viennese abbastanza ricco – non si fosse innamorata nel 1913 ad Alessandria di un inglese più anziano di lei, quarto degli otto figli di un ebanista ebreo londinese emigrato? Presumibilmente, avrebbe sposato un giovanotto della borghesia ebraica della Mitteleuropa e i suoi figli sarebbero cresciuti in Austria. Dal momento che quasi tutti i giovani ebrei austriaci finirono per diventare emigranti o profughi, la mia vita successiva non sarebbe forse stata molto differente da quella che ho avuto: molti di loro, infatti, si trasferirono in Inghilterra, dove studiarono e diventarono accademici. Ma non sarei cresciuto né sarei arrivato in Gran Bretagna da cittadino inglese con regolare passaporto.
Non potendo vivere in nessuno dei due paesi in guerra, i miei genitori tornarono – passando da Roma e da Napoli – ad Alessandria, dove si erano conosciuti e si erano fidanzati prima della Grande Guerra, e dove entrambi avevano dei parenti: lo zio di mia madre, Albert, del cui emporio di Nouveautés ho ancora una foto con tanto di personale al completo, e il fratello di mio padre, Ernest, di cui porto il nome e che aveva lavorato per le Poste e Telegrafi egiziani. (Dal momento che tutte le vite private sono materia prima per gli storici come per i romanzieri, ho utilizzato la circostanza del loro incontro per introdurre la mia storia dell’Età degli imperi.2) Non appena la guerra finì, si trasferirono a Vienna con il loro figlioletto di due anni. Ecco perché l’Egitto, al quale sono legato finché vivo dalle catene dei documenti anagrafici ufficiali, non fa parte della mia vita. Non ricordo nulla di questo paese, se non forse una gabbia di uccellini allo zoo di Nouzha e, vagamente, un frammento di una nenia infantile ellenica, forse cantatami da una balia greca. Né ho qualche curiosità per il luogo in cui sono nato, il quartiere dello Sporting Club, lungo la linea tranviaria che va dal centro di Alessandria a Ramleh; d’altronde non c’è molto da dire su quest’area, stando a E.M. Forster che visse ad Alessandria quasi nello stesso periodo in cui vi risiedettero i miei genitori. Nel suo Alessandria d’Egitto: storia e guida,3 tutto ciò che scrive sulla stazione tranviaria dello Sporting Club è che si trova «vicino alla tribuna centrale dell’ippodromo. La spiaggia per i bagni è a sinistra».
L’Egitto non appartiene quindi alla mia vita. Non so quando abbia inizio la memoria, ma certo sono pochi i ricordi che risalgono all’età di due anni. Non ci sono mai più tornato da quando il vaporetto Helouan salpò da Alessandria alla volta di Trieste, che era appena passata dall’Austria all’Italia. Non ricordo alcunché del nostro arrivo a Trieste, crocevia di lingue e razze diverse, una città di lussuosi caffè e di capitani di nave, sede di una grande compagnia di assicurazioni, le Generali, il cui impero economico definisce forse nel modo migliore il concetto di Mitteleuropa. Ottant’anni più tardi ebbi l’occasione di scoprire la città in compagnia di amici triestini e in particolare di Claudio Magris, questo meraviglioso memorialista della storia dell’Europa centrale e di quell’angolo dell’Adriatico in cui convergono la cultura tedesca, italiana, slava e...