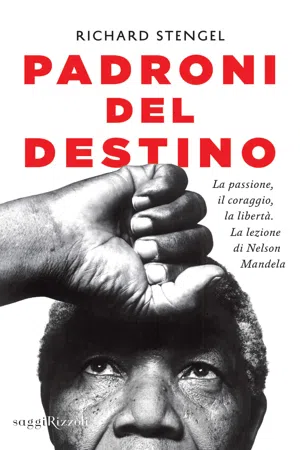![]()
Padroni del destino
![]()
Prefazione
In Africa esiste un concetto chiamato ubuntu, il cui senso profondo è che noi siamo uomini solo grazie all’umanità altrui e che se, in questo mondo, riusciamo a realizzare qualcosa di buono, il merito sarà in egual misura anche del lavoro e delle conquiste degli altri. Richard Stengel ha compreso in pieno questo concetto.
È uno scrittore straordinario, che conosce a fondo la mia storia, e gli sono infinitamente grato per la preziosa collaborazione durante la stesura del Lungo cammino verso la libertà. Ricordo con grande affetto le infinite ore trascorse a conversare e il duro lavoro svolto insieme su quel progetto.
Ha dimostrato di avere delle incredibili intuizioni sulle numerose e delicate problematiche che ancora oggi il mondo e i suoi abitanti devono affrontare.
E tutti quanti possiamo farne tesoro.
Nelson Mandela
![]()
Un uomo complesso
Nelson Mandela è stato forse l’ultimo vero eroe: simbolo del sacrificio e della rettitudine, sempre con il sorriso sulle labbra, venerato da milioni di persone come un santo vivente. Tuttavia questa immagine è riduttiva: lui per primo avrebbe detto che non era un santo, e non lo avrebbe fatto per falsa modestia.
Nelson Mandela era un uomo dalle mille contraddizioni. Era immune alle critiche, ma allo stesso tempo vulnerabile. Si preoccupava per gli altri, ma spesso ignorava chi gli era più vicino. Era generoso con il denaro, ma contava fino all’ultimo centesimo quando doveva lasciare una mancia. Non avrebbe mai calpestato un ragno o un grillo, ma era stato il comandante delle forze armate dell’African National Congress.
E ancora, era sì un uomo del popolo, ma gli piaceva la compagnia di personaggi celebri. Adorava essere cortese, ma non aveva paura di dire no. Non amava prendersi il merito, ma quando gli spettava lo puntualizzava. In cucina stringeva le mani a chiunque, ma non conosceva il nome delle sue guardie del corpo.
Era la sintesi perfetta tra un sovrano africano e un aristocratico inglese: un gentleman in dashiki di seta, insomma.
I suoi modi erano impeccabili: dopotutto li aveva appresi nelle scuole coloniali britanniche, da professori emeriti che leggevano Dickens quando Dickens scriveva ancora. Era molto cerimonioso: avrebbe accennato un inchino con un gesto della mano per cedervi il passo, ma se avesse dovuto raccontare delle condizioni igieniche della prigione di Robben Island o del rituale tribale della circoncisione che subì a sedici anni non sarebbe stato minimamente schizzinoso o puritano, e si sarebbe prodigato in descrizioni dettagliate.
Usava l’argenteria se si trovava a Londra o a Johannesburg, ma a casa sua, nella regione del Transkei, mangiava come vuole la tradizione locale: con le mani.
Nelson Mandela era un perfezionista: prendeva i fazzoletti dalla scatola e li piegava uno a uno prima di metterli nel taschino. Ricordo di averlo visto sfilarsi una scarpa durante un’intervista per rivoltare un calzino che aveva indossato a rovescio.
In prigione ha riscritto in bella copia tutte lettere redatte in più di vent’anni e ha creato una dettagliata lista di quelle ricevute, registrando la data di ricezione e quella di invio della sua risposta. Dormiva su un lato solo del suo enorme letto matrimoniale, lasciando intatta, quasi immacolata, l’altra metà. Ricordo ancora l’espressione allibita di un inserviente d’albergo nel vedere Mandela rassettare il proprio letto. Detestava essere in ritardo e considerava la mancanza di puntualità un difetto di carattere.
Non ho mai conosciuto nessuno più composto di Nelson Mandela. Quando stava seduto o in ascolto non picchiettava le dita, non batteva i piedi, non faceva movimenti di nessun genere; non aveva neanche il più piccolo tic nervoso. Ogni volta che mi sono ritrovato a sistemargli la cravatta, a lisciargli le pieghe della giacca o a fissargli il microfono al bavero, ho avuto l’impressione di ricoprire d’attenzioni una statua. Quando ti ascoltava, sembrava di parlare a una sua fotografia, a malapena si poteva dire che stava respirando.
Era un uomo dal grande carisma, consapevole di saper ammaliare chiunque, con qualsiasi mezzo possibile. Attento, raffinato, affascinante e, per usare un termine che lui avrebbe detestato, seducente. E su questa cosa lavorava moltissimo, tanto che prima di incontrare qualcuno cercava sempre d’imparare il più possibile sul suo conto. Quando fu liberato per la prima volta, per esempio, lesse tutti gli articoli a riguardo ed elogiò i giornalisti uno a uno, con riferimenti specifici. Come tutti i più grandi ammaliatori, poi, anche lui si lasciava facilmente incantare: bastava fargli capire che ti aveva conquistato.
Il suo fascino era tanto politico quanto personale. La politica è fondamentalmente una questione di persuasione ed egli infatti si considerava non tanto un Gran Comunicatore, quanto un Gran Persuasore. Mandela era capace di conquistare sia con brillanti ragionamenti sia con il suo fascino e, più di frequente, con una combinazione delle due cose.
Era capace di convincerti a fare qualcosa piuttosto che ordinartelo, ma l’ordine sarebbe stato perentorio se vi fosse stata la necessità.
Voleva a tutti i costi piacere; essere ammirato gli piaceva. E questo perché detestava deludere le persone. Desiderava che dopo un incontro con lui, il suo interlocutore andasse via pensando di non aver mai conosciuto una persona migliore.
Spendersi così tanto con chiunque richiedeva una straordinaria energia: a volte era così stanco che i suoi occhi a mezz’asta davano l’impressione che stesse dormendo in piedi. Ma non ho mai visto nessuno come lui rinvigorirsi tanto con una bella dormita. Alle dieci di sera crollava, ma otto ore dopo, alle sei del mattino, era di nuovo pimpante, come fosse ringiovanito di vent’anni.
Il fascino che esercitava sugli altri era inversamente proporzionale al grado di conoscenza che aveva di chi gli stava di fronte: molto cordiale con gli sconosciuti, ma freddo con chi gli era più vicino.
Elargiva quel suo celebre sorriso benevolo a chiunque incontrasse per la prima volta. Riservava però un sorriso soltanto agli estranei: vedendolo in più occasioni in compagnia dei suoi figli e delle sorelle egli appariva spesso severo, accigliato, ben poco interessato ai loro problemi.
Dopotutto, era un padre «vittoriano-africano», di certo non un genitore moderno. Quando gli si chiedeva qualcosa di cui non voleva parlare, assumeva un’espressione contrariata, e il suo sorriso si smorzava. In questo caso era meglio non insistere, altrimenti sarebbe diventato gelido, distaccato, e avrebbe rivolto la sua attenzione altrove. Quando questo accadeva, sembrava di assistere al repentino annuvolamento di un cielo limpido fino a pochi secondi prima.
Mandela era indifferente a quasi tutto ciò che è materiale – non gli interessavano le macchine né gli orologi – eppure l’ho visto mandare una sua guardia del corpo in un negozio a un’ora di macchina solo per avere una penna della sua marca preferita. Per quanto concerne il denaro era molto generoso con i suoi bambini, ma non si può dire lo stesso con le mance che lasciava ai camerieri. Una volta ho pranzato con lui in un ristorante di lusso a Johannesburg, dove è stato servito e riverito. Non appena arrivò il conto, di oltre 1000 Rand (N.d.T. circa 80 euro), mi fermai a osservarlo mentre prendeva dalla mano poche monetine per lasciare una mancia striminzita. Quando si alzò, senza farmi notare, feci scivolare sul tavolo una banconota da 100 Rand (N.d.T. circa 10 euro). E non fu né la prima né l’ultima volta.
Mandela è sempre stato un testardo e inflessibile sostenitore di ciò che lui riteneva essere giusto. Spesso gli ho sentito dire «Questo non è giusto», a proposito di una cosa da niente o di un affare internazionale, con lo stesso tono. Gliel’ho sentito dire quando la chiave di sicurezza non apriva la porta del suo ufficio ma anche al presidente del Sudafrica, F.W. de Klerk, durante alcune negoziazioni riguardo alla Costituzione del Paese. Per anni, a Robben Island, usò quest’espressione rivolgendosi tanto alle guardie quanto al direttore della prigione.
In un certo senso, questa intolleranza all’ingiustizia è stata la forza che l’ha spronato nelle sue battaglie. È stato il motore del suo scontento, il suo verdetto riguardo all’immoralità dell’apartheid. Era sbagliato, era ingiusto, e lui ha cercato di sistemare le cose.
Come faccio a sapere tutto questo? Ho collaborato con Mandela alla sua autobiografia. Ci abbiamo lavorato insieme per circa tre anni e durante questo periodo l’ho visto quasi ogni giorno: ho viaggiato e pranzato insieme a lui, gli ho lustrato le scarpe, gli ho annodato la cravatta e ho trascorso ore e ore a conversare con lui sulla sua vita e le sue imprese.
Il mio percorso con Mandela è stato quasi del tutto accidentale. Arrivai in Sudafrica per caso, al posto di un altro giornalista che si era ritrovato all’ultimo minuto a dover annullare il viaggio. Colsi quindi l’occasione per scrivere un libro sulla quotidianità di una piccola città sudafricana durante l’apartheid.
Quando l’editor di Mandela si ritrovò tra le mani il mio libro, mi offrì l’opportunità di lavorare sull’autobiografia del rivoluzionario sudafricano.
Così raggiunsi Johannesburg nel dicembre del 1992 per incontrare Nelson Mandela.
Erano anni duri e pericolosi per il Sudafrica sull’orlo della guerra civile. Mandela era stato scarcerato da meno di tre anni e stava lottando duramente per consolidare la sua leadership e condurre il Paese verso le prime elezioni democratiche. Lavorare all’autobiografia non era certo il primo dei suoi pensieri, eppure voleva raccontare la sua storia.
Mi fece aspettare un mese intero prima di poterlo intervistare e quando finalmente ci incontrammo quasi capovolsi il progetto.
Stavo seduto in un corridoio, fuori dal suo vecchio ufficio nel quartier generale dell’African National Congress, aspettando che prima o poi si palesasse. Lo cercai con lo sguardo e lo vidi avanzare verso di me: camminava lentamente, in modo controllato, quasi a rallentatore. La prima cosa che notai fu il color caramello della sua pelle. I lineamenti del suo volto mi parvero subito armoniosi, con zigomi ben pronunciati, dal tocco quasi asiatico. Alto quasi un metro e ottanta, tutto di lui, dalla testa alle mani, mi sembrò di dimensioni impressionanti. Non appena si avvicinò, mi alzai.
«Ah, lei deve essere…» disse lui, e poi attese che concludessi io la frase.
«Richard Stengel» ribattei, e lui mi porse la mano, calda e asciutta; le sue dita erano gonfie e la pelle era ancora rovinata da decenni di lavori forzati.
Mi esaminò con attenzione. «Ah» esordì con un sorriso, «lei è molto giovane». Queste parole non mi suonarono come un complimento. Mi fece cenno di accomodarmi nel suo ufficio ed entrai. La stanza era grande, l’arredamento formale, tutto era pulito. Sembrava un ufficio di rappresentanza, ma non lo era affatto. Si fermò un attimo per scambiare poche parole con la sua assistente, una donna minuta e scattante che gli porse un documento da firmare. Mandela prese il foglio con cautela; mi sembrò evidente che facesse tutto con estrema cura. Si sedette alla scrivania e cominciò a leggere con attenzione, parola per parola. Firmò lentamente, come se volesse perfezionare la calligrafia. Poi si alzò, diretto alla poltrona di pelle logorata che si trovava di fronte al sofà, e mi chiese quando fossi arrivato. La sua voce era leggermente impastata, come una tromba con la sordina.
«È giunto fin qui solo per questo progetto o per qualcos’altro?» mi domandò.
Il mio cuore cominciò a palpitare. La domanda implicava che l’autobiografia non fosse un motivo sufficiente a giustificare la volontà d’intraprendere quel viaggio. Gli risposi che ero giunto lì solo ed esclusivamente per il libro, e lui annuì. Lui non sprecava le parole.
Mi disse che stava pianificando una vacanza, e che il suo staff aveva preventivato quattro o cinque giorni liberi di modo che noi due potessimo parlare del progetto. Aggiunse che sperava che avremmo finito il lavoro prima della sua partenza, che sarebbe avvenuta da lì a dieci giorni. Avevo trascorso un mese a telefonare continuamente per fissare un appuntamento, senza mai ricevere una risposta, e avevo passato mesi cercando e raccogliendo materiale, quindi fu forse la frustrazione repressa che mi spinse a sollevare leggermente il tono della voce e a dirgli: «Quattro o cinque giorni? Se lei crede di poter scrivere un libro con quattro o cinque incontri lei si… lei si…» non riuscivo a trovare la parola giusta «… lei si sta illudendo».
Ero al cospetto di Nelson Mandela da meno di dieci minuti e gli stavo dicendo che non aveva alcuna cognizione della realtà. Lui mi guardò inarcando leggermente un sopracciglio e poi si alzò. Pensai mi stesse per cacciare.
Andò invece verso la sua scrivania, chiamò la sua assistente e le disse: «Il signor Stengel è qui e stiamo cercando di elaborare un piano». Si rivolse di nuovo a me comunicandomi che quella sera aveva un impegno, ma che non aveva alcuna intenzione di mettermi fretta e che avrei dovuto parlare con la sua segretaria il lunedì mattina. Con quelle parole mi ritrovai fuori dal suo ufficio e, temetti, fuori dalla sua vita. Il lunedì successivo, di sera, ricevetti invece una chiamata in cui mi veniva comunicato che avrei potuto incontrarlo la mattina seguente.
Prontamente, alle sette, ci ritrovammo seduti agli stessi identici posti della prima volta. «Cominciamo» disse lui, come un giudice pronto ad avviare un processo. Mi schiarii la voce e mi scusai innanzitutto. «Mi dispiace, sono stato così… così…» e mi fermai ancora perché non riuscivo a trovare la parola giusta «… così brusco con lei, l’altro giorno». Quella parola suonava estranea e pretenziosa. Lui mi guardò e sorrise, un sorriso divertito, comprensivo ma anche un po’ annoiato.
«Lei deve essere davvero un giovane molto gentile» disse «se crede che la nostra conversazione dell’altro giorno sia stata brusca», e pronunciò la parola molto accuratamente con una «r» vibrante e un’aspra «c». Mi misi a ridere. Aveva trascorso ventisette anni in prigione con delle guardie che per tutto il tempo lo avevano considerato meno di un essere umano, trattato con una brutalità che lui stesso dava per scontata. E prima di tutto questo, per la polizia e per l’esercito era stato un terrorista che andava fermato a ogni costo. Aveva vissuto in un Paese dove la classe dirigente dei bianchi non lo considerava, a malapena lo trattava alla stregua di un essere umano. Tutto questo era molto più che brusco.
Fu l’inizio della nostra amicizia. In due anni ho accumulato più di settanta ore d’interviste con lui, praticamente nulla in confronto alle ore, i giorni e i mesi trascorsi l’uno in compagnia dell’altro.
Sin dal principio mi ero imposto di stargli vicino fino a quanto lui potesse tollerare – agli incontri, agli eventi, durante le vacanze e i viaggi di Stato. Ho trascorso ore e ore con lui nella sua casa ad Houghton, l’ho accompagnato in viaggio nel suo paese natale, nella regione del Transkei, e l’ho anche seguito in America, in Europa e ovunque in Africa. Con lui ho partecipato a campagne politiche, sono andato a incontri di negoziazioni e trattative diventando la sua ombra. Ho tenuto un diario: più di 120.000 parole. Gran parte di questo libro viene da questi appunti di viaggio. Chiunque abbia passato del tempo con Nelson Mandela sa che non è solo un grande privilegio, ma anche un enorme piacere. La sua presenza era preziosa, luminosa, ti faceva sentire migliore, più buono. La maggior parte delle volte era allegro, ottimista, sicuro di sé, generoso e divertente. Persino quando l’intero peso del mondo gravava sulle sue spalle lui sembrava capace di sostenerlo senza troppa fatica. Quando si passava del tempo al suo fianco si era consapevoli di vivere la storia così come stava per essere fatta. Mi ha lasciato tanto della sua vita, qualcuno dei suoi pensieri e un piccolo pezzo del suo cuore.
Lui mi ha esortato a sposare mia moglie, anche lei sudafricana, ed è stato lui il padrino del mio primogenito. Gli voglio un bene infinito. È stato la causa di molte delle più belle cose che mi sono capitate. Quando abbiamo finito il libro, è stato come se il sole fosse uscito dalla mia vita.
Ci siamo frequentati pe...