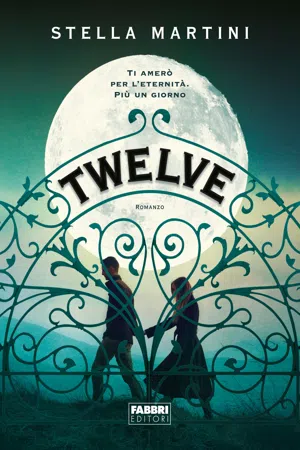![]()
One
Abel
A guardarlo da lontano, l’Overlake Hotel ha qualcosa di spaventoso. Affacciato sul lago e circondato dalla foresta, ha l’aria di un castellaccio appollaiato come un’aquila sul picco della montagna. Man mano che ti avvicini lo spazio intorno appare lugubre, carico di una inesorabile decadenza, di quelle che non possono non suscitare cattivi pensieri.
Da piccolo, mia madre mi ci portava solo se davvero non poteva farne a meno. Avevamo bisogno di soldi e lei, oltre a cucinare, rifaceva le camere degli ospiti. Io, intanto, passavo le giornate a gironzolare per i lunghissimi corridoi dell’hotel, che con gli occhi di allora mi sembravano infiniti. Mi divertivo ad ascoltare l’eco dei rumori dell’albergo: una porta che sbatteva, l’ascensore che portava i nuovi ospiti al piano, una valigia che urtava contro la parete, le voci degli avventori…
Non c’era suono che non riverberasse contro quelle pareti, rimbalzando come una pallina impazzita da un corridoio all’altro.
Occupavo così il mio tempo, mentre Martha, mia madre, era al lavoro nelle cucine. Il vecchio Herr Joseph, il proprietario dell’albergo, l’aveva assunta quando era rimasta vedova, assolvendo a un tacito accordo preso con mio padre, di cui era grande amico. Gente di montagna: poche pacche sulle spalle o strette di mano, ma un aiuto concreto nel momento del bisogno.
All’epoca io avevo tre anni, e da allora mia madre ha sempre cercato di non farmi mancare nulla. Vivo qui, all’interno dell’albergo, in una stanza al secondo piano che si affaccia sul bosco. Le camere con la vista sul lago sono riservate per gli ospiti paganti. Come il signor Krug, ad esempio, un austriaco con i baffi da vichingo e il ventre pronunciato, che da quindici anni viene qui, sempre nello stesso periodo, e occupa la stessa stanza a picco sulle acque.
Io comunque lo preferisco, il bosco. Mi affascina, e poi non saprei proprio quando ammirare il panorama visto che, alla fine, non è che abbia tutto questo tempo libero.
All’hotel il lavoro inizia presto, alle sette del mattino. Mi alzo, faccio una colazione veloce, poi subito in giardino, dove mi occupo di tener pulita la piscina e di aprire le sedie a sdraio per gli ospiti. La stagione è appena iniziata e sono ancora pochi. Una decina al massimo, ai quali stasera se ne aggiungeranno due, molto speciali.
Me lo comunica Herr Joseph, scoprendomi intento a fissare la sagoma di un grosso SUV che sta varcando il cancello principale.
«È mio figlio Albert, con Leonor.»
Non aggiunge altro, perché non è necessario. Non gli piace e non gli è mai piaciuto che io passassi del tempo con Leonor, nemmeno quando eravamo molto piccoli: lei era già la principessa di casa, tenuta in palmo di mano. Una bambina silenziosa e fragile, con occhi profondi molto più adulti della sua età.
Albert, il padre di Leonor, è un brav’uomo che ormai da anni si è trasferito a trecento chilometri da qui. Nemmeno a lui, però, le cose sono andate tanto bene, negli ultimi tempi. Mia madre dice che Leonor non sta bene; quanto alla moglie, tutti ormai sanno di quella brutta storia, anche se non si conoscono i dettagli.
Di Leonor ricordo poco. Solo episodi di poca importanza: una gara con i bob durante un’imprecisata vacanza di Natale, una caccia alle lucciole in una notte d’agosto, qualche tuffo in piscina sotto gli occhi indulgenti di sua madre. Ci siamo fatti compagnia un tempo, ora sembra un migliaio di anni fa, e siamo cresciuti insieme ma a debita distanza. Non che avessimo grandi alternative, del resto: nessun coetaneo nei paraggi, visto che i turisti si portavano appresso i figlioletti anche durante le scalate, e così eravamo solo io e lei, compagni di giochi in quei lunghissimi pomeriggi. Mai da soli, però. Il nonno, Joseph, era sempre in allerta, sospettoso. Pretendeva che ci fosse sempre un adulto a sorvegliarci, come se dei ragazzini di otto anni potessero ficcarsi in chissà quale pasticcio.
Abbiamo smesso di vederci dopo che ho compiuto gli undici anni, quando mi hanno ingabbiato in quella scuola speciale, il collegio Saint Maurice. Ho cominciato a trascorrere in istituto anche le vacanze estive, se così si potevano ancora chiamare.
Per fortuna quei tempi sono finiti. Ci penso mentre guardo Leonor scendere dall’auto. Veste completamente di nero, e sembra ancora più magra e pallida di quanto non sia già. Ha la faccia imbronciata, grave, e due auricolari ficcati nelle orecchie.
Sono nella traiettoria del suo sguardo, ma lei non mi vede, o finge di non vedermi. Saluta il nonno con un abbraccio frettoloso ed entra nell’albergo.
Una volta non era così. Sorrideva e indossava solo abiti allegri e sgargianti.
Albert, invece, mi riconosce. Mi viene incontro per stringermi la mano e mi saluta con calore.
«Come stai Abel? Tutto bene?»
Annuisco. «Bentornati» dico.
«Prendi i loro bagagli» mi ordina il vecchio Joseph.
Di solito non faccio il facchino, ma quando lui dà un ordine è meglio non discutere.
Albert mi aiuta a trasportare le valigie. Sono grosse e pesanti, come se si fossero portati dietro tutta la loro vita. O forse vogliono fermarsi per i mesi estivi: il pensiero, per qualche motivo che non comprendo, accende in me la scintilla di una nuova felicità.
«Come sta Leonor?» domando mentre trascino su per le scale una borsa rosa che probabilmente le appartiene.
«È un po’ depressa» risponde Albert. «Spero che stare qui l’aiuti a uscire da questo umore cupo.» Il suo sguardo sembra perso nel vuoto, oltre me. «Le è sempre piaciuto venire tra queste montagne.»
Depressa?, penso io. I vecchi sono depressi. O gli psicopatici.
«In che stanza dorme?» chiedo.
«Quella.» Albert mi indica una porta al terzo piano, sul lato che si affaccia sul lago, una singola stretta ma confortevole che di rado viene occupata: questo è un albergo per famiglie, o forse nessuno desidera venire qui da solo.
Mi domando come Albert possa pensare che la depressione di sua figlia sia in grado di dissolversi con più rapidità nella solitudine di questi picchi, piuttosto che facendo le vasche in Duomo con le amiche di Milano, ma preferisco tenere per me questa osservazione.
«Ecco fatto» dico, depositando il bagaglio davanti alla stanza di Leonor e bussando alla porta.
Lei apre quasi subito.
Il viso, da così vicino, è ancora più pallido e affaticato di quanto sembrasse prima. Ha gli occhi cerchiati, le palpebre gonfie di chi non dorme da giorni, forse da settimane.
«Grazie» dice.
«Sono contento di ved…»
Non mi dà il tempo di finire la frase: afferra la valigia e la trascina dentro, richiudendo la porta con un sorriso appena accennato, di circostanza; resto in piedi nel corridoio come uno scemo, con la mia migliore espressione di benvenuto ancora stampata in faccia.
Forse non mi ha riconosciuto. È da qualche anno che non ci vediamo, è normale. Oppure non vuole avere nulla a che fare con me.
Chissà cosa le hanno raccontato.
«È stanca» si scusa ancora suo padre, avvicinandosi alle mie spalle. «Il viaggio è stato faticoso. Ha solo bisogno di riposare.»
Già, mi dico mentre ritorno di sotto. Oppure è semplicemente diventata una stronza di città.
Leonor
«Allora, vogliamo muoverci a scaricare le casse di minerale?»
L’urlo mi sveglia di soprassalto, ma non mi spavento. Fragore di vetri che vibrano e urtano tra loro: significa che è mercoledì, il giorno delle consegne. A sbraitare è nonno Joseph. Prende di petto ogni situazione, controlla tutto, striglia il personale quando qualcosa non va o se un cliente si lamenta della pulizia della camera o del servizio. Tiene i conti, tratta con i fornitori. Insomma, ha ancora una tempra formidabile, a dispetto dei suoi settantadue anni. Da quando è morta la nonna si è dedicato anima e corpo a quest’attività, e si occupa di persona anche della manutenzione, aiutato a volte da mio padre, muratore, imbianchino o idraulico improvvisato a seconda delle necessità.
Prima delle ultime vacanze di Pasqua, alla vigilia della stagione turistica, abbiamo trascorso due o tre week-end qui all’Overlake. Papà ha aiutato nonno a ridipingere il salone principale e l’ingresso dell’hotel, mentre io e mamma, visto che il tempo era buono, ne abbiamo approfittato per fare lunghe passeggiate fino al paese o intorno alle rive del lago.
È strano come quei giorni mi sembrino a volte più chiari e nitidi di quelli che sto vivendo ora. La voce di mamma, la luce del cielo, i fiori che sbucavano incerti fra l’erba: è tutto così reale, così vero. Ora, invece, tutto ciò che vivo mi sembra avvolto in un liquido denso fatto di suoni attutiti e pensieri immobili.
«Sveglia, pigrona» mi chiamava mamma, comparendo nella stanza appena i raggi del sole sfioravano il davanzale della mia finestra. Nel dirlo, sollevava il piumino in cui mi avvolgevo la notte e spalancava gli scuri delle finestre. Mi portava il caffè a letto insieme a qualche fetta di pane di segale ancora tiepido e a un po’ di marmellata di mirtilli preparata da Martha, la cuoca.
«Lo sai che i mirtilli fanno venire gli occhi belli?»
Era una sua teoria, del tutto priva di fondamenti scientifici, ma i suoi occhi erano splendidi, e io ho preso molto da lei. Non c’era motivo di dubitare che avesse ragione.
Il tempo di sciacquarmi il viso, sistemarmi i capelli ed ero già sul sentiero accanto a lei, entrambe con un bastone in mano per aiutarci nelle salite, le scarpe da trekking e un cappellino con la visiera per ripararci dal sole primaverile. Il lago, in quei giorni, era azzurro come il cielo.
«È un posto meraviglioso» diceva mamma sorridendo. «Non ti piacerebbe vivere qui? Io ci verrei subito.»
Evitavo di risponderle, e non era solo colpa del fiato corto. Sarei morta al pensiero di ritrovarmi confinata in un paese di nemmeno cinquecento anime, dove l’italiano è la seconda lingua dopo il tedesco, lontana dai miei amici, da Diana, da Nicolas, dalla nostra discoteca del sabato sera, dai cinema multisala, dalla Galleria e da tutti i negozi del centro. E, non ultimo, dal Wi-Fi. Il tempo in cui mi bastava rincorrere le lucciole con Abel è finito da un pezzo.
Purtroppo, però, la vita fa a modo suo.
Per i prossimi tre mesi sarò costretta a rimanere qui a Malfenn. Un avamposto tirolese, tutto fiori, siepi curate e casette di legno ornate dai gerani, dimenticato da Dio e dalla rete telefonica. Per scambiarmi messaggi con Diana devo scendere al paese o cercare i pochi punti dove c’è segnale. Sono tagliata fuori da tutto, ma non me la sento di lamentarmi con papà: gli leggo negli occhi una tristezza che è uguale alla mia, lo smarrimento infinito di chi non sa che forma dare al dolore che prova.
Ci sono persone che aspettano tutta la vita. Spesso non sanno nemmeno loro cosa aspettano. Io sono mesi che attendo il ritorno di mamma. Essere di nuovo qui, in questo luogo che me l’ha portata via, è una ferita lacerante che non sanguina e non macchia, ma è come se dentro tutto si fosse fermato a quel maledetto pomeriggio e io vivessi sospesa, incapace di agire autonomamente.
Fosse stato un anno come un altro, mi sarei avvicinata ad Abel, l’avrei salutato, gli avrei parlato. Magari cogliendolo impreparato alle spalle, puntandogli un dito contro la schiena e imitando la voce del pistolero negli spaghetti western che da bambini guardavamo insieme nei giorni di pioggia: «Ehi, gringo, questo hotel è troppo piccolo per tutti e due!».
Non lo vedevo da anni, qui all’albergo. Anni, davvero, in cui è cresciuto e io sono cresciuta, ma i suoi occhi sono sempre gli stessi, occhi che non ha nessun altro in tutta la vallata, forse in tutto il mondo. Occhi del colore del bosco in autunno, occhi d’oro. Chissà se li ha presi da suo padre: Martha non gli somiglia affatto.
Però non ce la faccio, preferisco ignorarlo. Penserà che me la tiro, ma in questo momento non ho voglia di giocare o anche solo di parlare con qualcuno che non faccia parte della mia famiglia e non sappia cosa sto passando. Ho la testa piena di domande senza risposta, anche se quella costante e che non mi dà mai tregua è sempre la stessa.
Abel
Mia madre si aggira per l’albergo indossando un grembiule, ha le mani segnate dalla varechina e lo sguardo vigile. È la cuoca dell’Overlake da sempre. Ha cinquant’anni, non è mai stata magra ed è la custode dei segreti culinari di Malfenn… La pelle del viso è liscia, quasi senza rughe, e il suo sguardo pieno di calore. Sa già dei due nuovi arrivati e non vede l’ora d’incontrarli. Io non le bado; sono alle prese con un krapfen gigante in attesa d’attaccare a lavorare. Ma ignorarla, con quella sua voce tonante, risulta impossibile.
«Quanto sei magra, tesoro mio!» esclama appena Leonor mette piede nella sala colazioni. Attraverso la porta aperta della cucina le vedo, la ragazza bruna con i capelli arruffati e la grande signora altoatesina con le guance rubizze. Mia madre bacia Leonor, due volte, e la fa ruotare su se stessa come se fosse una bambola di pezza. Lei si lascia trascinare, non la guarda mai negli occhi e fissa un punto oltre la finestra. Non lo avrebbe mai permesso, un tempo.
La vecchia Leonor che ricordo io era tempestosa e viva, e costantemente affamata.
«Adesso ci penso io, a te. Una bella fetta di strudel caldo, che ne dici? E anche pane, burro e marmellata, e poi una bella tazza di latte fresco, quello delle nostre vacche, mica del supermercato. Siediti, siediti.»
«Grazie Martha, ma…»
Mia madre neanche l’ascolta. «Magra come un’acciuga, mein Gott, sei magra come un’acciuga!»
Leonor ha un attimo d’incertezza. Magra è magra, non c’è che dire. Non si può non notarlo. L’ultima volta che l’avevo vista era diversa. Più bassa, il viso rotondo, pieno di efelidi e segnato da un sorriso contagioso. Quanto tempo è passato? Cinque anni, forse? All’epoca sembrava un’altra persona, più insicura ma allo stesso tempo solare e serena. Rideva spesso, anche senza un apparente motivo. E io con lei.
Sembra passato un secolo da quell’estate. Un pomeriggio in cui si era messo a piovere, ci eravamo riparati nel deposito dell’Overlake, dietro al bar, dove consegnavano le bottiglie, per sfuggire all’acquazzone che ci aveva investiti. Il vento fischiava e come spinti da un istinto naturale ci eravamo stretti l’uno all’altra per riscaldarci. Le nostre labbra si erano avvicinate. Un gesto che avevo visto fare a un paio di ragazz...