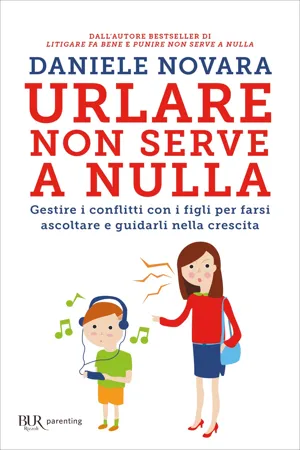![]()
2
SECONDA PARTE
COME GESTIRE I CONFLITTI CON I FIGLI
![]()
4
DISTINGUERE
TRA CONFLITTO E VIOLENZA:
la competenza conflittuale
impedisce la violenza
Io vado d’accordo con tutti, non ho idee politiche io. Credo che le idee politiche dividano la gente, e invece questo è un brutto mondo dove bisogna stare uniti senza litigare. A me fanno paura quei colleghi in ufficio che cominciano i discorsi con: “Sapete qual è la verità?” e puntano il dito contro, e alzano la voce, sudano e dicono che bisognerebbe “uno fare, due fare sul serio, tre eliminare” e giù nome e cognomi. E subito salta su un altro che non è d’accordo e anche lui è convinto ugualmente e punta il dito con altrettanta decisione, e dalla voce vibrante capisci che anche per lui è sinceramente necessario fare, fare sul serio, eliminare… e solo i nomi e cognomi sono diversi.
E allora mi verrebbe da saltar su e dire: ma insomma sì, facciamo, facciamo sul serio, ed eliminiamo ma senza litigare, perché alla fine ogni idea è uguale all’altra. Il mondo fa schifo ma abbiamo solo questo, chi può arraffa, chi è forte se ne approfitta, chi ha qualcosa se la tiene. Poi arriva uno che cambia tutto dicendo “basta!”, e con la violenza massacra tutti e torna tutto come prima. E si urla e si suda, nascono selve di dita puntate.
E adesso basta, perché ho paura che quello che sto dicendo sia già un’idea su cui qualcuno potrebbe non essere d’accordo, perché – vedete – io ho scelto come strada quella di andare d’accordo con tutti, tanto ognuno ha ragione. Se tutti facessero come me non ci sarebbero problemi.
S. BENNI, L’uomo che andava d’accordo con tutti
IL CONFLITTO E LA VIOLENZA NON SONO LA STESSA COSA
Non mi stancherò mai di ribadire l’importanza, per un corretto e innovativo approccio alla gestione dei conflitti, di riconoscere la distinzione tra conflitto e violenza.
Purtroppo in questi anni ho dovuto costatare che la sovrapposizione tra questi due concetti persiste. Una certa cultura mediatica, da un lato, e una certa confusione semantica diffusa nel parlato comune ci portano a ritenere la violenza semplicemente un conflitto più intenso, e il conflitto semplicemente una violenza più leggera. Anzi direi di più: nei comunicati giornalistici è estremamente diffuso l’uso promiscuo dei due termini.
Un esempio tra i tanti: «La guerra in Siria si fa sempre più intensa. Oggi sono stati bombardati alcuni quartieri di Damasco provocando altri morti, decine se non centinaia. Pare che siano stati colpiti e uccisi anche diversi bambini. Il conflitto non si attenua, anzi, più passano i mesi e più la sua crudeltà si fa efferata e priva di inibizioni».
In questa cronaca giornalistica, presa a caso tra le tante, su uno dei fronti più sanguinosi dei nostri giorni, l’autore non sembra farsi particolari scrupoli nell’utilizzare le parole “guerra” e “conflitto” come sinonimi. La domanda sorge spontanea: chi scrive questi articoli si accorge che il termine “conflitto” è lo stesso usato durante le riunioni condominiali per definire la divergenza di opinioni tra due condomini in funzione di un progetto che per qualcuno costa troppo e per un altro troppo poco? O lo stesso che si utilizza quando due colleghi sul lavoro si trovano in contrasto su un piano di sviluppo aziendale, di marketing, o su una decisione da assumere in riferimento al personale? E anche lo stesso che si utilizza nelle relazioni critiche con i propri figli? Tra le dinamiche scatenate da una difficoltà relazionale e quello che sta accadendo in Siria – bombe, morti, violenza nelle strade – di differenza ne passa eccome, ed è indispensabile tenerne conto. La naturalezza con cui si sovrappongono e confondono i due concetti mi sembra davvero macabra.
La stessa etimologia è radicalmente diversa. Sono due termini che derivano entrambi dal latino: violenza da violentia, con la radice vis (forza, vigore, prepotenza) e la terminazione -ulentus (eccesso); conflitto da cum (con) e fligere (urtare, sbattere). Fin dall’origine c’è una profonda distinzione semantica: se il conflitto implica un “con”, un’alterità contro cui ci si scontra, una relazione, il termine “violenza” invece non comporta necessariamente una dimensione relazionale: la violenza può esercitarsi anche contro oggetti, o su se stessi, o nei confronti di sconosciuti. Si tratta di parole che indicano due esperienze umane lontane, e il problema del sovrapporle sta nell’ombra che questa confusione getta sui rapporti interpersonali.
Confondere il conflitto e il litigio
con le tragedie delle guerre e della violenza
crea uno stato d’animo di paura e di allarme
quando ci si trova in situazioni di contrarietà con gli altri.
Senza questa separazione tra le due parole tutto risulta poco chiaro.
E così capita che il vicino di casa che mi manda a quel paese con termini e critiche pesanti mi faccia sentire violentato, ferito, in guerra, pur non essendoci stato di fatto alcun atto violento nel nostro diverbio. Il confine tra la divergenza, la contrarietà e la violenza scompare. Questo fa sì che la permalosità dilaghi, la suscettibilità abbia il sopravvento, i comportamenti finiscano per rendersi irriconoscibili e si fatichi a distinguere una sberla da un insulto. In questo contesto, diventa difficilissimo insegnare ai figli che cosa differenzi la violenza e il conflitto.
Il conflitto è una questione di manutenzione relazionale.
È nei conflitti che possiamo scoprire e riconoscere le nostre capacità di vivere e accettare la differenza altrui, che possiamo accettare l’opposizione per cogliere altri punti di vista, per immaginare nuovi esiti e individuare accordi più efficaci.
La violenza, come la guerra, è esattamente il contrario:
un movimento che rifiuta l’altro, eliminatorio del contrasto.
La violenza è un’azione che conduce alla soppressione, più o meno concreta, di colui che pone un ostacolo, che è titolare del conflitto. È un comportamento semplificatorio, banale, assolutistico nella sua brutalità. Proprio le persone che non amano i conflitti, che non amano le perturbazioni, che prediligono la calma, la rassegnazione relazionale, la docilità, sono quelle che possono più facilmente diventare violente.
Quanti genitori ho incontrato, in particolare padri, che mi confessano la loro estrema disponibilità verso i figli ma, allo stesso tempo, riconoscono che quando non ce la fanno più potrebbero facilmente passare a gesti non molto tranquilli.
L’idea piuttosto diffusa che la violenza non sia altro che un conflitto degenerato in una sorta di inevitabile escalation non trova alcun riscontro alla prova dei fatti. È vero che a volte i conflitti possono degenerare in violenza, ma non lo è il contrario, cioè che la violenza sia l’inevitabile conclusione di un conflitto particolarmente intenso. In realtà sono ben più numerose le situazioni di violenza senza conflitto esplicito e intenzionale che quelle di violenza che contengono forme di conflittualità diretta.
Una testimonianza terribile della dinamica aconflittuale della violenza fu, all’epoca del delitto di Erba nel 2006, l’intercettazione ambientale rilevata in casa di Rosa Bazzi e Olindo Romano qualche giorno dopo l’efferato delitto in cui sterminarono quattro persone, con una quinta che si salvò per miracolo. Una delle frasi più agghiaccianti di quei giorni fu quella che Rosa Bazzi pronunciò con molta naturalezza, senza pensare che avrebbe potuto contribuire a incriminarla: «Che calma c’è adesso senza di loro». È una frase che ben esprime il movimento paranoico interno della violenza, di chi non tollera la conflittualità, la magmaticità dell’esistenza, la sua complessità, la sua articolazione spesso creativamente disordinata.
Un grande psicanalista, Franco Fornari, ha ben chiarito queste dinamiche rivelando i vantaggi psichici dell’utilizzo della guerra e della violenza come sistemi di risoluzione dei problemi. La violenza a livello relazionale esprime una logica tautologica – «Il problema sarà risolto quando non ci sarà più il problema» – che mira a eliminare la fatica del confronto, il limite posto dall’altro.
Togliere di mezzo il conflitto eliminandone la fonte:
questa è la logica della violenza,
di chi non riesce a sostenere
la problematicità che ogni rapporto porta con sé.
Ho definito tale atteggiamento carenza conflittuale, intendendo con questa espressione l’incapacità di stare nella tensione relazionale, che viene prevalentemente vissuta come una minaccia insopportabile. Tale carenza si contrappone alla ben più auspicabile competenza conflittuale, che indica al contrario la capacità di stare nella tensione relazionale affrontandola come una situazione gestibile.
Nella tabella che segue propongo una distinzione netta tra questi due concetti, che ne riassume le caratteristiche essenziali e mira a distinguerne gli ambiti esperienziali.1
LA DISTINZIONE FRA VIOLENZA E CONFLITTO |
VIOLENZA2 | CONFLITTO |
- Danneggiamento intenzionale dell’altro con presenza di danno irreversibile di tipo sia fisico sia psicologico | - Contrasto, contrarietà, divergenza, opposizione, resistenza critica (senza componenti di dannosità irreversibile) |
- Volontà di risolvere il problema (conflitto) eliminando chi porta il problema stesso | - Intenzione di affrontare il problema (conflitto) senza ledere la persona |
- Eliminazione della relazione come forma di “soluzione” semplificatoria e unilaterale. | - Sviluppo sostenibile della relazione possibile, anche se faticosa e problematica |
È proprio il saper “stare” nei conflitti, quindi nei litigi,
che crea l’antidoto più efficace alla violenza.
Occorre allora, nella gestione dei conflitti con i nostri figli o comunque dei conflitti che li riguardano, sostenere, con modalità educative adeguate, un processo di apprendimento che insegni loro a “stare” nelle divergenze e nelle difficoltà relazionali. Solo così si possono sviluppare le competenze necessarie per evitare di spostare sugli altri quelle che in realtà sono piuttosto le nostre pulsioni interne. Sviluppare tale apprendimento è il modo più efficace per evitare di subire violenza ed, eventualmente, di commetterla.
I BAMBINI PICCHIATI
La violenza non nasce mai dal nulla.
Molto spesso dietro a episodi violenti, o anche a fasi storiche particolarmente efferate, si scoprono modalità educative a loro volta coercitive e violente. Penso al libro di Rudolf Höss, Comandante ad Auschwitz,3 o al film di Haneke, Il nastro bianco,4 che hanno contribuito a mettere in luce la specifica impronta dell’educazione prussiana che ha preceduto l’epoca nazista.
Dietro alle vicende umane di tanti femminicidi si nascondono educazioni repressive, soffocanti e morbose, che poi si proiettano sugli altri producendo comportamenti paranoici. Chi non ha avuto modo di sperimentare da bambino il riconoscimento e il rispetto della propria differenza individuale, chi ha vissuto esperienze di fusione simbiotica dove il contrasto non era possibile e non era accettato, tende a proiettare le emozioni e le pulsioni contrastanti che prova dentro di sé all’esterno, verso un nemico. Chi ha subito la violenza da piccolo ha decisamente molte più probabilità di usare a sua volta violenza nei confronti degli altri.
È impressionante questa dichiarazione di un bambino palermitano, raccolta, insieme a tante altre, dall’équipe di Gigliola Lo Cascio5 nell’ambito di un’ampia ricerca sugli stili educativi: «Io atti di violenza non ne ho avuti mai. Ho passato la vita bene, ho avuto solo bacchettate dalla maestra e schiaffi». È palese l’incapacità del bambino di avvertire l’anomalia di quanto ha dovuto subire, e non gli sarà difficile replicare lo stesso comportamento quando sarà cresciuto.
Da sempre antropologi, psicanalisti, psicologi affermano un dato scientificamente riscontrato.
Coloro che picchiano i bambini sono stati,
per la grandissima maggioranza,
picchiati o trascurati a loro volta quando erano bambini.
È risaputo che chi è stato emozionalmente deprivato da ...