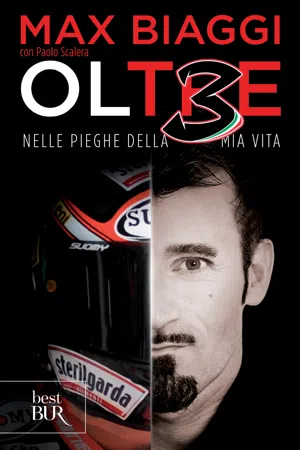![]()
Capitolo 1
Quando mi sveglio è ancora buio. Apro gli occhi di colpo, sentendomi mancare la terra sotto i piedi. A volte mi capita… Spesso accade mentre sto sognando di correre, e finisco in terra. La sensazione non è proprio quella di una caduta dalla moto, manca per esempio il rumore, ma per il resto è tutto molto simile, e questa volta la scivolata è quella di Gara 1 a Magny-Cours.
Con gli occhi spalancati, ma senza vedere niente, ci metto una frazione di secondo a realizzare che sono nel letto di casa, a Montecarlo. A farmelo capire, il respiro di Eleonora al mio fianco. La casa è silenziosa, tendo l’orecchio ma anche dalla stanza dei bambini non proviene alcun rumore; così, con la massima attenzione, scivolo fuori dalle coperte e vado in cucina. In silenzio, mi preparo un caffè. L’orologio sul muro segna le cinque e un quarto, e come sempre la prima cosa che faccio è guardare fuori dalla finestra, verso il mare: è tranquillo. Svegliarmi di soprassalto mi capitava anche da bambino, prima che iniziassi a correre, ma questa volta il sogno è stato di un realismo incredibile. Il manubrio mi si è girato, senza peso, fra le mani, procurandomi quella sensazione di vuoto che mi ha schiacciato contro il materasso, svegliandomi.
Ha smesso da poco di piovere, in Francia, a Magny-Cours, e anche se l’asfalto è ancora bagnato ci siamo schierati con le gomme slick. Parto prudente, ma deciso, con un po’ di nervosismo addosso perché è l’ultima giornata del campionato 2012 e ancora, e per la sesta volta in carriera, mi gioco un titolo mondiale. Quando si spegne il semaforo vedo Tom Sykes scattare bene con Johnny Rea, il mio compagno di squadra Eugene Laverty, Carlos Checa, Marco Melandri, e mi accodo. Istintivamente analizzo la quantità d’acqua sollevata dagli pneumatici e archivio il dato. Poi mi ritrovo davanti alla BMW di Marco nel frastuono familiare dei motori e lentamente sento, come sempre, la tensione del via allentarsi. Al secondo giro supero Eugene in quarta posizione, mentre mi rendo conto che Chaz Davies, con la terza Aprilia in gara, è andato per campi all’uscita della Curva Grande.
Va tutto bene, continua così, mi dico. Non sto tirando, controllo la situazione quando, all’improvviso, alla staccata del tornantino Adelaide, lo sterzo mi si gira. Non posso farci nulla. In quel punto ci sono delle piccole ondulazioni dell’asfalto, ma non ho frenato alla morte. La sensazione di vuoto mi prende alla sprovvista. È sempre così. Un attimo e sono in terra. Non si pensa in quei momenti: sbatto, rotolo, vedo la moto che mi corre vicino, le scintille e poi sono fermo, con un gran vuoto dentro. Mi rialzo subito, consapevole di non essermi fatto nulla, ma la moto si è scartata come una caramella. Impossibile ripartire. Sento lo stomaco stringersi: non così! Il Mondiale, il sesto Mondiale, che stavo inseguendo e avevo quasi fra le mani, mi sta scivolando via come un mantello di seta dalle spalle. Il vuoto si è trasformato in un peso incredibile e mi sento come inchiodato a terra, gli stivali pesanti a ogni passo nella ghiaia della via di fuga.
Max, mi dico, hai fatto una cazzata e ora la paghi.
All’esterno della curva trovo Tom, un amico di Eugene Laverty che poi è diventato anche amico mio. È lì con uno scooter per riportarmi ai box, mi siedo dietro, silenzioso, furente con me stesso.
«Non preoccuparti ora, c’è sempre Gara 2» dice Tom. «Dai, vai, non ci stare a pensare» prosegue. Ma io non ci riesco proprio, a pensare ad altro.
«Ragazzi, mi dispiace» dico non appena arrivo nel mio box. «Ho frenato come al solito. Mi è scappata via.» Lo ripeto ad Aligi Deganello, il mio capomeccanico, poi a Gigi Dall’Igna, che fa una delle sue solite facce imbarazzate. Gigi è il responsabile del reparto corse dell’Aprilia. Ci guardiamo, poi anche lui ripete la frase di Tom.
«Va’ a cambiarti ora, pensiamo a Gara 2.»
Mi sembra strano che tutti pensino alla seconda manche. Per me il titolo è perso, l’ho buttato via al tornantino, ma in qualche modo la squadra ci crede ancora e questo mi solleva un poco. Un poco, eh, non tanto. Mi sento svuotato.
In un certo senso quello che provo ora, nella cucina di casa mia, a Montecarlo, dove vivo da vent’anni, da quando faccio il pilota professionista.
Apro la finestra ed esco sul balcone. Se c’è una cosa bella di vivere a Montecarlo è il clima. E il mare, ovviamente. Non fa freddo, ma rimango fuori per poco. Sono inquieto perché ho chiesto a Fiorella, mia cugina, e un po’ anche mia manager, di prenotare la pista di Vallelunga per oggi, ma non per andare a girare. È che a Valle ho iniziato la mia carriera, e mi è sembrato il posto giusto per annunciare che smetto. Sono convinto di farlo, ma un po’ la cosa mi spaventa: perché negli ultimi vent’anni non ho fatto altro che correre.
«Possiamo cancellare la prenotazione?» le ho chiesto qualche giorno fa.
«Possiamo, ma entro certi limiti di tempo» mi ha risposto Fiorella. Ma ora, improvvisamente, alle cinque e mezzo, torno dentro casa, prendo il telefonino e twitto: «È un’alba molto diversa oggi per me. Niente sarà come prima. Forza comunque!».
È andata. Fra poco ho l’aereo che mi porterà a Roma. Non si torna più indietro, ma è giusto così. Non si può continuare a girare in tondo, nella vita. Io in realtà l’ho fatto perché correre in motocicletta è girare in tondo, cercando di ripetere gli stessi gesti, le stesse traiettorie, curva dopo curva, solo un po’ meglio ogni volta. Decimi, centesimi, millesimi. Conta solo quello. Migliorare ciò che già si fa bene. Si diventa un po’ maniaci, ma in fondo lo sono tutti gli sportivi. Ossessionati da se stessi. Chiudo gli occhi. Sono Max. Li riapro, sono Massimo, come mi chiama papà. Le palpebre come una visiera: quando sono giù non esiste altro che il nastro d’asfalto che scorre, sempre più stretto man mano che aumenta la velocità. Da solo nei test o in gruppo durante la gara, in fondo, non cambia molto. Chiudo gli occhi.
È l’anno del primo titolo iridato di Loris Capirossi in 125. 1990, Vallelunga. Corrono tutti i migliori dell’epoca: Loris, fresco campione del mondo, e poi Fausto Gresini, Doriano Romboni, Maurizio Vitali. Io sono lo sconosciuto Massimiliano Biaggi. Arrivo terzo al traguardo guidando una Honda 125 di Massimo Matteoni. Ma mica una moto pronta per il Mondiale, una «Kit B», da campionato italiano. Mi ricordo tutto perfettamente. Durante le qualifiche passo in carenatura sul traguardo e firmo il miglior tempo, ma dietro di me, uno in scia all’altro, ci sono Gresini e Romboni e mi soffiano la pole. In gara Capirossi tocca Vitali al Tornantino. Un mucchio selvaggio di giovani arrembanti. Già piloti di valore. Finisco non so come terzo. Riapro gli occhi.
Devo andare. Mi infilo nella doccia mentre la mia famiglia dorme ancora: Inés e Leon hanno appena quattro e tre anni, Inés è nata il 22 settembre del 2009, Leon il 16 dicembre del 2010. Li ho visti entrambi venire alla luce. Un’emozione forte. È come tagliare il traguardo. Il loro arrivo mi ha trasformato la vita, ma non ho cambiato quasi nulla nelle mie abitudini. Le cose ora muteranno un po’, o forse no. Non lo so ancora. Fisicamente sono una roccia e potrei andare avanti ancora parecchio. Sono stato anche fortunato: in tanti anni di gare mi sono fatto davvero male pochissime volte. Sul mio corpo gli unici segni visibili sono il mignolo sinistro bloccato in quella che il dottor Claudio Costa chiamerebbe angolazione fisiologica alle corse, cioè a uncino, ricordo di una brutta caduta in Francia, e quello destro consumato dalla stessa strusciata sull’asfalto.
Il dottor Costa è il nostro angelo custode. È un omone grosso, che ti guarda sempre come si guarda un figlio. A sedici anni Claudio si trovò a bordo pista a Imola, il circuito creato da suo padre Checco assieme a Enzo Ferrari, ad assistere Geoff Duke caduto alla curva delle Acque Minerali. In quel momento decise che sarebbe diventato medico ortopedico e traumatologo. E lo ha fatto, creando una Clinica Mobile, dapprima un piccolo camper, oggi un bilico con tanto di sala gessi e sala operatoria, presente a tutte le gare del Mondiale.
Ogni volta che mi guardo le mani mi consolo pensando che un mignolo così lo ha anche Phil Read, mentre a Barry Sheene furono addirittura costretti a tagliarlo. Non è un granché come lesione, ma ugualmente non mi piace. Poi ci sono due lunghe cicatrici su entrambi i lati del piede sinistro, ricordo di una bruttissima frattura all’astragalo che mi sono procurato nell’inverno del 2004 allenandomi con una moto da Supermotard al circuito del Sagittario, a Latina, e che ha richiesto una complessa operazione effettuata in Belgio da due équipe chirurgiche contemporaneamente. Fosse andata male mi sarei dovuto ritirare molto prima, perché il piede è quello del cambio.
Il resto sono piccole cicatrici. Un buco nel braccio dove mi si infilò la leva del freno in una caduta a Monza, e altri segni più piccoli perché quando si cade e si scivola, anche se si è protetti dalla tuta, il calore generato dalla frizione sull’asfalto brucia.
Praticamente non ho nulla. Atleticamente sono in forma. Posso correre un’ora a quattro minuti al chilometro senza stancarmi eccessivamente. Correre a piedi mi piace moltissimo, mi scarica, ma da un po’ di tempo ho notato che fatico più del solito a recuperare dopo una gara o un allenamento. Ho anche qualche dolorino ogni tanto. Per essere un pilota sono vecchio. Anzi sono il più vecchio pilota in attività nella SBK. O dovrei dire ero?
Chiudo gli occhi.
Sono di nuovo a Magny-Cours, nel motorhome con Eleonora. Mi tolgo gli stivali, il paraschiena, la tuta. Come sempre è il mio fisioterapista personale a prendersene cura. Marino Laghi è con me praticamente da sempre, dal 1994, l’anno del primo titolo in 250 con l’Aprilia, ed è come un secondo padre. Con lui non ho segreti, ci capiamo con lo sguardo. Conosce il mio corpo meglio di quanto lo conosca io stesso: quando, per un periodo a me sembrato lunghissimo, ho dovuto fare a meno di lui mentre si stava curando un cancro alla gola, per la prima volta da che faccio questo lavoro mi sono sentito solo. Ora Marino grazie a Dio sta bene. Solo la voce gli si è arrochita un po’, ma l’aveva roca anche prima, dopotutto.
«Max, io vado a pranzo in hospitality» mi dice Ele.
«Vai pure, io rimango qui» le rispondo. Poco dopo rientra Marino e mi porta ciò che mangio di solito fra una manche e l’altra: un piatto di spaghetti in bianco con il parmigiano. Poi rimango solo, a rimuginare su quanto è successo. Squilla il telefono, ma è davanti, sul cruscotto del motorhome, e quando lo prendo non squilla già più. Chiamata persa, sul display c’è il nome: Jorge Lorenzo.
Jorge l’ho conosciuto nel 2002, a Jerez. Allora lui aveva quindici anni ed era alla sua prima gara mondiale. Mi si presentò davanti al motorhome accompagnato da un giornalista. Voleva conoscermi perché, disse, era un mio tifoso. Aveva un mio poster fra le mani e glielo firmai. Lo guardai dapprima distrattamente e poi una seconda volta: un ragazzino paffutello che si affacciava al Mondiale con l’ambizione che abbiamo tutti, vincere. Sembrava timido e un po’ chiuso. Mi disse che, da quando era ancora più giovane e aveva messo le ruote in pista, non si era mai perso una mia gara, e una volta, in occasione di una mia sconfitta, aveva pianto.
Da allora Lorenzo ha vinto due titoli iridati nella 250 e poi, cosa che a me non è mai riuscita, ha vinto anche in MotoGP, battendo Valentino Rossi, suo compagno di squadra. Siamo diventati amici. Inizialmente sono state semplici telefonate mentre lui era impegnato nel Motomondiale e io in Superbike, poi abbiamo iniziato a vederci ogni tanto e ora Jorge, che a sua volta è in lotta per vincere il secondo titolo nella classe regina, è venuto a tifare per me a Magny-Cours. Decido di non richiamarlo. Sono troppo giù e non posso fare a meno di pensare all’errore che ho commesso e a come nelle corse le situazioni possono ribaltarsi rapidamente. Se è per questo anche nella vita. Il telefono squilla nuovamente, questa volta è Eleonora. Le rispondo.
«C’è Jorge che ti vuole parlare, Max.»
«Digli che non posso, Ele.»
«Mi dice che è importante, che vuole vederti.»
Ci penso un po’. Mi immagino Jorge in piedi al suo fianco che aspetta. «Va bene, ok, digli di venire.»
Pochi minuti dopo è lì, davanti a me. Mi sorride.
«Come va, Campeón?»
«Come vuoi che vada? Non so cosa sia successo… L’asfalto era irregolare, ma non ho pinzato più del solito» – faccio un gesto, leggero, con indice e medio della mano destra a stringere una leva immaginaria –, «e sono finito giù.» Lo dico come una constatazione, che è anche una resa. Mi sento battuto.
«Tutto questo non ha importanza, Max. Tu sei il campione» dice Lorenzo sorprendendomi. Poi aggiunge: «Dimentica tutto, c’è ancora una gara da fare. Vai dentro, vinci il Mondiale e poi questa sera andiamo insieme a festeggiarlo».
Non so se Jorge lo ha notato, ma l’ho guardato con gli occhi sbarrati e la bocca aperta e ho sentito dentro di me che, sì, potevo farlo. Potevo partire come nulla fosse successo e giocarmi al meglio le mie possibilità. È stato come il suono del gong che rimanda il pugile sul ring a battersi. Grazie Jorge, ne avevo bisogno.
Sull’aereo che mi porta a Roma, quarantacinque minuti di volo, mi appisolo subito.
Sono nuovamente sulla linea di partenza, questa volta è Gara 2. Al mattino sembrava quasi un goal a porta vuota: avevo 30,5 punti di vantaggio su Sykes con 50 punti a disposizione. Ora ne ho solo 14,5. Dunque se Tom vince nuovamente devo arrivare almeno quinto. Sembrerebbe facile ma non lo è, perché in Superbike tutti difendono la posizione fino all’ultimo metro. A volte ci tocchiamo con le carene, se non peggio. Ti devi guadagnare ogni posizione e poi mantenerla, perché come molli un attimo chi ti sta dietro prova a infilarti in staccata, anche se sa che farà un giro peggiore. È un modo di correre lontanissimo da quello della MotoGP, dove ogni sorpasso è chirurgico, ma le moto sono molto diverse, al di là dell’aspetto. Le Superbike sono più pesanti, si muovono di più. Risentono del fatto di essere concepite per andare su strada. E poi ci sono le gomme. Le Pirelli perdono progressivamente di efficienza e quando sei a fine gara devi remare. La moto non tiene più la traiettoria, così una delle cose più importanti è imparare a rispettarle, perché se tiri troppo all’inizio le strappi e poi l’aderenza se ne va a farsi benedire. Questo è uno dei miei punti di forza, da quando correvo in 250. So usare le gomme e le rovino poco perché il mio stile di guida è rotondo, accelero con delicatezza; Tom Sykes invece ha una guida irruente, a strappi. È molto forte, ma spesso ha pagato nella seconda parte della gara perché non aveva più gomma. Mentalmente mi auguro che sia una di queste giornate, ma quando si spegne il semaforo vedo la sua verde Kawasaki scattare al comando. E te pareva! Io invece, sempre dalla terza fila, rischio il minimo e sono addirittura decimo. Questa volta siamo tutti con le slick, ma la pista non è completamente asciutta. La traiettoria è pulita, ma basta andare fuori di dieci centimetri e la caduta è quasi assicurata. Una striscia scura su uno specchio. Mi accorgo che sto ansimando.
Mentre sto lì sulle uova, Laverty prova a passare Sykes, però Tom lo ripassa subito. Eugene ci riprova alla Châteaux d’Eau, ma con il medesimo risultato. A quel punto finiamo il primo giro. Oltre a Tom ed Eugene, ho davanti Guintoli, Haslam, Rea, Melandri, Baz, Giugliano e Checa. Se rimango così il Mondiale è perso, ma la gara è lunga. Ora il respiro è regolare e non penso ad altro che a guidare, con la maggiore precisione e dolcezza possibili. Un errore, anche un semplice fuori pista, e addio sesto titolo.
Intanto davanti si è scatenata la solita bagarre, ma io non la vedo, mi concentro sulla mia posizione e sulle segnalazioni dai box.
Dopo sei giri Melandri cade, deve esser finito fuori traiettoria, sull’umido. Mi irrigidisco di colpo, poi mi sciolgo, me lo impongo, devo essere ancora più fluido nei movimenti. Poco dopo va in terra anche Baz, e Haslam commette un errore cedendomi la sesta posizione. Ma a questo punto sbaglio anch’io: alla curva del Lycée vado largo entrando nella via di fuga. Sento le pulsazioni accelerare ma non perdo troppo tempo, solo una posizione, sono settimo. Davanti a me, a qualche centinaio di metri, vedo le Ducati di Giugliano e Checa, ma devo anche stare attento perché ho Leon alle spalle. Abbiamo combattuto un anno intero nel 2010, lo conosco bene: se c’è un punto dove pensa di poter passare, lo farà.
Ma io ho le Ducati nel mirino. Quinto posto. Quinto posto. Ce l’ho nella mente, in un angolino. So che mi basta un quinto posto, se Sykes vince. Prima però devo raggiungere le Ducati. Che farei se fossi al loro posto, sapendo che l’avversario che vuole superarmi è in lotta per il Mondiale mentre per me una posizione in più o in meno non significherebbe nulla? Questo pensiero mi distrae. Lo cancello. Sto guadagnando terreno. Transito davanti ai box e il cartello indica −11 giri. Siamo a metà gara, ma ormai ho Giugliano davanti. Lo supero, ma non basta, il sesto posto non basta, devo raggiungere e superare anche Checa.
Quando lo prendo vedo che Carlos non ne ha più, è in difficoltà. Dal profilo consumato della sua gomma posteriore capisco che sta cercando di accelerare anche lui il più dolcemente possibile; sa farlo, lo so perché abbiamo corso per anni insieme in Yamaha ai tempi della 500, dal 1999 al 2002. Ma io sono in condizioni migliori, alla staccata della Adelaide lo affianco e lo passo. Mancano nove giri e sono quinto. Da qualche parte della mia testa rispunta fuori il numerino magico, ma ora, chissà perché, non sono più così convinto che il quinto posto basti. Avrò contato bene? Ripasso davanti al mio box, c’è un OK sull...