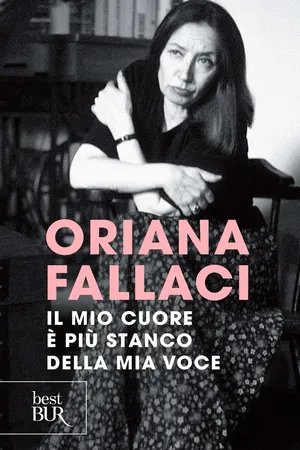Per incominciare devo chiedervi di perdonare il mio inglese. Come vi accorgerete via via, è tutt’altro che shakespeariano. I miei colleghi di «Look» lo chiamavano, con un sorriso, “the Fallaci English”. E so bene che parlare un “inglese Fallaci” di fronte a insegnanti e studenti di un college americano sia quantomeno da irresponsabili. Allo stesso tempo, però, non ho altro per comunicare con voi. Dunque, per favore, cercate di comprendermi quando la mia pronuncia sarà insopportabile, la scelta delle mie parole sarà inesatta, la costruzione della frase sarà stravagante. Vi ringrazio.
Devo poi chiarire subito che non sono qui per insegnarvi qualcosa; e ancor meno per dirvi tutto quel che c’è da dire sull’argomento di cui ho accettato di parlare. Mi ci vorrebbe un libro per farlo. Sono venuta qui solo per parlarvi del giornalismo come è, o è stato, o dovrebbe essere in quella parte di mondo cui appartengo: l’Europa e l’Italia. E poi il giornalismo, come lo vedo io. Come lo faccio io. Cioè il giornalismo in cui credo, il giornalismo per cui soffro, il giornalismo per cui mi caccio nei guai, ovunque io vada, da sempre, da quando ho scelto questo lavoro, e non ero che una bambina. (Avevo sedici anni). Così, quando non sarete d’accordo con le mie opinioni, (e temo avverrà perché sono piuttosto scomoda come forse sapete), dovrete pensare che – per queste opinioni – pago sempre un prezzo elevato. Fatto di angoscia, rabbia, solitudine e perfino minacce, insulti, odio. Questa è la dichiarazione che ho ricevuto l’altro giorno, prima di partire per New York, dai fascisti di Imperia:
Ti abbiamo condannato a morte. Seguiremo ogni tuo movimento e sceglieremo il momento giusto. Siamo in tutta Italia, possiamo venire a prenderti ovunque e in qualunque momento. Spera di morire subito perché se dovessi sopravvivere per qualche istante, sarebbe terribile per te. Firmato, lo Squadrone Fascista della Morte.
Cose di questo genere non sono un’eccezione per me. Ed è solo l’ultimo caso, dovuto a un dibattito televisivo sulla libertà di aborto cui ho partecipato tre settimane fa. Ero stata invitata, insieme ad alcuni politici, perché ho scritto un libro sull’argomento, Lettera a un bambino mai nato, e dato che il dibattito era in diretta, e non registrato, ho detto tutto quello che penso su chi governa il mio Paese da trent’anni. Pochi giorni dopo ci fu un’interrogazione in Parlamento. Un’interrogazione al presidente del Consiglio, al ministro dell’Interno, al ministro di Grazia e Giustizia e ad altri due ministri per chiedere che fossi accusata di apologia di reato. (Tra le altre cose, infatti, ho anche detto che le cattive leggi devono essere disubbidite). L’interrogazione era accompagnata da offese pesanti, e io ho reagito denunciandone gli autori: i parlamentari neofascisti. Chiedendo inoltre al presidente della Camera di privarli dell’immunità parlamentare.
Ma l’Italia non è l’unico Paese, ovviamente, in cui ho sperimentato l’odio che i giornalisti suscitano quando si comportano come dovrebbero. Ne sono un esempio le lettere che ricevo dal vostro Paese, gli Stati Uniti, dopo la mia intervista a William Colby, l’ex capo della CIA. Inutile dire che, lungi dallo spaventarmi, queste cose mi rendono orgogliosa. Un giornalista senza nemici, che non dà fastidio, che non vive in mezzo ai guai, (dal guaio minore d’aver il telefono sotto controllo come io ho avuto sempre, al guaio peggiore d’essere “condannato a morte” dai fascisti), molto raramente è un buon giornalista. Un buon giornalista non dovrebbe mai essere una persona accomodante. Ancora meno, una persona innocua. Se tutto fila liscio per lui o per lei, significa che compiace il potere. Il nostro compito non è compiacere il potere. Il nostro compito è informare e risvegliare la consapevolezza politica delle persone. Quella consapevolezza che il potere ha sempre cercato di mettere a dormire. Vedete, per un giornalista, ogni giorno è un caso Watergate.
Un caso Watergate e un esercizio di cultura, di politica. L’atto di denunciare, spiegare, protestare è sempre (secondo me) un atto di cultura e di politica. Il processo di formazione culturale è sempre un processo di formazione politica, e viceversa. L’uno si identifica con l’altro. E dove avviene questo doppio processo, a livello popolare, se non nel giornalismo? Il giornalismo è il palcoscenico naturale, il veicolo più ovvio, per raggiungere le masse ed educarle. Il suo unico concorrente, in questo senso, è il cinema. (Per quanto non devi essere capace di leggere per guardare un film).
Ho detto il cinema, non ho detto la scuola. E questo potrebbe ferirvi, lo so. Il fatto è che, nell’Europa occidentale, dobbiamo ringraziare il giornalismo, e non la scuola, se la cultura non è più un privilegio aristocratico. Dobbiamo ringraziare il giornalismo, e non la scuola, se la politica non è più l’attività privata di una casta bensì una partecipazione di massa.
Le ragioni sono le seguenti. In Europa (e in particolare nel mio Paese) il potere è sempre stato caratterizzato da una mancanza di cultura. Oppure da una cultura statica e polverosa. Di conseguenza non ha mai riformato il proprio sistema educativo. (Come, in qualche misura, avete fatto voi in America). E così i docenti (che appartengono al sistema educativo concepito dal potere) sono rimasti altrettanto statici e polverosi. Oltre che distanti dalla realtà quotidiana. Generazione dopo generazione, hanno perso il ruolo di guida morale che erano soliti possedere; hanno smesso di esercitare il controllo sociale che erano soliti esercitare. Allo stesso tempo, i giovani hanno capito quanto poco apprendevano da loro e quanto questo poco si riferisse al passato. (Oltretutto, un passato interpretato secondo i vecchi concetti e gli interessi egoistici del potere).
E allora cosa hanno fatto per reagire alla loro insoddisfazione? Si sono rivolti ai giornali come a una scuola alternativa, ai giornalisti come a insegnanti alternativi. E in loro hanno trovato una conoscenza del presente, un ponte con la realtà, una palestra di opinioni e discussioni. E cioè i fatti del loro tempo, le idee e le ideologie del loro tempo, il cibo adatto a soddisfare la loro fame.
Nel caso dei cosiddetti lettori adulti, è successo più o meno lo stesso: anche se in modo diverso. Mi riferisco, ovviamente, a chi non è andato a scuola, o non ci è andato abbastanza. E infatti a loro cos’è successo? È successo che, non appena raggiunsero qualche tipo di consapevolezza politica, sentirono fame di istruzione. Capirono, cioè, che meno sapevano e più sarebbero stati sfruttati. E, non potendo tornare sui banchi in classe, e non avendone nemmeno voglia, credo, si sono istintivamente rivolti ai giornali come a una scuola. Una scuola molto accessibile, tra l’altro, e molto pratica. Potevano frequentarla da casa, con pochi centesimi al giorno, senza la noia di dover ascoltare cose lontane dal loro tempo e dai loro problemi.
Non dimenticherò mai la lettera che ricevetti lo scorso dicembre da una casalinga di sessantasette anni, di Prato. Pier Paolo Pasolini, il nostro più coraggioso poeta, scrittore e regista, era appena stato ucciso a Roma. La polizia aveva dato una versione sbrigativa dell’omicidio. Per caso, ero venuta a conoscenza di un’altra versione che gettava molte ombre sul potere che Pasolini aveva così coraggiosamente attaccato negli ultimi mesi della sua vita. Avevo pubblicato quella storia e ne era nata una specie di persecuzione contro di me. (Non entrerò nei dettagli, vi dirò solamente che ricevetti un ordine di comparizione molto ingiusto, con l’alto rischio d’essere arrestata). E arrivò questa lettera, da questa donna che non avevo mai incontrato e che diceva: «Cara Oriana, ti rendi conto di quanto le persone come me debbano a te, a Pasolini, al direttore della tua rivista? Noi, che non siamo andati a scuola non perché eravamo stupidi, ma perché eravamo poveri; noi, che siamo cresciuti a pane e pomodori non perché eravamo tirchi, ma perché eravamo poveri? Non abbiamo le stesse idee politiche, tu e io. Sono una comunista e mi hai fatto arrabbiare quando hai scritto quelle cose da Hanoi, però ti ho perdonato presto. Eppure, anche quando non sono d’accordo con te, ti leggo come leggerei un libro di testo a scuola, che ho frequentato così poco. Voi giornalisti siete i nostri cari insegnanti. Per favore siate anche i loro guardiani, i loro censori, i loro revisori. E non stancatevi mai d’esserlo».
Vi ho citato questa lettera perché mi aiuta a esprimere il concetto che approfondirò questa sera. Cioè, il giornalismo visto come istruzione e lotta; non solo come informazione. Ma prima di arrivare a questa idea che mi ossessiona, devo raccontarvi perché, sedicenne, scelsi questo lavoro. Chiarirà ancora meglio ciò in cui credo.
Vedete, nacqui durante il fascismo di Mussolini, il che significa che sono nata in un’epoca in cui il vero giornalismo non esisteva nel mio Paese, come sotto ogni tirannia. Sopravviveva solo grazie ai giornali clandestini. Ebbi però la fortuna, e il privilegio, di nascere in una famiglia antifascista. Mio padre era uno dei capi del movimento clandestino di Firenze. Un giorno, avevo circa nove o dieci anni, credo, trovai un giornale che diceva cose totalmente diverse da quelle che ero abituata a sentire a scuola. (Infatti, come saprete di certo, sotto una tirannia anche la scuola è serva obbediente di chi comanda). Il giornale diceva, tra l’altro, che Hitler e Mussolini erano due assassini. Così lo mostrai a mio padre e gli chiesi: «Cos’è questo?». E mio padre rispose: «È un giornale che dice la verità». Allora domandai: «È per questo che non lo vendono nelle edicole?». E mio padre rispose: «È per questo». Ne rimasi così scioccata, così scandalizzata, che gridai (me lo hanno raccontato in seguito): «Un giorno scriverò per giornali che dicono la verità e che vengono venduti nelle edicole». (Bè, non so se è quello che in effetti avviene...).
Comunque... Poi la guerra ci raggiunse, nelle nostre case. E io avevo dieci, undici, dodici, tredici anni. Ero molto precoce, perché è la sofferenza che fa correre l’intelligenza, come scoprii con amarezza, mentre è l’eccesso di agi e felicità che la rallenta. E per quanto fossi ancora una bambina, finii per entrare a far parte della Resistenza, proprio come quei giovani vietnamiti che ho visto arrestare o uccidere nel Viet-nam del Sud... Ero nelle file di Giustizia e Libertà, il movimento dei fratelli Rosselli, i due intellettuali liberal-socialisti uccisi in Francia da sicari assoldati da Mussolini. E vidi molte cose in quegli anni. Vidi esecuzioni, arresti e torture: anche mio padre fu arrestato, e torturato. E feci anche qualcosa: andavo a portare armi e messaggi alle brigate militari in montagna, cose del genere....