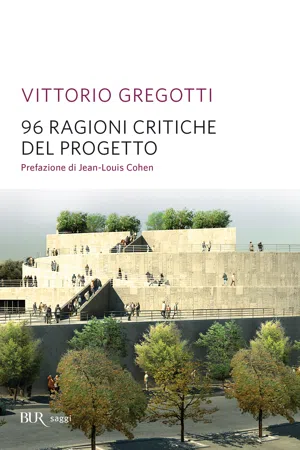![]() 96 RAGIONI CRITICHE
96 RAGIONI CRITICHE
DEL PROGETTO![]()
1
Il disegno degli spazi aperti
Il disegno degli spazi aperti è divenuto progressivamente uno dei grandi temi dell’architettura di questi ultimi anni.
Dobbiamo subito dire che i risultati di queste prime, numerose e spesso intelligenti esperienze ci appaiono quanto mai deludenti. Se pensiamo, anche in modo schematico, alle maestrie tanto articolate con cui gli antichi hanno saputo regolare con minimi mezzi grandissimi spazi, alla straordinaria sofisticazione del trattamento di piccoli angoli urbani, alla capacità di costruzione coerente di interi percorsi territoriali (si pensi ad esempio ai sistemi dei canali francesi a cui è stato dedicato su «Casabella» di recente un ampio servizio), ci rendiamo conto di come, a fronte di un enorme aumento quantitativo di mezzi, di quantità e scala degli interventi, si debba riscontrare un decadimento qualitativo, della coerente intelligenza organizzativa e morfologica degli spazi e delle cose, una perdita di coscienza civile dei loro significati assolutamente evidente.
Ciò che più colpisce poi, in questo campo specifico dell’attività architettonica, è la rinuncia a esercitare un controllo morfologico, cioè di disegno sugli interventi a grande e piccola scala degli spazi aperti, abbandonati da un lato a una spesso discutibile obiettività e tecnica dei grandi manufatti infrastrutturali che sempre più numerosi costituiscono un sistema strutturale rigidissimo, ma sovente del tutto irresponsabile sul piano morfologico, capace di condannare a una rovinosa confusione intere parti di città e di territorio, dall’altro a una revisione decorativa degli aspetti accessori, separata, persino in termini istituzionali (aree istituzionali separate presiedono alla pianificazione del territorio, delle strade, dei porti, delle ferrovie e così via), nei confronti delle responsabilità pubbliche dell’intervento che aggiunge semplicemente alla specificità delle situazioni ambientali l’indifferenza della produzione oggettuale rispetto ai contesti.
Vi è poi stato, negli ultimi cinquant’anni, nel campo del disegno degli spazi aperti, un obiettivo impoverimento delle tecniche di progetto e di intervento: persino un restringimento dei materiali con cui opera il progetto.
Tale impoverimento è da ascriversi costantemente da un lato alla riduzione astratto-quantitativa degli interventi di piano, ma dall’altro a un’obiettiva riduzione dell’impegno progettuale nel campo dell’ingegneria e dell’architettura, da un lato quindi al non pensare che la migliore ingegneria è sempre l’architettura, dall’altro alla distrazione architettonica (ma anche istituzionale) nei confronti di questi temi, distrazione che si è man mano trasformata in incapacità di mestiere e di insegnamento.
Tre sono secondo noi le componenti principali del disegno degli spazi aperti.
La prima è quella che «Casabella» ha definito come «progetto di suolo»: si veda nel numero 520-521 l’articolo di Bernardo Secchi. Non si tratta semplicemente di ciò che appoggia sul suolo, ma ciò che del suolo è corrugazione volontaria, ma anche vera e propria preparazione e organizzazione tecnico-formale della sua superficie apparente: l’uso del suolo, la sua distribuzione funzionale, ma anche le materie, inclinazioni, ricoprimenti, rialzi, bordi, congiungimenti, scavi, riporti: l’architettura della terra, e della sua intenzionalizzazione.
Quando si fa riferimento all’idea di «progetto di suolo» non ci si limita quindi a pensare ai criteri generali del suo uso come supporto di rete o come controllo quantitativo della sua disponibilità a ricevere un’equilibrata quota di servizi, attività, residenze, ma piuttosto al modo in cui l’organizzazione dei fabbisogni, incontrando storia e geografia del territorio, assume una configurazione durevole, significativa, restituisce ad essa un’immagine del senso della sua stessa modificazione.
Il riconoscimento delle specificità e delle differenze storico-geografiche all’interno di un territorio deve essere uno dei due pilastri su cui appoggia il più importante degli obiettivi morfologici del disegno degli spazi aperti: l’articolazione necessaria e legittima (cioè proporzionata rispetto all’uso) delle parti e la loro reciproca relazione, per gerarchie, separazioni, congiunzioni, differenze dei caratteri principali, per sovrapposizione di funzioni e significati; contro cioè ogni disegno della riduzione che è carattere tipico delle periferie urbane del nostro tempo, della loro indifferenza all’identità.
La seconda componente riguarda la natura, qualità, solidità dei segnali e dei manufatti di completamento e ordinamento dello spazio aperto, concepito come una grande architettura interna nella quale sono strategicamente definite le relazioni tra le cose. Senza dover ricorrere a Pierre Patte o all’abate Laugier e alla tradizione dell’«embellissement de la ville» (il cui punto di vista forse sarebbe meglio situato nella terza delle categorie del disegno degli spazi aperti che abbiamo istituito), il completamento e ordinamento civile dello spazio aperto non riguarda solo il dover «assoggettare all’autorità pubblica ciò che guarda sulla strada», come affermava lo stesso Laugier, ma in modo più ristretto e tradizionale i manufatti che completano, definiscono e a volte identificano i luoghi aperti della città e del territorio.
Che questo insieme di manufatti sia stato ridotto alla categoria aggettivale dell’arredo urbano dimostra solo la decadenza nella tradizione del disegno degli spazi aperti, non la caduta della loro importanza di senso, che è andata invece quantitativamente e tipologicamente moltiplicandosi negli ultimi cento anni.
Il suo controllo è certo andato separandosi sulle linee di culture del progetto divergenti; noi pensiamo che esse potranno essere modificate sotto il segno dell’architettura piuttosto che sotto quello delle concretizzazioni mal poste della tecnica o della decorazione come valore in sé.
La terza questione coinvolge, in una diretta partecipazione alla definizione degli spazi aperti, la morfologia stessa dei corpi edilizi. Si tratta cioè di una diversa concezione dell’architettura stessa, di un suo sorgere e costituirsi a partire dalle questioni di contesto, cioè dagli elementi strutturali di relazione con lo spazio concreto o specifico e con il significato e le responsabilità pubbliche che questo assume in senso concretamente storico e che essa deve affrontare. Questo muterà certamente nel tempo, e comincerà a mutarsi proprio a partire dalla nuova architettura che si insedia, ma ciò non rimuove la solidità di questo punto di partenza, che è la solidità dei contenuti storici della sua costruzione attraverso la morfologia del luogo.
La difficoltà che deve venire affrontata è, in questo caso, la penetrazione logica di un linguaggio che si costituisce dall’incastro necessario di questi diversi elementi.
Mentre già oggi è possibile pensare che tale penetrazione fondi con conseguente chiarezza gli elementi insediativi del progetto e misuri logicamente le relazioni generali con il sistema degli spazi aperti, più difficile è il cammino che da questa soglia potrà essere in grado di pervadere, con altrettanta necessità, quelle modulazioni del corpo edilizio che costituiscono un tramite tra la grande regola insediativa e gli aspetti della relazione fisico-percettiva e di significato, più prossima e quindi anche capace di rinviare ogni esperienza specifica al suo orizzonte di senso.
Questo cammino non attiene naturalmente a questa sola componente del progetto degli spazi aperti, ma pervade come problema irrisolto ogni singolo frammento che la compone, e la comprende.
Settembre 1986
![]()
2
Il progetto del presente
Più volte in «Casabella» abbiamo fatto riferimento in vario modo alla nozione di realtà come materiale centrale rispetto alla costituzione del progetto di architettura, materiale interpretabile a partire dalla condizione specifica.
Ciò non nel senso che la «cosa architettonica» rappresenti la realtà, o vi corrisponda; si tratta al contrario sempre di una esperienza di modificazione sia nel senso della costituzione di una nuova realtà sia in quello della trasformazione del modo di essere nel mondo di chi la compie: autore e fruitore. In questo senso e solo in questo senso è esperienza di verità.
Le questioni non devono in alcun modo essere confuse: altro è presentarsi in modo convincente alla realtà sociale, altro è coincidere con essa; aderirvi senza distanze significa non contenere all’interno dell’opera quello scarto invisibile ma concretissimo che stabilisce nei confronti dell’esistente empirico uno stato di necessaria tensione, un aumento della verità essenziale, oggettiva della cosa.
In questo senso si può fare l’ipotesi che il lavoro architettonico non faccia riferimento obbligatoriamente alla necessità di previsione che è tradizionalmente connessa all’idea di progetto, quanto alla costituzione di uno speciale angolo di visione dal quale sia possibile illuminare qualche lato della condizione presente, far chiarezza su una parte delle relazioni e delle possibilità che la costituiscono, qui e ora.
Una condizione prioritaria per dare senso a ciò che possiamo chiamare «progetto del presente» è certamente un ritorno al confronto con la realtà economico-sociale, un uscire dunque dalle gerarchie che hanno posto in primo piano il confronto tutto interno al mondo disciplinare, come motivazione essenziale, primaria alla formazione delle soluzioni di progetto. Tornare a soffrire la realtà, a scontrarsi con la ricchezza dei temi da essa offerti, non tanto cercando di costruire una qualche risposta ai problemi da essa posti per mezzo dell’architettura, quanto per utilizzare le sue offerte come materiale per l’architettura.
È chiaro che quando si parla di confronto con la realtà si tratta di riconoscere al contempo un valore di realtà all’opera stessa che quindi mostra una precisa verità non confrontabile né rispecchiabile in modo puntuale con ciò che chiamiamo realtà. Non si tratta neppure solo di valorizzare lo scopo, né tanto meno il progettato in quanto unica realtà, né il presente in quanto pura riproduzione del mondo esteriore, bensì di mettere in atto un complesso di regole transitorie capaci di astrarre da quel presente specifico l’essenza stessa della sua presenza, il campo di azione, il limite e la struttura del fenomeno specifico.
Lo scopo del progetto diviene quindi l’approfondimento del fenomeno sino alla sua radicale intimità. Solo attraverso tale approfondimento prende senso lo scopo del progetto, la sua dimensione pragmatica, le tecniche con cui viene costruito in quanto tecniche dei materiali e in quanto tecniche della loro produzione e organizzazione.
Si fa riferimento qui, solo parzialmente, al vecchio dibattito tra autonomia ed eteronomia dell’architettura, dibattito che si è prodotto e si fonda su un equivoco puramente operativo, poiché da un lato non vi è chi non comprenda con il solo buon senso l’indispensabilità almeno conformativa dello scontro con l’esperienza esterna alla disciplina per la costruzione del progetto, dall’altro l’impossibilità di costituire significativamente tale esperienza senza obiettivi ideali allineati con le problematiche interne alla disciplina. Peraltro sul piano teoretico pare insostenibile pensare a una pratica artistica se non a partire dalla realtà per operare su di essa una modificazione costitutiva di una verità, che è aumento, anche piccolissimo, della verità del mondo.
Non tutti gli architetti saranno naturalmente d’accordo con queste affermazioni, e con buone motivazioni. L’ansia per la diacronia che pervade tuttora molta parte della cultura architettonica, l’empirismo volgare, neocaratteristico, con cui si risponde spesso all’impero dei fatti e dei comportamenti e che ha il suo riflesso speculare nelle spinte verso la fuoriuscita dal presente per mezzo degli artifici dello stile precostituito, mostrano solo quanto paziente e difficile sia il lavoro per l’accertamento di qualche livello di realtà del presente, quanto complesso sia circoscrivere la nozione stessa di orizzonte del presente in rapporto a quella di progetto.
Tra le soluzioni definitive promesse dal futuro e la nostalgia della compiutezza del passato va rivendicata invece, come tema centrale dell’architettura, la verità del presente.
Non si tratta di trasferire qualcosa dalla realtà di oggi al dominio della forma: essa, quando è autentica opera, con i propri caratteri di definizione assoluta, non è un segno di irrealtà, bensì del fatto che nell’opera la realtà mostra ciò che non possiede come esperienza comune, cioè la verità del presente. Il progetto di architettura (ma forse ogni tipo di progetto) è, come abbiamo prima cercato di affermare, in qualche modo paradigma, prova di consistenza delle nozioni di tempo e di realtà. Il progetto quindi tratta di ipotesi di mutazione, trasformazione, modificazione di una mappa di realtà nel tempo, o meglio nei modi diversi di essere del tempo: tempo del progetto, dei suoi obiettivi e dei suoi effetti; in questo senso esso parrebbe indissolubilmente legato ai suoi aspetti proiettivi.
È possibile però spostare per un momento la nostra attenzione dalla questione del progetto, e quindi del processo, al problema della cosa architettonica. È la cosa architettonica (indipendentemente dal fatto che sia o meno realizzata) il compimento del progetto del presente, persino quando essa mostra ciò che non è in alcun modo nel presente.
La cosa architettonica si costituisce in questo senso come un punto fermo in relazione con la realtà in moto: essa assume per sua natura caratteristiche positivamente conclusive, anche e proprio perché la sua realizzazione pone in essere un nuovo presente, disponibile a sua volta alla rilettura e alla modificazione.
Queste caratteristiche, volta a volta conclusive, di fermezza e consistenza della cosa architettonica, provengono quindi dal pensare il progetto come costituzione del presente.
Questa condizione di preminenza del presente in quanto approfondimento critico dell’esistente empirico sembra peraltro poter pervadere oggi utilmente anche gli obiettivi del progetto. Si vengono a indebolire così gli aspetti proiettivi, di cellula del futuro, in rapporto ai compiti di ordinamento, chiarimento, distinzione delle cose del presente. È lo stato di complessificazione del presente a costituirsi come una dimensione profonda, in cui la cosa architettonica giace come misura solida che descrive e ordina di essa una parte piccola, limitata e precisa.
Descrivere con chiarezza e profondità, sino a giungere al cuore del presente, sembra quindi costituirsi come il compito principale del progetto, compito che pare più arduo, e necessario (in quanto interpretativamente fondato), del porre le basi di un futuro senza prove e senza confronto, il cui unico obiettivo potrebbe essere solo la tensione verso il dominio dell’imprevedibile.
Ma il progetto di architettura non è progetto politico, il suo compito non è di prevedere per dominare, ma di vedere per costituire un frammento del vero.
Per altro verso dobbiamo dire che uno degli interessi meno diffusi tra gli architetti dei nostri anni è proprio la profezia: noi siamo piuttosto oggi architetti della resistenza e della correzione. Ciò non solo in conseguenza all’indebolirsi del pensiero ingenuamente utopico, nel suo progressivo e contraddittorio trasformarsi in ideologia, ma anche in un moto di ripulsa verso ogni pressione empiricamente globalizzante.
Millenaristi e futurologi (ancor più dell’ideologia) hanno rubato il nostro futuro, così come il nostro passato ci è spesso stato rubato dagli adoratori della storia come memoria legittimante. «In effetti invece» come scrive Jacques Le Goff in Storia e memoria «l’interesse del passato sta nel chiarire il presente: il passato si raggiunge a partire dal presente.» O meglio, dal nostro punto di vista, il presente è la superficie del passato: è la chiarezza del progetto del presente che è in grado di illuminare il passato e persino il nostro domani, per mezzo della sospensione dal processo storico attraverso la costituzione della cosa architettonica.
Ottobre 1986
![]()
3
Periferia
Io credo che non si rifletta a sufficienza sul carattere di permanenza e di relativa irreversibilità che le decisioni urbane e territoriali assumono una volta divenute cose fisiche. Si tratta di riflettere quindi sulla grande responsabilità qualitativa che, rafforzata dal forte costo degli investimenti, deve essere condizione di ogni intervento. In modo quasi inversamente proporzionale alla qualità, invece, la resistenza alla trasformazione, non tanto fisica quanto di senso, è sovente molto cresciuta a partire dal dopoguerra. Tale difficoltà alla trasformazione ha indubbiamente costituito anche, contro errori e improvvisazioni, una forma di resistenza dell’identità urbana laddove essa non è stata travolta da espansioni senza preoccupazioni di identità né sociale né morfologica.
Ricostruire o costruire tale identità è evidentemente compito metodologicamente più agevole laddove storia e geografia hanno costituito segni chiari e lungamente persistenti; si tratta essenzialmente, in questi casi, di riparare ai danni fatti, di saper ascoltare l’animo profondo e specifico della città e del territorio, di trasformarlo in regole insediative, di prendere decisioni architettoniche adeguate alla qualità e permanenza del contesto.
Laddove, come nelle grandi periferie, il programma di costruzione si è formato nella pura prospettiva tecnico-economica del profitto o dello standard (anche se le due logiche mostrano sempre le loro profonde differenze) il compito, come si sa, risulta assai più arduo. Certo esso non può essere compiuto solo disegnando giardinetti o collocando panchine, bensì attraverso operazioni di trasformazione di senso assai più radicali.
Bisogna tenere conto che lo stesso miglioramento della mobilità gioca in questi casi un ruolo ambiguo: da un lato facilitando l’accesso alla parte di periferia consid...