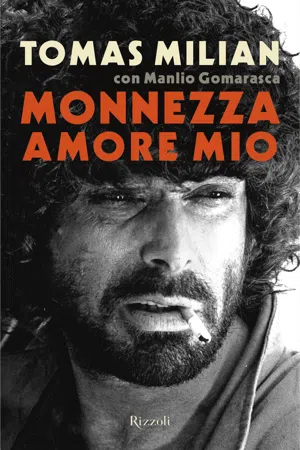![]()
7
Il prezzo di un uomo
Non avevo più soldi. Il biglietto d’aereo per tornare negli Stati Uniti l’avevo perso o era scaduto. Il contratto con Cristaldi era scaduto pure lui e non avevo più la sicurezza dello stipendio fisso; ma la cosa peggiore era che non avevo nessuna voglia di lavorare. Dovevo reagire, trovare una soluzione, ma quale? Non potevo mica assaltare una banca? O forse sì. In Italia era scoppiata la moda dei western, dei cowboy e soprattutto dei banditi. Banditi che assaltavano le banche. Volevo entrare a far parte di quel giro, dove uno non solo poteva assaltare banche e diligenze, ma addirittura veniva pagato per farlo.
C’era però un ostacolo. I produttori di film western mi consideravano un attore impegnato e dicevano: «Ma chi ci crede a Tomas Milian che fa il cowboy?». Come chi? Ci avrei creduto io e tanto bastava. Non ho mai creduto invece in questo incasellare gli attori tra impegnati e non impegnati, perché l’unica differenza è che i primi parlano, mentre gli altri sparano. Parole vs pallottole.
Telefonai alla mia agente e le dissi di iniziare a far circolare la voce che Tomas Milian avrebbe accettato un western per pochissimi soldi. La mia proposta fu così ghiotta che i produttori arrivarono persino da Madrid. Nel 1966, il produttore Pepe Maeso e il regista Eugenio Martín vennero a Roma per propormi un film che si chiamava El precio de un hombre, che sarebbe uscito poi con il titolo The Bounty Killer. Leggendo il copione avevo già deciso: quella era la storia che mi ci voleva.
Di fronte al regista e al produttore, però, invece di elogiarla, mostrai delle riserve riguardo alla cattiveria del mio personaggio. Dissi che era troppo fine a se stessa e che bisognava giustificarla, senza diventare noiosi o pedanti, altrimenti si passava per razzisti.
Stavo rischiando di perdere l’opportunità di avere un buon successo popolare in un momento in cui mi era rimasto soltanto mezzo limone rinsecchito in frigorifero, ma, come si dice, chi non risica non rosica.
Accettarono di cambiare la sceneggiatura e io partii per la Spagna.
Il primo giorno sul set, in Almeria, si girava una scena in cui il mio personaggio doveva fare una corsa a cavallo e fermarsi di botto di fronte alla macchina da presa. Non avevo detto a nessuno che da piccolo ero caduto da cavallo rompendomi il braccio in tre punti e che da allora non ero più montato in sella. Sapevo che a freddo, senza prima sentire gridare «Motore, azione!», non sarei mai riuscito a partire al galoppo. Così di nascosto chiamai il maestro d’armi e mi feci insegnare a tenere le redini e a fermare la bestia di colpo.
Mi diedero un cavallo nero bellissimo, El Cordovez. Quando sentii il regista dare l’azione, diedi un colpo secco con gli speroni sulla panza di El Cordovez, che partì al galoppo. Feci una corsa piena di rabbia, come a dire a mio padre: «Guarda, guarda come ce la faccio!». Quando arrivai alla meta, tirai le redini e il cavallo si impennò. Fu bellissimo.
Un’altra scena che mi diede grande soddisfazione fu quella della mia morte. Mi sparavano e io cadevo a terra a pancia in giù, con la faccia di traverso, e mentre morivo vedevo la sabbia vicino alla mia bocca che si muoveva al ritmo del mio respiro. Senza perdere il controllo della scena pensai: «Attraverso la sabbia, si renderanno conto della mia morte…». Iniziai a diminuire la forza del respiro e ogni volta la sabbia si spostava sempre meno. Sempre meno… sempre meno… Finché chiusi gli occhi e non respirai più. L’operatore di macchina, Enzo Barboni, riprese la scena fino alla fine, senza che nessuno gli avesse detto niente. Al montaggio tagliarono un po’, uccidendo buona parte del pathos che avevo creato, ma in quel momento il mio spirito aveva ballato da solo.
The Bounty Killer fu un grosso successo come anche la colonna sonora scritta da Stelvio Cipriani, un giovane che trovai io stesso durante una visita a una casa discografica. Sentii venire da un pianoforte una melodia che pensai sarebbe stata perfetta per il film, così parlai col pianista e lo raccomandai al produttore e al regista. Fu la prima colonna sonora scritta e suonata da Cipriani, che poi sarebbe divenuto celebre con Anonimo veneziano.
Per la musica avevo orecchio e una grande passione. In quegli anni erano esplosi i Beatles e non potevo lasciarmi sfuggire un’altra grande parte da interpretare: quella del cantante. La parentesi musicale fu uno spasso, ma si chiuse presto. Tutto era nato dall’amore per i Beatles e Bob Dylan, che condividevo con il mio amico Ray Lovelock, una delle persone più fedeli e perbene che abbia mai conosciuto.
Ray era bravissimo con la chitarra e gli chiesi di trovare altri ragazzi bravi come lui per mettere su una band. Tornò con Maurizio, Mario, Romeo, Peppe e Fido, ovvero il Tomas Milian Group. Sul 45 giri che uscì nel 1967, oltre al mio nome, c’era anche la mia faccia.
Per il debutto, organizzai una festa al Piper, il locale più in voga del periodo. Invitai tutta Roma, aristocratici e proletari, tutti insieme in un’ammucchiata musicale. C’erano Joan Baez e il principe Dado Ruspoli, tutti in pista a ballare al fianco di un ragazzo che faceva il pesciarolo a Tor Marancia. Si chiamava Quinto Gambi e mi somigliava moltissimo, così me lo feci presentare.
Quinto andava al Piper tutte le sere per rimorchiare, come diceva lui, e rimorchiava sempre. Si presentava alle ragazze come Tomas Milian e quando queste gli chiedevano: «Scusa, ma non eri cubano?», lui rispondeva: «Ma quale cubano e cubano? Ahò, so de Roma, la storia der Cubano se l’è inventata l’ufficio stampa mio pe’ famme appari’ più esotico! Capito Ni’?».
Da quel giorno diventammo amici per la vita e cominciò a farmi da controfigura.
Mi presentò alla sua famiglia, una famiglia esemplare, di grandi valori, che mi diede tanto calore umano. Andare a trovarli era come visitare un presepe marxista. Volevo essere come Quinto, estroverso, allegro, simpatico, paraculo, buono, puro, dritto e comunista. Ma ero già borghese e corrotto ancora prima di arrivare in Italia e l’unica maniera per essere come lui era di riflesso, attraverso il cinema.
Quinto mi insegnò tante cose, anche la differenza che c’è tra la colazione del popolo e quella degli aristocratici.
Fin dai primi tempi, in Italia, avevo grande difficoltà con i nomi dei pasti. Un giorno ricevetti una telefonata dalla governante-segretaria di una nobildonna amica mia, la quale mi comunicava che la principessa mi voleva a colazione.
Quel giorno, mi presentai alle nove del mattino con una scatola di cornetti caldi, incartati e infiocchettati. Il portiere del palazzo, vedendo il mio passo spedito, si intromise tra me e il cancello.
«Senta, può lasciare qui il pacchetto! Quant’è?»
«No, guardi, non ha capito. Devo andare dalla principessa. Ho un invito.»
«La principessa sta riposando.»
«Riposando? Ma se sono le nove del…»
Il portiere aprì le braccia e, gonfiando il petto, iniziò a spingermi verso l’uscita, come una gallina che protegge i suoi pulcini da un gatto randagio. Me ne andai covando pensieri rivoluzionari. Cercai un bar, presi un cappuccino e mi mangiai i cornetti.
Dopo qualche ora, chiamai la mia amica blasonata. Non capiva perché non fossi da lei.
«Tomas, che fine hai fatto? Ti stiamo aspettando per andare a tavola!»
Quando arrivai, lei con un sorriso da Gioconda mi spiegò che colazione in Italia voleva dire lunch, il pasto dell’una. Che figura… mi ripromisi di non dimenticarlo e non lo dimenticai. Un giorno, però, mi telefonò Quinto che viveva a Tor Marancia, in una borgata di lavoratori e gente, come si dice a Roma, cor còre in mano.
«Pronto, To’? So’ io. Dice mi’ madre si voi veni’ a magna’ a casa nostra domani.»
«Va bene a colazione?» proposi.
«A ma’, dice Tòmasse si pò veni’ a colazzione…» Non sembrava molto convinto. E neanche la mamma lo era.
«A colazzione? Vabbe’, dije da veni’ quanno je pare. Questa è casa sua.»
«A To’, dice mi’ madre…»
«Sì, l’ho sentita, Quinto. Ringraziala da parte mia. A domani.»
Il giorno dopo, me la presi con comodo e andai a comperare una bottiglia di vino. Arrivai da loro a un quarto all’una e mi accorsi subito che qualcosa non andava.
«A fijetto bello, ma ch’è successo?» esordì la madre di Quinto. «Er caffellatte s’è tutto freddato! Mo’ t’o scallo o, si voi, t’o posso fa’ fresco, ma ha’ da aspetta’ ’n pochetto, perché sto pe’ butta’ giù ’a pasta.»
Non capivo più niente.
«A To’, ma invece de mèttete a beve er caffellatte da solo, perché nun se magnamo tutti insieme l’amatriciana che ha fatto mi’ madre e se bevemo ’a boccia che ciai portato?»
Chiarimmo l’equivoco e ci facemmo un sacco di risate. Da allora capii che la colazione per i nobili era il pranzo per il popolo. Una grande lezione di vita. Non si può non amare Quinto come non si può non amare Roma. Io Roma l’ho amata moltissimo, e grazie al Monnezza sono stato ricambiato.
La sera che il Tomas Milian Group debuttò al Piper, cantai Senza luce, una canzone dei Dik Dik, e altri pezzi.
Alla fine del concerto fui avvicinato da una persona che si offrì di farci da manager e cominciò a organizzarci le serate, una dietro l’altra. In quel periodo, giravo il film Faccia a faccia ed era difficilissimo incastrare gli spostamenti tra il set, Roma e il resto d’Italia.
Ricordo ancora un concerto a Sorrento. Partimmo da Roma con la mia Rolls e il furgone con gli strumenti. Il locale era pienissimo. Alla fine della serata, verso le tre di notte, ripartimmo per Roma, dove alle sette del mattino dovevo trovarmi al trucco perché alle nove si girava.
Un’altra volta sarei dovuto andare a Venezia, ma mi era impossibile lasciare il set, così il manager mi fece causa e mandò a pignorarmi tutto. Il Tomas Milian Group finì lì. Un altro ingaggio mancato e il manager vendicativo mi avrebbe lasciato come nella canzone dei Dik Dik: Senza luce.
Quando iniziai a fare i western, lasciai la capanna del Pincio. Stavo così bene lì che non sentivo più lo stimolo di lavorare. Gli amici che passavano di lì mi portavano pure da mangiare come fossi un animale esotico. Così non si poteva più andare avanti: dovevo smettere di essere un foresto nella foresta per tornare nel mondo civilizzato. Pensai di prendere un appartamento con un affitto almeno tre volte più alto di quello della capanna, così sarei stato obbligato a risalire a cavallo. Affittai un attico, molto bello, da dove vedevo Roma a 360 gradi, da San Pietro a Monte Mario, dal Tevere a piazza del Popolo. Dopo un po’ venne a trovarmi l’uomo delle tasse. Le tasse… manco sapevo cosa fossero all’epoca.
«Quante stanze ha? Una?» cominciò.
«Macché una! Adesso qui cambio tutto e ne ricavo almeno altre due! Vede quanto spazio?» Ormai avevo trovato una dimensione da europeo bianco civilizzato, uno stile di vita che avevo sempre desiderato, e non vedevo l’ora di vantarmene.
«Sì, vabbe’, ma per il momento scrivo una…»
Ma come si permetteva questo di buttarmi giù? Manco l’avevo invitato. Di sicuro è un comunista, pensai, di quelli che vogliono che tutti vivano in un monolocale e vadano al lavoro in bicicletta, come i cinesi.
«Mi dica, Milian. Che macchina ha?»
«Per ora una Lancia, molto vecchia, ma sto per comprarmi una fuoriserie.»
«Sì, vabbe’, ma per il momento scrivo che ha una Lancia molto vecchia. Quello che vuole fare dopo non mi interessa.»
Ce l’aveva proprio con me, allora. Pensavo mi detestasse perché mi stavo dando delle arie. E invece no.
«Lo sa che lei mi è proprio simpatico?» disse andando via. «È la prima persona che incontro in Italia che mi vuol dire di avere più di quello che ha.»
Dopo The Bounty Killer mi offrirono un altro western, La resa dei conti, nel quale interpretavo un altro ladro messicano, Cuchillo Sanchez. Il regista del film, Sergio Sollima, avendo saputo del mio cattivo carattere, appena mi vedeva imbronciato mi domandava: «Che c’è, colombino?». Chiamandomi colombino mi disarmava completamente, impedendomi di esplodere, e lo sapeva. Un gran paraculo. Per me, invece, quel colombino era un’espressione razzista camuffata d’affettuosità… ma avevo pur sempre un affitto da pagare.
Il produttore del film era napoletano, si chiamava Salvatore Alabiso. Sul set indossava grisaglia, camicia bianca, cravatta nera, stivaletti e cappello da cowboy, il tutto nel deserto d’Almeria, in agosto, con cinquanta gradi all’ombra. Diceva sempre: «Non ci sono film belli o film brutti. Se a fine serata la cassa è piena, il film è bellissimo. Se è vuota, il film è ’na schifezza!».
Una volta, Salvatore teneva d’occhio con preoccupazione un nuvolone nero che si dirigeva verso di noi e non ci avrebbe permesso di girare. Sollima, invece, continuava i suoi preparativi senza agitarsi.
Quando si innervosiva, Salvatore emetteva un lamentino con la gola che sembrava un fischio. E quella volta non fu da meno. «Perché non ti sbrighi Sergi’, iiih…?»
Siccome Sollima non lo ascoltava, il lamentino di Salvatore si trasformò in urlo terrificante che sembrava provenire dal nuvolone nero. Prese il copione e si mise a strappare le pagine: «Questa scena non si fa, viaaa! Quest’altra neppure!». I fogli volavano ovunque. «Basta! Cambiamo posto! Andiamocene! Viaaa!»
Nel film c’era anche Lee Van Cleef, nel...