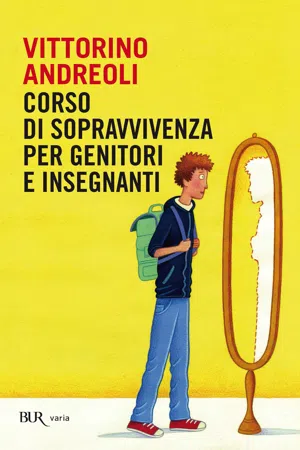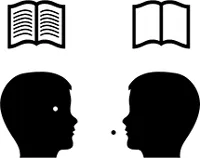![]()
parte terza
CASI CLINICI A SCUOLA
![]()
INTRODUZIONE
Sigmund Freud incomincia a parlare di psicoanalisi con i casi clinici. La presenta cioè attraverso delle storie, le prime cinque che costituiranno il volume fondamentale: I casi clinici.
Non vi è dubbio che ogni disciplina nasce dal particolare e poi si sviluppa fino al generale e alla descrizione dei principi e della sua organizzazione strutturata.
Il riferimento ai casi è particolarmente importante perché riportano ai problemi di una vita quotidiana, in questa circostanza di vita scolare, con la complessità dei messaggi, delle relazioni e dei problemi che vi entrano in maniera talvolta molto pesante.
È certo che l’affrontare un caso dipende dalla cultura di una scuola: quanto maggiori e approfondite sono le conoscenze sulla psicologia generale, tanto più saranno gli strumenti a disposizione per affrontare anche il caso specifico.
In questa breve introduzione ci proponiamo semplicemente di riferire la modalità, lo schema attraverso cui i casi vengono descritti e analizzati. Uno schema che ha in parte una convenzionalità, ma che soprattutto fa riferimento a un processo, a una metodologia della comprensione, che è la base e la premessa per ogni tipo di intervento risolutorio.
Ogni caso sarà distinto in quattro parti.
La prima riguarda la storia e conterrà l’avvenimento, ciò che è accaduto, con la descrizione per quanto possibile precisa dei personaggi che ne faranno parte. Si tratta di un vero e proprio racconto, che non si limita solo al fatto, ma anche alla situazione in cui si è svolto. In questa parte prevarrà comunque la cronaca, l’atteggiamento del cronista che narra l’evento e ne riferisce le caratteristiche dei soggetti e del luogo in cui è avvenuto.
La seconda parte attiene all’analisi psicologica della storia. Degli elementi che entrano nella cronaca viene fatta una scelta e alcuni di essi assumono un rilievo particolare, da un punto di vista psicologico. Anche dati di pura cronaca possono così essere tradotti e decodificati. Una sorta di lettura psicologica di quella stessa cronaca. Un’altra storia che alla prima lettura non appariva, che era sottostante, una specie di ombra delle motivazioni, dei sentimenti che, in qualche modo, hanno guidato l’evento. È come se si dovesse andare oltre il dato fotografato, per scavarvi sotto, fino ad arrivare all’inconscio, e quindi a quella determinante del comportamento che può sfuggire, ma che deve entrare almeno, in ipotesi, per potere fornire significato a quella storia.
Senza un’analisi che include lo sforzo della comprensione non è possibile passare alla terza parte, che è quella della soluzione del caso. Altrimenti si rischia di avere una scuola che non comprende, appunto una scuola da decreti, da regolamenti, che si limita a constatare fatti e ad agire meccanicamente seguendo il dispositivo di legge. Una scuola disanimata, che farà sentire agli studenti sempre più un’incomprensione profonda, e che potrà stimolare reazioni ancora più contrapposte, oppositive.
L’importanza di una psicologia che entri nella scuola riguarda proprio l’analisi dei comportamenti e quindi la necessità di trattare con attenzione qualsiasi evento, prima di potere prendere delle decisioni.
Così, nella terza parte, verrà prospettata la soluzione del caso. In questa sezione sarà visibile la struttura articolata: prima di adottare la soluzione, si devono infatti sentire tutte le proposte fatte dai diversi insegnanti nel Consiglio di classe.
Le ipotesi di intervento dovranno costituire la base della discussione, che non deve peraltro terminare in un antagonismo per rimandare la decisione, ma porterà ad adottare una soluzione, che avrà in sé la forza non della verità, ma della coerenza.
Ancora una volta si deve trovare la soluzione che corrisponde di più al sapere proprio della psicologia.
Così nella trattazione del caso, le opzioni vengono a mano a mano scartate, motivandole sulla loro incompatibilità con i principi della psicologia, fino all’analisi della soluzione che appare più conforme all’esigenza del caso proposto.
È chiaro che questo diventa un punto di vista speciale, quello della psicologia, che fino ad adesso è mancato nella scuola e la rivoluzione della riforma nella preparazione dei docenti sta esattamente in questo, nell’esigenza che essi acquisiscano un sapere, che ha, alla base la disciplina psicologica. Questo garantirà uno sguardo sulle vicende dei comportamenti e una nuova tendenza nella scelta del modo con cui intervenire.
La storia termina con una epicrisi che riassume il senso della soluzione scelta, e cerca di portare il significato di quel caso singolo, in una visione più ampia che riguardi in modo più diffuso gli studenti, così che la storia specifica possa diventare un esempio utile alla soluzione di molti altri casi.
Si torna così a qualcosa che somiglia all’exemplum dei predicatori medievali, dei Francescani e dei Domenicani in particolare.
![]()
CASI DI STUDENTI
Storia di una vittima del bullismo, Giuseppe
La storia
Il caso non porta il nome di un bullo, ma quello della vittima. Giuseppe, uno studente del primo anno di un istituto tecnico, è un ragazzo Down, quindi soffre di una condizione genetica che gli dà alcune specificità somatiche, che lo differenziano visibilmente dai coetanei dello stesso gruppo e, soprattutto, determina caratteristiche comportamentali che testimoniano un certo impaccio, un lieve torpore mentale, da cui deriva una difficoltà a partecipare alle esperienze di vita e anche di gioco dei pari età. Si avverte, insomma, uno scarto, piccolo o grande, che determina la sua esclusione da ogni attività che venga condotta con lo stile dei compagni non diversamente dotati.
Va subito precisato che oggi i giovani Down hanno un inserimento sociale estremamente più ricco che in passato. È questo il risultato di un’educazione, di una sfida che porta le famiglie e la società nel suo insieme a rendersi conto che un danno genetico è solo uno degli elementi che contribuiscono a un comportamento, ossia il fattore biologico (vedi qui).
Questa componente può essere, almeno in parte, compensata da un’esperienza individuale positiva con una famiglia attiva, che dà un forte senso di sostegno, favorendo l’autostima e, soprattutto, da un ambiente sociale che tenda a non isolarlo.
Giuseppe frequenta la prima classe dell’istituto tecnico assieme a compagni che hanno la sua stessa età e ciò sta a indicare che il curriculum passato risulta ben supportato. Nei precedenti anni di scuola elementare e media, Giuseppe non è rimasto indietro nei programmi, si è ben inserito e, in qualche modo, ha trovato un aiuto sia negli insegnanti, sia nelle classi di cui ha fatto parte.
Ciò non toglie che le differenze esistano, e sarebbe perfettamente inutile, anzi frutto di un romanticismo che finisce per diventare negativo, ritenere che non sussistano, almeno a una valutazione superficiale.
Questa storia accade nell’ora di intervallo, alle 11, quando Giuseppe viene avvicinato da una ragazza, che frequenta, come lui, la prima classe, nello stesso istituto, anche se in una sezione diversa. Lo chiama con un fare di conquista e lo convince a entrare nella propria aula.
Non è difficile raggiungere l’obiettivo, perché Giuseppe interpreta l’invito come un gesto amichevole. Quindi entra nella classe.
Ad attenderlo ci sono tutti gli altri componenti di quella prima.
La porta si chiude e Giuseppe viene fatto oggetto di una serie di atti di violenza che vanno da quella verbale fino a veri e propri pugni. A essi partecipa l’intero gruppo, anche se la regia spetta a uno di loro, che tiene in mano uno strumento per la ripresa video, ossia un telefonino usato come cinepresa.
Mentre la violenza si consuma, il ragazzo filma ciò che accade, tra cui, ad esempio, un colpo assestato da un «attore», uno dei componenti della classe, nel momento in cui si trova in una posizione ideale, dal punto di vista cinematografico, che permette all’operatore di immortalare la scena. Qualche altro compagno disegna sulla lavagna simboli che richiamano il nazismo, inneggiato come uno dei periodi in cui si è cercato di perseguire una razza pura, con l’eliminazione di tutti coloro che erano considerati inferiori.
Tutto ciò rivela una perfetta pianificazione del gesto: dallo spazio, entro cui si consuma la scena; al tempo, quello dell’intervallo; alla ripresa che ne viene ricavata, una sequenza di 3 minuti e 17 secondi, che immortala quanto accade.
Questo caso di bullismo si sostanzia, dunque, in una violenza nei confronti di una persona, compiuta, con diverse responsabilità, ma coralmente, da un’intera classe. La voglia di estrinsecare un comportamento fuori norma avviene, insomma, da parte di tutto il gruppo, all’interno dell’aula.
Ha, dunque, un excursus che è estraneo alla valutazione dell’insegnante e a tutte le dinamiche di profitto e di giudizio che, abitualmente, questo tipo di fenomeni contempla.
Questo dato è di particolare gravità per due aspetti principali.
1. Prima di tutto perché mostra come la tendenza al bullismo abbia coinvolto tutti gli adolescenti di quella classe, sia pure con ruoli diversificati. È chiaro infatti che chi ha materialmente preso a pugni la vittima esprime un’intensità diversa da chi, invece, si è limitato a sorridere, o da chi è rimasto in silenzio, senza fare alcuna opposizione, senza gridare all’ingiustizia, all’inaccettabilità di un tale comportamento.
Ma l’elemento corale è importantissimo, perché è stato talmente forte da annullare anche le differenze di valutazione della scuola tra i singoli alunni. In altre parole, quest’atto ha coinvolto sia i bravi, sia i meno bravi, gli asini. Pertanto è un gesto di bullismo che avviene nella scuola, ma al di fuori delle dinamiche del giudizio.
2. Il secondo aspetto da sottolineare è che tutto si svolge sulla particolare opportunità di poter giocare su una persona che soffre di un disturbo Down e dunque di una diversità. Proprio su questo scarto si esprime una forza, una superiorità.
Al di là di quelle che possono essere le considerazioni etiche, qui il dato eclatante è proprio la partecipazione dell’insieme dei ragazzi, che finiscono per essere poi presenti nel video, che è stato programmato, all’interno di quest’atto di bullismo, con la consapevolezza che chi fosse rimasto in classe sarebbe diventato parte anche dello spettacolo.
Che il bullismo sia in qualche modo accettato, lo dimostra il fatto che quella sequenza terrificante viene poi condivisa con gli amici, e persino messa online, su un sito internet, tanto da offrire uno spettacolo a cui chiunque può partecipare. Basta connettersi al sito web.
Finito l’intervallo, quando la classe si ricompone per la lezione, Giuseppe, in lacrime, racconta ciò che gli è successo: il primo momento in cui aveva pensato che si trattasse di un gioco, a cui aveva tentato di partecipare, con quell’ipocritica che spesso in questi soggetti si manifesta, poi il dolore dei pugni, l’evidente inimicizia, l’atmosfera crudele, il pianto.
Il caso viene divulgato attraverso internet, ma, allo stesso tempo, viene anche confessato e quindi arriva all’attenzione degli insegnanti e dei responsabili della scuola. Questa è la storia.
L’analisi psicologica
Per analizzare questo caso si deve fare riferimento alla psicologia di gruppo. Ancora una volta è altamente probabile che ciascuno, singolarmente, non avrebbe usato violenza, e quindi espresso quel comportamento di bullismo in maniera individuale. Nemmeno il leader, sebbene sia pensabile che il regista abbia svolto un compito particolarmente significativo nell’organizzazione del gesto, da attuare con la collaborazione di ogni membro della classe, primi attori e comparse, senza le quali la scena non avrebbe avuto la medesima efficacia.
Dobbiamo quindi soffermarci sull’interazione dell’insieme, rammentando che, nel caso di adolescenti, come si è detto, la spinta all’essere contro e il desiderio di compiere azioni, che la società non può accettare, sono particolarmente accese.
Non deve essere passato in secondo piano inoltre l’ambiente in cui questo episodio si svolge: la scuola, intesa come edificio, come aula, anche se, quando la violenza viene consumata, l’unica componente presente sono gli studenti, mentre manca l’altro referente necessario che è costituito dal docente o dai docenti.
Insisto sulla necessità di dare rilievo a questo fattore, poiché la sfida sta appunto nel porre in essere qualcosa che si sa con certezza che la scuola non solo proibisce, ma che non può assolutamente accettare. Infatti, la sua finalità è educare a una vita sociale improntata alla cooperazione, e, anche quando avverte delle conflittualità, stimolare alla ricerca di una soluzione non violenta.
Si tratta di una posizione generale che viene sostenuta, anche se, nel valutare il comportamento che le classi possono esprimere, non deve essere tralasciato il ruolo che il dominio del giudizio esercita nelle dinamiche collettive, soprattutto quando quel giudizio appare ingiusto e diventa discriminatorio, poiché punisce chi magari non meritava quella punizione e, invece, privilegia la furbizia di chi è piuttosto abile a recitare parti che non corrispondono al merito.
Ma non vi è dubbio che nessun insegnante, per quanto convinto dell’importanza dei giudizi e persino della necessità di questi, anche quando siano severissimi, potrebbe mai approvare ciò che, invece, in quella classe è accaduto.
Pertanto quell’atto di bullismo generale va letto come fenomeno che si lega alla scuola e a cui la scuola si oppone in maniera nettissima. Si tratta di una contrapposizione di tutto il gruppo, che vuole essere siglata e riconosciuta come realtà generale, tanto che la si fissa in video e quindi la si spettacolarizza e condivide su internet. La messa in onda online è, anzi, l’imprimatur del fatto di esistere, di esistere nella dimensione più ampia.
A sostenere la violenza, oltre che nei confronti di Giuseppe, anche contro la scuola, stanno alcuni segnali espliciti, ossia quei contenuti di dottrine estreme che, nella storia mondiale, hanno avuto un d...