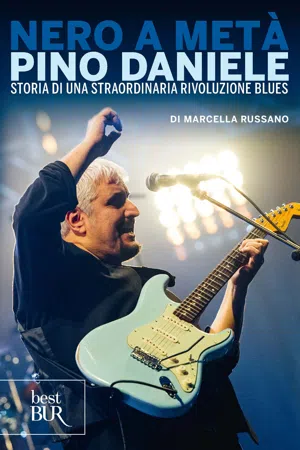![]()
Canzoniere di un mascalzone latino
Fino a questo punto abbiamo analizzato le influenze che hanno caratterizzato la musica di Pino Daniele da un punto di vista politico, sociale e culturale. Ma quello che rimane, al di là di tutte le analisi che possiamo fare, di tutte le analogie che possiamo trovare e di tutte le influenze che possiamo rintracciare, è il potere evocativo delle canzoni del musicista partenopeo. Il suo è un canzoniere molto articolato e ricco, composto da più di duecento brani, attraverso i quali Daniele affronta i temi più disparati e racconta atmosfere, luoghi e sentimenti con una tale profondità e una tale poesia da rimanere ancorato nella memoria di più di una generazione e da segnare, in maniera indelebile, il patrimonio artistico di un’intera cultura, quella partenopea. Quello che faremo di seguito è, dunque, ripercorrerlo, per quanto ci è possibile, esaminandone le tematiche a nostro parere più importanti.
Ritratti
Una delle caratteristiche che rendono unica la produzione poetica danieliana è la capacità del cantautore di dar vita a dei veri e propri ritratti, che emergono dalle note delle canzoni per ergersi in tutta la loro vividezza davanti a chi ascolta. Questa attitudine è già molto presente in TERRA MIA, l’esordio discografico del 1977, nel quale c’è una sorta di carrellata di affreschi della Napoli dei vicoli del centro. Luoghi, abitudini, tic linguistici e comportamentali sono descritti in maniera efficace, e le canzoni dell’album hanno il potere di trasportarci di peso in una realtà palpitante ed eterna al tempo stesso, quella dei bassi della città partenopea dove Daniele ha vissuto in prima persona: “Da Napoli vengono i succhi vitali della mia fantasia, quelle radiazioni che ho assorbito da ragazzo nato e vissuto tra Santa Chiara e Santa Maria La Nova. Emozioni, figure, persone, destini, sensazioni che confluiscono nell’ispirazione che mi dona una frase musicale, un accordo carico di profondità e di colori, un verso o un pensiero”1.
Basta ascoltare il primo singolo a comparire sul mercato, che come abbiamo detto è Che calore, per ritrovarci immediatamente immersi in una realtà ben definita e palpabile. L’atmosfera di questo brano è descritta dai commenti di più personaggi che si affiancano alla voce narrante. Una signora in sovrappeso che non riesce a salire le scale, un guaglione del bar preoccupato per le tazzine che porta sul vassoio e il caldo asfissiante e torrido dell’estate napoletana sono il perfetto intreccio narrativo per rappresentare uno degli aspetti tipici della città partenopea. Ma Che calore è una canzone corale, dove si mette in scena un momento di vita comune. La B-side del singolo, invece, Furtunato, è il ritratto di un personaggio a se stante, una sorta di simbolo della napoletanità. Dice lo stesso Daniele: “Furtunato è un personaggio caratteristico napoletano. Furtunato è uno che vende i taralli, ha un carrozzino e gira per Napoli. È un tarallaro […]. È la coscienza di Napoli. Gira per i vicoli gridando e chiamando la gente dai balconi. Per lui Napoli è sempre la stessa. Una volta, ero a casa nella mia cameretta, stavo suonando e passò Furtunato. Mi sono detto: perché non fare una canzone su di lui? In quel momento stavo suonando un po’ di musica sudamericana e, anche se il pezzo non ha lo spirito sudamericano, ha un colore un po’ strano. C’è un’introduzione di mandolini che ho messo per caratterizzare una canzone napoletana ma diversa”2.
Dunque il ritratto di Furtunato è emblematico. Il tarallaro è un venditore ambulante di taralli fatti con la sugna e il pepe, tipici della cucina partenopea. Il suo grido risuona tra i vicoli della città e, affacciandosi ai balconi o uscendo in strada, la gente può comprare la sua “robba bella”. Quello che del discorso di Daniele colpisce è l’affermazione che per Furtunato “Napoli è sempre la stessa”: è una realtà immutabile, eterna appunto, come eterno è il mestiere del tarallaro che diventa quasi metafora della napoletanità stessa. Passa per i vicoli, grida il suo richiamo, saluta le donne che si affacciano ai balconi e più grida, più donne attira, più merce riuscirà a vendere per arrivare a sbarcare il lunario. Ma il tempo passa:
Cagnano ’e ffemmene
cagnano ’e barcune
e isso saluta senza penza’
Napule è comme ’na vota
ma nuje dicimmo ca adda cagna’
Furtunato tene ’a rrobba bella
’nzogna ’nzogna
E dunque, nonostante l’immutabilità e la fissità di certe abitudini, Napoli “adda cagna’”, deve cambiare. L’ansia di rinnovamento scorre sotterranea accompagnata dal grido del tarallaro.
Un altro meraviglioso ritratto presente in TERRA MIA è Saglie saglie. Anche questa canzone è dedicata a un venditore ambulante, un ragazzino che percorre i vicoli con le sue ceste piene di agli. Il brano, che si apre con il suono sovrapposto di mille campanelli, ci dà immediatamente l’idea di una giornata di canicola tra i vicoli e i gradini dei Quartieri. Poi la nenia cantata dalla straziante voce di Donatella Brighel dipinge con poche ed efficaci pennellate il supplizio quotidiano del venditore ambulante, figlio del sottoproletariato urbano, vessato dalla fatica e dal calore, preoccupato per la sua sussistenza che dipende direttamente dalle sue capacità commerciali:
Saglie saglie cu’sta sporta chiena d’aglie
si nun saglie e scinne
tutta ’sta rrobba nun’a vinne
Sali, sali, con questa cesta piena di aglio, se non sali e scendi tutta questa roba non la vendi, recita questa nenia disperata e immediatamente ci ritroviamo sulle gare, le scalinate che in lungo e in largo percorrono i quartieri poveri della città, dove la vita scorre tra miserie e contraddizioni millenarie. Poi è lui, il ragazzo, il venditore ambulante, a parlare:
Sole, sole d’òro
a matina me daje forza
mentre attuorno tutto more
quanti vote ’mmiezo ’e mane
’mmiezo ’e mane aggio guardato
quanti cose aggio perduto
quanti cose aggio truvato
La sua è una sorta di preghiera pronunciata, recitata e cantata dallo stesso Daniele, una preghiera rivolta al sole che è poesia: sole, sole d’oro, la mattina mi dai forza mentre attorno tutto muore. Quante volte in mezzo alle mani ho guardato, quante cose ho perso, quante cose ho ritrovato. Memorabile è la versione incisa nel 1991 in occasione del disco SOTTO ’O SOLE, raccolta di riletture di brani già editi a cui si affiancano Quando, tema centrale del film di Troisi Pensavo fosse amore e invece era un calesse e ’O ssaje comme fa ’o core, brano scritto dall’attore stesso. Ed è in questo disco che Saglie saglie viene reinterpretata interamente da Daniele. A fargli da contrappunto, nel recitativo della strofa, è uno stupendo ed emozionante Massimo Troisi.
Chiude la serie dei ritratti di TERRA MIA il brano Cammina cammina. La ballata, che si sviluppa solo su chitarra e voce, racconta della vecchiaia descrivendo alcuni momenti della giornata di un anziano signore che, per far sì che il tempo che lo separa dalla morte trascorra più veloce, non fa altro che camminare. La figura dell’uomo che curvo cammina senza sosta sotto la luna, in silenzio assoluto poiché non c’è nessuno con cui parlare, sembra assumere la grandezza e il respiro paradossale di una delle odi leopardiane.
E cammina, cammina vicino ’o puorto
e rirenno pensa ’a morte
se venisse mo’ fosse cchiù cuntento
tanto io parlo e nisciuno me sente
La morte è un pensiero di cui ridere, è qualcosa di addirittura auspicabile quando non si ha più nessuno con cui parlare. Poi il vecchio signore pensa alla sua amata, Maria, che è morta da tre anni. Ci pensa tutte le sere e non gli sembra vero di essere rimasto solo al mondo. Così la morte non è più un pensiero su cui ridere ma assume il peso del dolore in quanto metafora di un’assenza, della mancanza di qualcuno con cui condividere le giornate, le ore e i minuti. È uno spaccato di vita quotidiana, di saggezza popolare che diventa universale, che si distacca dalla sua cornice per assumere una valenza assoluta.
Differente è invece la prospettiva della narrazione in Donna Cuncetta, altro sapiente affresco della saggezza popolare contenuto nell’album PINO DANIELE. Il brano è introdotto da chitarre e violini dal sapore tipicamente mediterraneo e descrive con veloci pennellate il carattere e l’aspetto di una donna del popolo:
Donna Cunce’ parlate
donna Cunce’ dicite
’o tiempo d’e cerase è già fernuto
Donna Concetta parlate, non abbiate paura di esprimervi, dice la voce narrante, siete ormai esperta della vita (il tempo delle ciliegie è già finito).
Dint’a ’stu tuppo niro
nce stanno tutt’e paure
’e ’nu popolo ca cammina sotto ’o muro
Nel vostro tuppo (chignon) di capelli neri sono racchiuse le paure di un popolo che sta sempre in guardia e non può lasciarsi scoperte le spalle (cammina rasente il muro).
Donna Cunce’ cacciate
tutt’e ricordi a’mpietto
donna Cunce’ alluccate pe’ dispietto
Donna Concetta raccontate tutti i ricordi che tenete stretti al cuore e urlate per dispetto.
La figura di Donna Concetta è il simbolo della vasciaiola napoletana (usando il termine nel senso positivo di “colei che abita nei bassi della città”). È una donna forte ed è già matura nonostante abbia ancora i capelli neri. È il simbolo delle paure del suo popolo, è depositaria della memoria collettiva e ha il sangue caldo dei meridionali. Il ritratto che ne fa fin qui Pino Daniele è molto sanguigno e appassionato. Ma la vera anima di Donna Concetta la percepiamo soltanto quando la prospettiva del racconto cambia ed è lei a prendere la parola e a esprimere i suoi pensieri:
E si vulesse Dio
cu chesta fantasia
jettasse tutt’e cose a mare
Ma se solo Dio me lo permettesse, con la fantasia che mi ritrovo, butterei tutto a mare.
Mo’ ca so’ vecchia e dormo
nun pozzo cchiù fa’ niente
so’na pezza mmano ’a gente e tengo mente
Ma s’je fosse guagliona
je fosse capurione
e quando vott’o viento dic’a mia
e sulamente si vulesse Dio…
Ora che sono vecchia e passo la maggior parte del mio tempo a dormire, non posso più far niente, sono solo uno straccio nelle mani degli altri e cerco di ricordare. Ma se fossi una ragazza, allora sarei il capo del rione e non avrei paura a farmi sentire, a dire la mia, se solo volesse Dio. Nei sogni di Donna Concetta, ormai anziana e costretta a dipendere dagli altri, c’è la sua giovinezza, il suo passato di caporione, di donna sfrontata e decisa, simbolo della libertà d’azione e della capacità di essere incisivi del suo stesso popolo: simbolo della forza e del carattere delle donne napoletane, donne del Sud, donne forti, abituate a combattere per imporre la propria volontà e a destreggiarsi tra gli ...