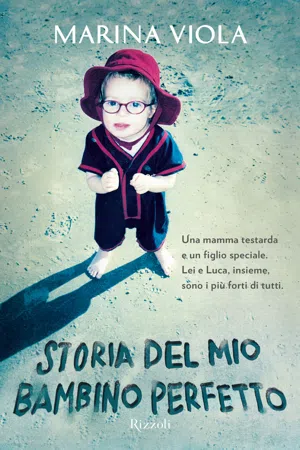![]()
Mai più soli
Come quasi ogni volta che andiamo da Byrne e Heather, siamo arrivati in ritardo e trafelati.
Byrne è uno dei miei più cari amici. Ci incontrammo quando io venni negli Stati Uniti la prima volta, nel 1987. Facevo la ragazza alla pari a casa di Victoria, ma pochi mesi dopo il mio arrivo, nel suo seminterrato umido, mentre fumavamo una sigaretta di nascosto dai suoi figli, lei mi confessò che per il marito era diventato troppo impegnativo avere un’adolescente sotto lo stesso tetto, e che davo il cattivo esempio ai bambini perché ogni sera mi veniva a prendere un ragazzo diverso. Gentilmente, quindi, mi chiese di trovarmi un altro posto dove andare a vivere.
Spaesata, chiesi aiuto a uno dei ragazzi che avevo conosciuto nel frattempo, Richard, che tuttora è il mio migliore amico ed è come se fosse un fratello. Lui, grazie alla sua personalità stravagante, creativa, genialoide e spiritosa, conosceva mille persone, e sapevo che mi avrebbe trovato una stanza in affitto da qualcuno. Mi diede un indirizzo e mi disse: «Vai e di’ che ti ho mandato io. Sono degli studenti universitari amici miei e hanno una stanza libera».
Andai con le mie valigione, un po’ spaventata e titubante bussai alla porta. Aprì un energumeno che scandì in italiano: «Disciplina!» (gliel’aveva insegnato Richard due minuti prima al telefono). Entrai, misi le mie cose in camera e andai di corsa da Dan. Poi la sera tornai a casa e incontrai i ragazzi con cui avrei abitato per sei mesi. Uno di loro era Byrne. Non molto alto, biondo, faccia da irlandese, con un carisma raro ma completamente matto, Byrne divenne da subito un amico molto stretto.
Il giorno in cui dovetti tornare in Italia, mesi dopo, coincise con il giorno in cui lui partì per la Carolina del Sud, dove andò a studiare Pediatria. Sua madre ci portò all’aeroporto insieme. Ci abbracciammo forte e poi non ci vedemmo più… fino a una quindicina di anni fa, quando lui venne a sapere da Richard che avevo avuto un figlio con la sindrome di Down e autistico. Mi chiamò e due ore dopo era a casa mia. Rivederci fu un’emozione fortissima: non mi sembrava affatto cambiato. Era rimasto quell’irlandese un po’ matto che avevo conosciuto tanto tempo prima. Ma adesso era sposato con Heather e insieme avevano avuto due bambini.
Byrne è rimasto negli anni un carissimo amico, un punto di riferimento essenziale, ma anche un supporto medico, visto che è pediatra e spesso lo chiamo per chiedere consigli, soprattutto su Luca. “Sarebbe stato bello” penso ogni tanto “se fosse stato lui il pediatra di Luca nei momenti in cui cercavamo un sostegno.” Avrebbe saputo darci quell’appoggio che solo Byrne è capace di dare, e allora ne avremmo avuto davvero bisogno, visto che la famiglia di Dan non era stata in grado di tenerci per mano e camminare con noi.
Invece allora la pediatra di Luca era la dottoressa Price: una persona del tutto diversa. Un giorno le avevo portato Luca per una visita di controllo e ricordo che lei mi guardava strano, come se avesse avuto qualcosa da rivelarmi ma non osasse farlo. Continuava a rassicurarmi, andava tutto bene, dovevo essere forte, pensare ad allattare, a essere serena. Mi faceva i complimenti per la mia apparente tranquillità. Avevo però la sensazione che non riuscisse a trovare il momento o le parole giuste per dirmi qualcosa di importante, e che continuasse a girarci intorno. Mi rivelò, tra le altre cose, che stava aspettando i risultati degli ultimissimi esami, e che mi avrebbe fatto sapere. Mezz’ora dopo mi telefonò a casa: «Ho ricevuto i risultati. Luca ha una forma strana di sindrome di Down: mosaicismo con traslocazione robertsoniana. Dovresti cercare su Internet, perché io non ne so molto».
In che senso sindrome di Down?
Riattaccai la cornetta e per un attimo fu come se avessi messo le dita in una presa della corrente. Mi ritrovai, immobile e incapace di parlare, a fissare Luca, come se avesse fatto chissà che cosa, come se fosse stata colpa sua. Lui, ignaro, continuava a giocherellare con il girello. «Ho capito bene? Ha detto proprio sindrome di Down?» E mentre lo pronunciavo a voce alta, mi assalì un panico senza precedenti, fino ad allora ignoto. Come se a un tratto avessi sbattuto la faccia contro un muro di ghiaccio a velocità altissima. Come se fossi stata aggredita alle spalle, inaspettatamente, violentata e abbandonata in una stradina buia. La sindrome di Down è roba cronica, che dura per sempre, non si cura, tutta la vita mia e sua e di Dan. Forever.
Con frenesia, composi il numero dell’ufficio di Dan e in lacrime gli dissi: «Luca ha la sindrome di Down. Vieni adesso, ti prego». Subito dopo chiamai Claudia, sua sorella, che abitava a cinque minuti di macchina da casa. Rispose Matt, suo marito, e io, tra un singhiozzo e l’altro, quasi farneticando, annunciai anche a lui la notizia. Dall’altra parte della cornetta ci fu soltanto un silenzio imbarazzante. Io piangevo troppo per parlare. Aspettavo che dicesse: «Adesso arriviamo». Ma non lo fece. «Sono a casa da sola. Ho paura» esclamai fra le lacrime, per aiutarlo a capire che volevo stare con loro.
«I’m sorry» rispose lui. «È l’ora di cena, nostra figlia Isa deve mangiare. Non possiamo muoverci.»
«Cosa?» chiesi incredula. Ma non siete lì tutti e due? Non può venire solo uno di voi? Isa non può mangiare mezz’ora dopo? Ovviamente non dissi nulla di tutto questo. Se mia mamma era partita da Milano per poter stare con me durante un esame medico, non avevo dubbi sul fatto che Claudia o Matt sarebbero venuti da me, sola in casa con un dolore enorme dentro, ad abbracciarmi, a piangere, a stare insieme, condividere, ascoltare. O anche solo ad aspettare con me l’arrivo di Dan. Però era quasi ora di cena, e la stavano preparando. Non era il momento giusto per le emergenze. Allibita dalla risposta, restai in attesa di Dan.
Durante quel lasso di tempo mi dimenticai completamente della presenza di Luca. Per me erano cambiate tutte le carte in tavola, la vita come me l’ero immaginata era stata cancellata per sempre, aveva imboccato un’altra strada, intrapreso un viaggio tutto diverso. Ma per lui non era cambiato assolutamente nulla: era lo stesso bambino che giocava tranquillo prima della telefonata della pediatra e, esattamente come prima, continuava imperterrito a far girare la palla con dentro le perline attaccata al bordo verde del girello.
Mi piacerebbe poter tornare indietro a quel preciso istante in cui per me tutto si faceva diverso ma per lui non era successo assolutamente nulla. Vorrei tornarci per imparare da lui, vorrei come lui poter andare avanti e fare le cose che facevo prima, senza pensare che invece sarebbe cambiato tutto. Era la mia idea di essere madre e di come sarebbe stato mio figlio a cambiare, ma non lui e non la situazione di per sé; non le cose che poi sarebbero successe. No, quelle sarebbero accadute anche senza questa notizia devastante, anche senza la telefonata, anche senza le parole “Down” e “sindrome” scandite bene in una cornetta. Perché, e io ci tornerò mille volte, “Luca is Luca”, e Luca è così, esattamente così, da quando è nato. Solo che noi lo scoprimmo soltanto in quel momento.
Quando vidi Dan arrivare dalla stradina, gli corsi incontro, ci abbracciammo e piansi a lungo. Tutti e due lì, vinti da una diagnosi devastante, mentre Luca ci guardava strano. Dan mi chiese di ripetergli tutto quello che la pediatra mi aveva detto, e andammo subito a cercare informazioni su Internet per cercare di capire, di sapere. Frenetici, impauriti, sconfitti.
Scoprimmo che avere la sindrome di Down voleva dire avere tre cromosomi invece di due nella ventunesima coppia. Uno pensa: “E cosa sarà mai un cromosoma in più”… al limite dovrebbero esserci più informazioni nel DNA, non meno, le persone così dovrebbero essere migliori. E invece è come sballare un equilibrio perfetto, dove basta una lieve folata di vento e cade tutto, come un castello fatto di carte da gioco. Il cromosoma in più è la folata di vento, il castello la normalità.
La sindrome di Down, leggevamo io e Dan con gli occhi sbarrati, comporta una serie di problematiche che, sapute tutte in una volta un’ora dopo aver scoperto che tuo figlio ne è affetto, sono terrorizzanti: problemi fisici (malformazioni al cuore, aumento del rischio di leucemia e altri tipi di cancro, diabete, problemi alla tiroide, problemi neurologici, problemi legati al tono muscolare troppo basso, per dirne solo alcuni), ma anche intellettivi e sociali (sono ridicolizzati, marginalizzati, sottovalutati, presi in giro). Infatti le persone con la sindrome di Down hanno ritardi in tutti gli aspetti dello sviluppo: mentale (un quoziente intellettivo più basso della norma), emotivo (soffrono spesso di depressione), fisico (sono basse e grassottelle), verbale (non pronunciano bene le parole), e chi più ne ha più ne metta. La tipologia che venne diagnosticata a Luca sembrava essere leggermente meno paurosa: si chiama “mosaicismo”, significa che non tutte le cellule si presentano con un cromosoma in più, per cui le ripercussioni possono essere meno drastiche.
Mosaicismo: fin da subito mi aveva ricordato il mio libro di storia dell’arte del liceo. Pensavo ai mosaici bizantini, a quello di Ravenna con i due uccelli che bevono da una fontana. Mi sembrava quasi una cosa bella, il mosaicismo. Quello di Luca, scoprimmo più tardi, è un mosaicismo raro, che colpisce poco più del due per cento delle persone affette da sindrome di Down. Ancora più oscuro, ancora meno studiato.
Dopo aver concluso la nostra ricerca, Dan telefonò ai suoi per annunciare che il loro primo nipote maschio aveva la sindrome di Down. Finora era stato lui quello forte, razionale, quello che consolava me, che ero distrutta; ma, mentre dava la notizia ai genitori, scoppiò a piangere, e a me si sciolse tutto dentro. Volevo poter essere io quella coraggiosa, volevo essere io a tenergli la mano, ricordargli che “Luca is Luca”, che la forza l’avremmo trovata, che guarda com’è bello, il nostro bimbo.
Ma adesso era compito dei suoi genitori consolarlo. Lui si era rivolto a loro ed era un momento in cui io dovevo farmi da parte. Lo capivo bene. Ero sicura che loro, che abitavano a qualche miglio di distanza, si sarebbero presentati per abbracciare il figlio, tenergli la mano, consolarlo, stargli vicino in questo momento che per sempre avrebbe cambiato la sua vita, e la loro. Anche loro, pensavo infatti, ne avranno pure avute di aspettative per il nipote, aspettative tarpate per sempre dalla voce della pediatra.
Invece non arrivò nessuno. Nessuno bussò alla porta, nessuno ci venne ad abbracciare, nessuno ebbe la decenza di condividere con noi quel momento. Eravamo io e Dan, seduti sul divano, abbracciati. Soli.
Non vedevo l’ora di sentire la voce rassicurante di mia madre ma, per via del fuso orario, da lei era notte fonda. Rimasi sveglia fino all’una di notte, che a Milano sono le sette del mattino, per poterla chiamare a un’ora decente. Sapevo che sarebbe stata già sveglia, avrebbe già bevuto la sua acqua calda, il suo caffè leggero e la prima sigaretta sarebbe già diventata cicca, nel portacenere in rame.
«Hanno scoperto cos’ha Luca» le dissi, togliendomi un macigno dal cuore e gettandolo a lei. «Sindrome di Down, mamma. Sindrome di Down, ma solo parziale. Non tutte le cellule hanno il terzo cromosoma» proseguii, cercando di attutire il colpo, perché sapevo di dare a lei lo stesso dolore che mi aveva dato la pediatra qualche ora prima. Capisco, non sono cose che si possono dire per telefono. «Scusa, mamma.»
«Ah» rispose lei scioccata, cercando le parole giuste per una figlia nel panico più totale, mentre sicuramente chiudeva gli occhi, piano. «E adesso?» le venne fuori, per metterla sul lato pratico, per prendere tempo prima di elaborare la botta.
Adesso sono nella merda, è l’una di notte e la famiglia di Dan ci ha fatto sentire già soli, mamma. Adesso voglio che tu mi venga a prendere e mi riporti a casa, nel mio letto, nella mia stanza con i poster di John McEnroe e di Vasco Rossi. Voglio tornare piccola, voglio essere accudita da te. Voglio che tu mi metta in castigo per essere tornata tardi. Voglio litigare con le mie sorelle. Voglio papà. Voglio non aver mai conosciuto Dan. Voglio andare in piazzale Loreto con la 93 e poi camminare verso casa di Angela, e chiacchierare invece di fare i compiti. Voglio le ripetizioni di latino, le lezioni di pianoforte, le vacanze a Bordighera. Voglio i soldi per la merenda a scuola. Voglio che tu vada a parlare con i miei professori, che dicono: «È intelligente ma non si applica». Voglio rientrare nel tuo utero. Voglio avere quattordici anni e preoccuparmi di come mi vesto, e se il moroso è arrabbiato con me perché odio la musica da discoteca.
Voglio morire, mamma. Adesso voglio solo morire.
«Non lo so. Continuiamo con la terapia. Nel frattempo dobbiamo portarlo a fare altri esami. Sai, la sindrome di Down spesso è associata a problemi di cuore, problemi alle vertebre del collo, problemi di digestione. Leucemia, depressione, ritardo mentale. Esami, mamma. Faremo altri esami. Scusa se ti chiamo a quest’ora per darti questa notizia.»
Tutto d’un tratto, quello che mi stava attorno, quello che io e Dan avevamo creato per far crescere la nostra famiglia in armonia e che mesi prima mi pareva poetico, romantico e splendido iniziò a sembrarmi claustrofobico e spaventoso.
Quando la mattina preparavo il caffè guardavo fuori dalla finestra della cucina che mi mostrava con violenza un prato, con i suoi alberi alti e robusti, gli scoiattoli che giocherellavano e si rincorrevano. A volte c’erano anche i coniglietti, bianchi, come quelli della Walt Disney. A me, vedendo tanta natura e tanta bellezza, veniva un magone immenso. Cercavo in questo quadretto campestre soffocante la perfezione che mio figlio non aveva, pensavo che lo scoiattolo era normale, come mamma scoiattolo si immaginava lui fosse, e invece mio figlio no. Vedevo in questa natura la distanza dal mio mondo: quello di Milano, di via Sismondi. Quello delle sorelle, che si litiga ma poi nel momento del bisogno si può contare una sull’altra. I coniglietti per me volevano dire alienazione, distanza, qualcosa di irreale, di sconosciuto e di brutto.
Il nostro era un sogno andato male. Era marcio dalla nascita. Era diventato un incubo.
Qualche giorno dopo io e Dan, entrambi sorpresi di come nessuno della sua famiglia avesse colto la gravità del problema, decidemmo di invitare i suoi genitori a cena per discuterne con loro e per condividere quello che stavamo provando. Arrivarono in perfetto orario: lui con le bottiglie di vino e lei con i soffici capelli bianchi, e si comportarono, come sempre, da ospiti un po’ impacciati, come se si sentissero fuori luogo. Si sedettero sul ciglio del divano in sala, aspettando che il pasto fosse pronto, a chiacchierare del più e del meno. Dopo una cena squisita, ma silenziosa e formale, con molta difficoltà Dan cominciò a parlare di quello che stavamo passando, di come avessimo avvertito da parte loro un palese distacco emotivo.
Raccontò la nostra storia come se i suoi non ne sapessero nulla, come se fossero arrivati da una crociera dove non c’era il telefono, e iniziò proprio dal primo elettroencefalogramma, dai primi giorni di Fenobarbital, dalle prime diagnosi, dal terrore dell’ignoto, culminato infine con la telefonata di qualche giorno prima. «Abbiamo bisogno d’aiuto» bisbigliò trattenendo le lacrime, quasi con imbarazzo.
«Quanto vi serve?» chiese il padre di Dan, dopo aver sorseggiato il vino e cercando di interpretare quello che suo figlio aveva appena detto.
Io mi alzai, e, con la scusa di andare in bagno, corsi in camera di Luca a guardarlo mentre dormiva, come per dirgli che comunque noi c’eravamo.
Quando scesi, Dan e i suoi avevano stabilito che, visto che noi avevamo bisogno di loro, avrebbero fatto in modo di ricordarsi di telefonarci almeno due volte la settimana e che avrebbero specificatamente chiesto come stava Luca. Sarebbe bastato? «Possiamo anche chiamare tre volte, se volete.»
Basta così, grazie.
La distanza di Claudia e Matt la capivamo ancora meno. I genitori di Dan, di un’altra generazione, forse avevano bisogno di tempo per assorbire la notizia. Alla loro epoca, infatti, una persona disabile aveva attorno a sé un non so che di vergognoso, come se la si dovesse tenere nascosta.
Ma Claudia e Matt erano nostri coetanei, e anche loro stavano vivendo la magia dei primi anni da genitori, l’amore profondo, le aspettative, i sogni, le speranze che si nutrono per proprio figlio e, visto che sapevano che per noi la strada sarebbe stata tanto difficile, ci aspettavamo da loro un supporto, il desiderio di condividere i momenti di crisi, un senso di urgenza; credevamo che ci venissero incontro, per sostenerci, per stare con noi e con Luca. Invece sembravano quasi impassibili, concentrati nel loro tran tran quotidiano, poco disponibili. A loro non è mai venuto in mente di prendere il piccolo Luca e portarlo a casa a giocare con la cugina, lasciando un po’ di tempo a me e Dan per stare da soli e digerire la botta, per esempio. Sembrava che fosse qualcosa che non li riguardasse.
Il centro per famiglie con figli disabili dove Luca andava a fare terapia tutti i giorni ci affidò a un’assistente sociale, che veniva da noi una volta a settimana. Mi piaceva molto: era una donna elegante, ma non rigida. Aveva una voce che ci calmava, e mi raccontò che suo figlio era nato con un tumore al cervello, e che era stato operato diverse volte. Mi diede così subito un aggancio, mi fece capire che era una di noi, che anche lei faceva parte delle madri che vivono nell’ansia, che capiva il mio trauma, perché aveva convissuto a sua volta con una maternità del tutto diversa da come se l’era immaginata.
Le raccontai che la famiglia di Dan non sembrava essere in grado di starci vicino, e di come questo mi facesse sentire sola, triste. Lei con grazia mi spiegò la difficoltà che spesso provano le persone che si ritrovano in una situazione del genere: nessuno nasce preparato ad affrontare un problema così grande. E poi c’era la questione dell’inadeguatezza, del non sapere esattamente in che modo rendersi utili, della paura di sbagliare. Erano meccanismi normali in queste circostanze, reazioni comuni. Non era colpa della famiglia di Dan, mi disse.
Propose di invitarli tutti a un incontro per parlare di questa nuova e drammatica situazione, e dare loro consigli su come starci vicini, ma anche suggerimenti su come affrontare il trauma. Noi non saremmo stati presenti, così che ciascuno potesse sentirsi libero di dire qualsiasi cosa senza timore di venire frainteso. Mi sembrava un’ottima idea: abitavamo tutti in zona, e non sarebbe stato difficile trovare un posto e un giorno che andasse bene a ognuno. Mi disse che era un tipo di incontro che organizzava spesso in situazioni come la nostra e i risultati erano quasi sempre ottimi, perché la maggior parte delle volte è semplicemente un problema di comunicazione tra le due parti. Mi sentii molto più sollevata.
Conoscevo la famiglia di Dan da molti anni. Era ovvio fin dal principio del nostro rapporto che la mia e la sua erano molto diverse. Io, con i miei attaccamenti quasi morbosi a mamma e sorelle, ma anche a zii e a cugini, venivo da un’esperienza diversa da quella di Dan, che aveva parenti meno espansivi. I suoi genitori, Thelma ed Ercole, sono sempre stati gentili e generosi con me e fin dal primo giorno mi hanno accolta a braccia aperte. Suo padre, romano ma in America da quando aveva ventun anni, era contento che suo figlio avesse sposato un’italiana. E anche sua madre mi ha sempre voluto bene.
Eppure dal principio del nostro rapporto ho avuto la sensazione che ci fosse una distanza emotiva tra me e loro, mi sembrava che ai genitori di Dan andasse bene mantenere sempre un livello di discorso superficiale, senza...