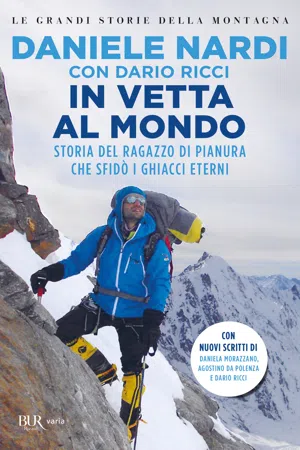«Solo pochi istanti, che le bestie sono stanche e hanno bisogno di riposare.» Il dialetto di Pietro mi resta nella penna, ma il suo accento inconfondibile è ancora vivo nel mio orecchio. È metà pomeriggio di un giovedì d’inizio dicembre. Partendo da Milano, di treno in treno ho raggiunto Sezze, in provincia di Latina, per incontrare Daniele Nardi, impegnato negli allenamenti ma soprattutto nell’organizzazione del cargo1 con tutto il necessario per la spedizione, da inviare al più presto in Pakistan.
Saliamo in macchina e cominciamo a chiacchierare fitto, ma ho subito chiaro quale obiettivo la mia guida abbia in mente: ha già puntato lo sguardo verso i Monti Lepini. Si va in montagna, la montagna di casa. Non penseresti mai che a partire da queste cime qualcuno sia riuscito a immaginarsi sulla vetta dell’Everest, del K2 o del Broad Peak. L’Everest dei Monti Lepini è il Semprevisa: 1536 metri sul livello del mare fatti di boschi e rocce calcaree, scavate e divorate da sorgenti carsiche. Non è un caso che c’imbattiamo in Pietro e i suoi muli proprio vicino a una sorgente. Soffia un vento freddo e l’orologio fagocita rapidamente le ultime luci del pomeriggio, ma Pietro, appena c’incrocia, ferma i suoi ciuchini, con le zampe quasi piegate dalle fascine di legna che hanno sulla soma, e li mette in posa per qualche momento, per qualche foto. Neanche il tempo di salutarli, Pietro e i suoi muli, che Daniele con un paio di balzi è già alla base del suo sentiero d’allenamento preferito: «Lo vedi, laggiù? Guarda bene: pochi passi ed ecco il sentiero che porta fino alla vetta. È un terreno molto allenante, quasi mille metri di dislivello: dai 550 della Fonte delle Cornette, che è proprio quella fontana laggiù, a una decina di metri da noi, fino alla vetta, a quota 1536. E sempre da quel punto ecco che parte la strada sterrata. Fino ai 1200 metri di Campo Rosello in tutto sono una decina di chilometri, e altrettanti a riscendere a valle: quando vengo a farmi una corsetta, alla fine mi faccio quasi una mezza maratona!». Sorride. E con gli occhi è in ricerca perenne di qualcosa, qualcuno. Di più, di un segno, un significato, una traccia. Immerso nelle sue montagne sembra un fauno, la mitologica divinità romana protettrice di selve e campagne, pienamente compenetrato dalla natura che lo circonda, impegnato a leggere e a decifrare gli indizi del bosco e della montagna. «Quando, a inizio primavera, quassù cominciano a soffiare i primi venti tiepidi, quasi puoi sentire il crepitio della neve che inizia a sciogliersi e lascia spazio all’erba che si fa largo verso la superficie» dice Daniele, come se m’avesse letto nel pensiero. Saperla ascoltare, la montagna, forse è il primo passo per provare a capirla, scalarla, domarla.
Piet Mondrian, Dune vicino a Domburg, 1910 circa. Di fronte ai Lepini che mi si paravano davanti, mentre provavo a inseguire con gli occhi i punti e le indicazioni che mi davano le dita e la voce di Daniele, m’è venuto in mente quel capolavoro del grande artista olandese, emblema del suo periodo espressionista, ora conservato al Gemeentemuseum dell’Aia. Se provi a socchiudere gli occhi, il verde dei boschi che s’arrampicano sui Lepini scolora, gli alberi si fondono in un’unica macchia estesa, a disegnare una forma geometrica irregolare, ma perfetta in sé, che s’incastra in modo quasi meccanico, automatico, con il grigio calcareo delle pareti rocciose. Sembra di vedere la trama quasi scolpita da Mondrian un secolo fa da tutt’altra parte del mondo.
Daniele quelle rocce, quelle pareti, le conosce tutte, una a una, palmo a palmo. «La vedi, laggiù, quella cittadina arroccata in cima al monte? È Sermoneta. E quella parete che sale proprio sotto al paese? Lì ho cominciato ad arrampicare: arrampicata sportiva, sì, con le mani, una corda di sicurezza, tanto coraggio e poco altro... Beata incoscienza! Ma poi ho capito che volevo fare altro: volevo scalare, volevo la cima, la vetta. Guarda di là, sulla sinistra, quello è Bassiano, un altro borgo di neppure duemila abitanti che, insieme a Sermoneta, mi è molto vicino nel supportare i progetti locali di arrampicata sportiva. Subito sotto puoi vedere un’altra parete buona per arrampicare. Qui sui Lepini di certo non ci sono le pareti che trovi in Valle d’Aosta, sul Monte Bianco o sulle Dolomiti, ma c’è molto da poter arrampicare e una buona comunità di arrampicatori e scalatori. E ci sono anche dei grandi chiodatori, che queste pareti le studiano, palmo dopo palmo, le attrezzano e le preparano, rendendole sicure. Un nome su tutti è senz’altro quello di Stefano Milani: lui le falesie dei Monti Lepini le conosce centimetro per centimetro, ha chiodato le Placche Rosse, quella lunga fascia calcarea che vedi proprio là in alto, sotto il paesino di Norma; e poi lo Scoglio dell’Araguna, Gecolandia, la Grotta del Pipistrello, la Gola dei Venti e il “nostro” Cerro Torre, una bella paretina che un po’ assomiglia alla leggendaria cima della Patagonia!»
Dall’ardore con cui le descrive capisci subito che Daniele, delle sue montagne, della sua terra, si sente un po’ un ambasciatore nel mondo e in alta quota. Lo anima l’orgoglio per quanto fatto partendo dalla «conquista» della vetta del Semprevisa, mescolato e impastato, però, dal desiderio di vedere unanimemente riconosciuto il valore delle sue imprese. E non solo sugli Ottomila del mondo. «Pensi sia facile partire da qui, da Sezze, vicino Latina, tra l’Agro Pontino e la Ciociaria, per arrivare in cima all’Everest o al K2? E poi ricordati: nessuno è profeta in patria.» La frase rimane sospesa nella brezza che comincia a soffiare da nord. Il sole affonda tra i monti. A valle, Sezze accende le sue luci. Da qui si domina tutto il gruppo dei Lepini, il gruppo degli Ernici, le Paludi Pontine. All’orizzonte c’è il Circeo, poi il mare e là in fondo l’isola di Ventotene. E a guardare da quassù i confini della terra perdersi nel mare provi in cuor tuo pace e beatitudine.
«Qui ci sono i ruderi delle capanne dei miei nonni paterni, c’è persino una valle dedicata a noi Nardi. Su certe pareti nascoste di queste zone, da solo, lontano dallo sguardo di tutti, ho cominciato a fare alpinismo. La mia prima grande impresa è stata la traversata da Sezze a Carpineto superando il Semprevisa: l’annunciai a 13 anni a mio padre e a mio nonno con tono trionfalistico: ma che freddo quella notte, quassù in cima!»
E anche la via non è poi così banale. Recitano i manuali: «Da Sezze, per compiere l’ascensione al Semprevisa, conviene seguire la valle di Suso, che forma un bacino chiuso a est dal monte, a sud da una serie di colline che separano la valle Pontina, e a nord dai monti di Bassiano, che connettono al sistema del Semprevisa la catena di piccole colline di fronte l’Agro Pontino. Sono circa sei ore di cammino». E poi bisogna scendere verso Carpineto. Un bel trekking, non c’è che dire.
«Tante volte» continua Daniele «ho nascosto le mie salite: erano cose mie, personali, profonde. Senza volerlo e forse senza saperlo ero attratto da quell’indicibile forza dell’avventura, dell’essere appesi al nulla. Non ti parlo di arrampicata sportiva, di quella protetta e sicura dalle cadute. Quella dove il trapano perfora lasciando segni indelebili di acciaio sulla roccia, che attenuano le cadute, e dove il coraggio è sostenuto dalla sicurezza. Parlo del salire semplice con le proprie forze su pareti aggettanti, dove la sicurezza di volta in volta devi cercartela tu, posizionando degli arnesi, friend e nut,2 che poi però togli dalla parete e che non sempre sono sicuri. Sento la responsabilità verso i ragazzi di Mountain Freedom3 e certe volte mi trattengo dal raccontare queste cose: l’arrampicata sportiva è sicura, invece insegnare l’alpinismo è tutta un’altra cosa.»
«Insomma, non basta essere bravi ad arrampicare per immaginarsi o sognarsi alpinisti?» lo interrompo.
«Mi stai seguendo sul sentiero giusto!» sorride. «Anche io da ragazzo, man mano che le mie capacità aumentavano, sono stato attratto da quel senso di avventura estrema che ti dà l’alpinismo senza supporto di sicurezze. Insomma, dopo aver fatto il corso di arrampicata sportiva e aver aperto le mie prime piccole vie in solitaria autoassicurato sulle pareti della valle dell’Acqua della Chiesa, ho cominciato a provare il brivido delle scalate senza corda. A ripensarci oggi, ne sono passati tanti di anni e i gradi che scalavo non erano altissimi, ma sfioravano quella scala del “sesto grado dolomitico” di cui la storia alpinistica ha tanto parlato per anni. Oggi chi scala in free-solo4 riesce a fare molto di più. Ma in quel momento per me era la porta verso l’alpinismo. Uno dei miei allenamenti preferiti consisteva nel partire da casa, da Sezze, correre in scarpe da ginnastica e pantaloncini fino all’inizio del sentiero che portava alla valle Ciccopane del versante sud, quello setino, dal monte Semprevisa, circa 12 chilometri, inerpicarmi per tracce di sentiero dove nel passato i pastori salivano ai pascoli per arrivare fino alla vallata. Al centro della valle c’è una salita di arrampicata sportiva chiodata, ma per modo di dire: pensa che al posto dell’acciaio si usavano le catenelle dello sciacquone del bagno! Per ben tre salti, come fossimo in una gola, tre salti per un totale di novanta metri, che portano in un anfiteatro e poi ancora su una cresta che si protrae fino al belvedere di Colobrella, a 1230 metri. I gradi delle tre salite, diversi tra loro nella scala dell’Unione internazionale delle associazioni alpinistiche (Uiaa) citerebbero il “sesto grado inferiore” e le note “placche tecniche fino a sfiorare il sesto grado”. Io salivo leggero con le scarpe da ginnastica! Metro dopo metro sentivo salire la tensione sotto i piedi, nello stomaco, la mente a volte tendeva a offuscarsi per lasciare spazio alla paura. È lì che ho cominciato a imparare a gestire le mie emozioni in montagna. Quando senti la scarpetta scivolare su quelle placche appoggiate e lisce e tu che ti protendi verso l’appiglio che viene ancora dopo. Cerchi di spingere sui piedi ma quelli non ce la fanno a sostenere il grip necessario a proseguire. Fai per scivolare e poi ti tiri sull’appiglio successivo con la sola forza delle braccia. In particolare c’era un passaggio del secondo risalto che mi metteva sempre in difficoltà. La parete si faceva verticale, gli appoggi tutti obliqui e sfuggenti e dovevo essere dinamico per appigliarmi al bordo d’uscita del risalto. Sotto di me trenta metri di parete, il vuoto, la paura che mi tirava in basso. Poi, superati i tre risalti rocciosi, arrampicando si apre un anfiteatro con una piccola torre contornata al centro da alberi. Scalavo anche quella più facile e poi di corsa su verso Colobrella, per poi fare tutta la traversata verso la vetta e infine giù al paese di Bassiano e ancora di corsa fino a casa per un totale di 40 chilometri di corsa e 1500 metri di dislivello. Non ricordo quanto impiegassi ma certo più di una mezza giornata. Per tutti noi alpinisti questi sono passaggi obbligati. Chi più chi meno, abbiamo fatto i conti con la corda lunga sotto i piedi, senza protezioni, appesi alle nostre capacità di sostenere le difficoltà e la paura. E ci sono tanti altri momenti in cui ho dovuto fare i conti con il vuoto.
«Sai che a Sezze c’è una croce metallica alta circa 60 metri? E sai che – non dovrei dirlo! – appena terminato il corso di arrampicata non ho saputo resistere... Eravamo io e Pietro. Quando ho visto da sotto – di notte per non farci scoprire e d’inverno per rendere il tutto più entusiasmante – quello spigolo che saliva potente ed elegante verso il cielo, non ho saputo resistere. Mentre Pietro saliva all’interno della croce fra i diversi assi, io stavo affrontando lo spigolo, senza corda, senza protezioni, cercando di far aderire le suole delle scarpe da ginnastica ai bulloni che uscivano sui due lati ad angolo dello spigolo. Sotto di me, metro dopo metro, si costruiva il mio alpinismo, il mio desiderio d’avventura, la voglia di mettermi in gioco e scoprire e affrontare le paure. Non arrivammo in vetta, ci fermammo lì all’incrocio delle assi della croce, poi verso l’esterno, verso la Pianura Pontina e il Mar Tirreno. Sembrava d’avere tutta quella manciata di centinaia di metri della collina di Sezze sotto i piedi!
«Allora, come oggi, c’era il desiderio di battere piste nuove, inesplorate. Fu proprio quella voglia a spingermi a tentare la salita di una parete alta 25 metri nei pressi della sorgente dell’Acqua della Chiesa. Arrivai in un punto dove non ero stato capace di valutare lo spessore della fessura che si stringeva e diventava cieca. Le mani tremavano, le gambe non tenevano lo sforzo. Passai il mazzo dei nut nella bocca, tra i denti, per poter scegliere il migliore da fissare nella fessura. Ero solo, in autoassicurazione, con 22 metri sotto i piedi; poco più sopra di me l’albero dove poter fissare un cordino e scendere. Tra me e la fine un singolo passaggio di arrampicata, i denti che tremano e i nut che mi scivolano dalle labbra e si perdono nel vuoto, insieme alla mia speranza! Nello sconforto e mentre il panico di cadere a terra e sfracellarmi mi assaliva, solo allora, solo in quel momento, tirando fuori la calma e il coraggio, mi ricordai il racconto di un amico che mi disse che una volta s’usava annodare dei cordini e strozzarli nelle fessure al posto dei nut. Riuscii a togliermi un cordino dall’imbrago, fare un doppio nodo, strozzarlo nella fessura, metterlo in tensione e poi con molta cautela calarmi dalla parete. Fu la prima volta che rinunciai ad arrivare in vetta. Riuscii a telefonare a mio padre e, trascorsa la notte all’addiaccio, il giorno dopo mi raggiunse in parete. Una zona che lui conosceva molto bene, la zona dove da ragazzino mio nonno Luigi lo spediva a pascolare le pecore... Il tempo di spiegargli come mettersi in sicurezza e riuscii a completare la salita e a recuperare tutta la mia preziosa attrezzatura. Quel giorno con mio padre, in realtà, aprii la mia prima via alpinistica. Ma all’epoca non ero affatto consapevole, era per me il modo di scoprirmi, di vivere la natura e d’essere libero. Certo, a ripensarci oggi mi viene da ridere rispetto a ciò che provo a fare in Himalaya, ma per me furono due giornate indimenticabili. Due giorni interi per aprire 25 metri di arrampicata su roccia quando oggi con lo stile alpino e la preparazione tecnica che ho raggiunto ne faccio 1000 in una giornata! Ne è passato di tempo! Se ne sono fatti di metri in verticale, che ne dici?»
La brezza s’è presto trasformata in vento gelido che mi trapana le tempie e non è certo il compagno ideale per una conversazione all’aperto tra amici. A vederci così, camminare fianco a fianco, Daniele e io, non c’è rischio di sbagliare su chi sia lo scalatore. Lui saltella allegramente da una roccia a un’altra e m’indica uno dopo l’altro sentieri, vie d’ascesa, punti d’osservazione, leggendo da esperto topografo ogni vallata e ansa dei monti che si distendono ai nostri piedi; il tutto indossando poco più che una felpa e un leggero giubbotto. Io, invece, mi sono arreso fin da subito al repentino calo della temperatura, trovando consolazione e soccorso in sciarpa, giacca a vento e guanti di lana, che però complicano maledettamente la duplice fatica di tenere in mano bloc-notes, penna (con inchiostro ormai congelato: disdetta!) e registratore digitale. Del resto, che anche in cima al Semprevisa potesse far freddo l’avevo intuito non appena Daniele aveva parcheggiato la sua auto alla fine della strada sterrata, che culmina ora nel belvedere dove c’è il piccolo rifugio che mi sta facendo visitare. Il vascone a fianco del rifugio, che raccoglie l’acqua per gli animali portati quassù a pascolare, è completamente ghiacciato, e non dubito che quella lastra possa ben sostenere il peso di un’esperta pattinatrice, o magari ospitare le evoluzioni di due adepti dell’hockey su ghiaccio (sui Lepini? Certo sarebbe strano trovarne, ma del resto non lo è pure trovarci uno scalatore estremo?). «A 13-14 anni venivo spessissimo qui a bivaccare di notte. Un fornelletto, magari un sacco a pelo e una piccola tenda, e tutto mi sembrava magico, infinito. Ogni volta che venivo quassù era una piccola grande avventura. Guarda quella radura: lì mio nonno aveva le sue capanne per il pascolo. Io venivo qui a trovarlo, certo, ma da qui a dire che facevo il pastore ce ne vuole! Va bene che vengo dai Monti Lepini, ma non esageriamo, per favore!»
Quanto tempo, quanta strada, quanta roccia è passata da quei giorni. «Ora con i ragazzi dell’associazione siamo riusciti a ottenere la gestione di questo rifugio. Voglio farne un punto di ritrovo in quota qui al Semprevisa. È piccolo ma accogliente: a lavori finiti ci si potrà stare in dodici, e il caminetto ci scalderà tutti!»
S’è fatto buio. Riscendiamo a valle. Un ultimo sguardo all’orizzonte. Socchiudo gli occhi, sferzati dal vento. Sembra già di vederlo, lì, davanti a noi, il Nanga Parbat.