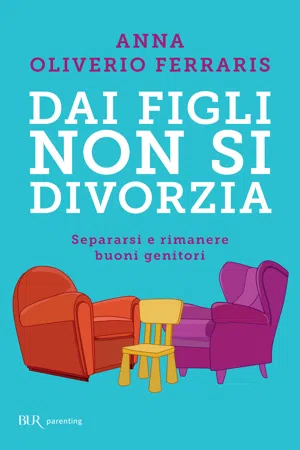![]()
[1]
PRIMA DELLA SEPARAZIONE
Tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo.
LEV TOLSTOJ
Finché resta unita, la famiglia è un sistema alla cui vita partecipano tutti i suoi membri. Le emozioni e i sentimenti degli uni influiscono su quelli degli altri, sulle loro scelte e i loro comportamenti, perché comuni sono le esperienze di vita, le memorie, il linguaggio. Non occorrono lunghi discorsi o spiegazioni per capire se papà e mamma sono di cattivo umore, tristi o arrabbiati. È facile comprendere se hanno litigato, se si tengono il muso o se invece stanno per fare la pace. Si vive negli stessi spazi, si coordinano gli orari, si condividono le abitudini, si è testimoni involontari di ciò che accade. Questa condivisione naturale di tempi, spazi, esperienze, emozioni, linguaggio crea, giorno dopo giorno, anno dopo anno, un intreccio fitto di relazioni e di eventi significativi che è alla base di quella intimità che è massima in famiglia, ma che può esistere anche in altri contesti, sia pure in forme meno intense, come la scuola, il luogo di lavoro, il parco giochi, la palestra. È difficile perciò, in famiglia, fingere di non vedere e di non sentire, così come è difficile sottrarsi allo sguardo dei propri congiunti anche quando servirebbe un po’ di privacy.
Spettatori impotenti
Così come i genitori sono testimoni dei conflitti dei figli, allo stesso modo i figli sono testimoni dei conflitti dei genitori. La differenza tra queste due condizioni sta nel fatto che mentre i genitori si sentono autorizzati a intervenire nei litigi dei figli, questi ultimi, per la posizione che occupano all’interno del sistema famiglia, si sentono assai meno autorizzati a farlo con i genitori. Può accadere che intervengano, quando la situazione degenera, ma in questo caso essi devono superare una barriera psicologica che ha radici negli anni infantili e che li porta a pensare che i saggi, i maturi, i responsabili siano gli adulti. Sono gli adulti che hanno formato la famiglia, che l’hanno voluta e che, per definizione, dovrebbero desiderare di tenerla unita. I figli sono arrivati dopo, quando la famiglia era ormai formata, e poi una prerogativa dei bambini è proprio quella di essere spensierati, di affidarsi alle decisioni dei genitori. In questo, l’età è una variabile rilevante perché più un figlio è piccolo meno sente di poter avere parte nelle decisioni e negli scontri dei grandi.
Le situazioni variano molto da una famiglia all’altra: in alcune di quelle che approderanno alla divisione i genitori litigano da sempre in modo esplicito e qualche volta fanno anche delle prove di separazione per periodi più o meno lunghi; in altre i litigi non sono frequenti; in altre ancora non ci sono esplosioni di ostilità ma incomprensioni su questioni di fondo, dissensi larvati, forme “fredde” di lotta di cui non sempre i figli colgono la reale portata. Così, se in alcune famiglie non è difficile maturare la convinzione che prima o poi mamma e papà si separeranno, in altre invece non è chiaro che cosa stia veramente accadendo né se si tratta di problemi passeggeri o duraturi.
«Da quando iniziano i miei ricordi ci sono sempre stati litigi» spiega Margherita. «Né mio padre né mia madre sono mai venuti a dirmi perché litigavano. Volevo chiederlo ma ero piccola e avevo paura. Sapevo però che un giorno si sarebbero separati, perché era una minaccia che mia madre faceva spesso. Lui alzava le mani e poi aveva altre donne (questo l’ho saputo dopo). Mia madre ha resistito fino a quando mio padre non ha iniziato a picchiare anche noi, me e i miei fratelli: a quel punto ha detto “basta”.»
Per Salvatore invece i segnali non erano altrettanto chiari: «C’era un clima da guerra fredda fin da quando frequentavo le elementari. Col passare del tempo avevano quasi smesso di parlarsi e quando erano costretti a farlo usavano un tono bizzarro per persone che vivono nella stessa casa e dormono nello stesso letto. Io però non pensavo alla separazione perché con noi erano molto affettuosi, sempre gentili e anche molto indulgenti. Il mio ragionamento, allora, era il seguente: loro non vanno d’accordo, ok, però ci vogliono bene e quindi non si separeranno mai. E invece…».
Anche per Gilberto non è stato facile capire che cosa stava accadendo a mamma e papà, che di notte litigavano e di giorno davano l’impressione di essere una coppia serena. «C’è stata molta allegria in famiglia fino a un certo punto. Mio padre è un tipo spiritoso che riesce a far ridere anche i musoni. Poi però i rapporti tra loro si sono deteriorati perché mio padre era frustrato per non essere riuscito nella vita e mia madre doveva occuparsi di tutto da sola. Loro cercavano di non farmi sapere nulla e io reggevo il gioco, anche se intuivo che le cose non erano più come prima. Cercavo di negarlo a me stesso, ma la verità era davanti agli occhi ogni giorno di più. Di notte mi svegliavo di soprassalto perché sentivo urlare, sbattere porte; ma per non soffrire facevo finta che non stesse accadendo nulla, mettevo la testa sotto le coperte e così le urla sparivano. Mia madre piangeva e mio padre gridava, insomma una vera tragedia! Ma la cosa più tragica, secondo me, è che la mattina quando mi svegliavo trovavo i miei in cucina che ridevano e scherzavano e così avevo la sensazione di aver fatto un brutto sogno. Poi un giorno, avevo sette anni, mia madre mi ha portato a vedere una nuova casa e ricordo che le chiesi se saremmo andati a vivere lì tutti insieme. Lei non disse né sì né no, ma soltanto che trasferendoci in quel luogo saremmo stati vicino a nonna, sua madre, e avremmo pagato meno d’affitto. Però io non ero soddisfatto della risposta e insistetti a chiederle se papà sarebbe venuto con noi, fino a che mi disse un “no” secco e freddo! Mi ricordo che mi si gelò il sangue perché quello che temevo si stava avverando: capii che una volta trasferiti non ci sarebbe più stata speranza di poter vivere tutti e tre insieme.»
I figli avvertono che qualcosa non funziona nella coppia; ma se i grandi non ne parlano possono essere insicuri della validità delle loro percezioni e incapaci di fare previsioni. Possono notare che papà e mamma non sono affettuosi tra loro, che usano toni duri o irritati, che non escono mai insieme, che evitano di rimanere soli o non dormono nella stessa stanza; ma non avendo mai vissuto un’esperienza di coppia e non potendo fare paragoni con altre famiglie, possono ritenere che quei comportamenti rientrino nella norma; tanto più che, per la propria sicurezza, essi desiderano che i genitori continuino a restare insieme. «Non ti dicono ancora nulla ma tu sai che qualcosa sta cambiando» spiega Mario. «Non vieni incluso nelle decisioni, c’è tensione, avverti che devi lasciare un po’ in pace i tuoi genitori che vedi litigare, tuo padre sta fuori più del tempo previsto, c’è gente che viene a casa a parlare con tua madre e si chiudono in una stanza. Non sai però ancora come andrà a finire. Tu non c’entri. Tu puoi soltanto stare a guardare. Quando mia madre mi parlò e usò la parola divorzio, ormai era tutto fatto.»
La difficoltà che incontrano i figli nel comprendere le dinamiche emotive della coppia emerge anche dalla testimonianza di Emma. «A un certo punto ho avuto l’impressione che qualcosa stesse cambiando perché ho cominciato a fare solo con mio padre le cose che prima facevo anche con mia madre: andare a cavallo, giocare a tennis, gite in bicicletta. Nessuno però mi ha dato delle spiegazioni e io non osavo fare domande. Più tardi ho capito che non andavano più d’accordo come un tempo. Non immaginavo però che si sarebbero separati. Sapevo che molte coppie vivono insieme anche se non vanno d’accordo. Ho saputo della loro decisione una sera quando li ho sorpresi in salotto a parlare degli alimenti che mio padre avrebbe dovuto dare a me e a mia madre dopo la separazione. Avevo nove anni. Il motivo per cui si sono separati l’ho saputo molto più tardi.»
Ci sono infine casi in cui la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: i figli non si accorgono di nulla, non sospettano nulla fino a quando i genitori non comunicano che si stanno separando. È questo il caso di Bruno. «Non ci sono stati segni premonitori o, almeno, io non me ne accorsi. Eravamo una famiglia normale. C’era qualche litigio, ma niente di più. Comunque io allora non conoscevo altre situazioni e per me quella che vivevo era più che normale. Ho sempre pensato che stavamo bene tutti insieme.»
Scheda 2
Cifre e dati
Negli ultimi anni c’è stato un incremento delle separazioni e delle rotture definitive tra coniugi. Secondo l’ultima relazione del procuratore generale di Cassazione, nel 2003 c’è stata una separazione ogni quattro matrimoni, un divorzio ogni nove.
Le coppie che si sciolgono lo fanno mediamente dopo tredici anni, sono in prevalenza quelle che risiedono nelle regioni centrosettentrionali con Liguria e Piemonte in testa, mentre i tassi di separazione nel Mezzogiorno sono la metà. C’è però un incremento in Campania e in Calabria.
| Separazioni | Divorzi |
| 1991 | 44.929 | 27.350 |
| 1996 | 57.538 | 32.717 |
| 1998 | 62.737 | 33.510 |
| 2000 | 71.969 | 37.537 |
| 2003* | 109.373 | 51.682 |
Non tutte le separazioni legali si convertono in divorzi: delle 29.462 separazioni concesse in Italia nel 1980, entro il 2000 se ne sono concluse in divorzio circa il 70 per cento. Entro lo stesso anno si sono concluse in divorzio circa il 60 per cento delle separazioni del 1991.
Figli. Se si considerano solamente i figli minori di diciotto anni, le separazioni e i divorzi che ne coinvolgono almeno uno sono (nel 2000) rispettivamente 35.173 (48,9 per cento) e 13.631 (36,3 per cento). Se invece si considerano anche i figli di età superiore ai diciotto anni, le cifre sono: 82.594 (separazione) e 35.050 (divorzio).
L’affidamento dei minori alla madre è predominante. Nel 2000 sono stati affidati esclusivamente alla madre l’86,7 per cento dei minorenni a seguito di una separazione e l’86 per cento a seguito di un divorzio. L’affidamento congiunto o alternato al padre e alla madre è ancora poco diffuso nel nostro Paese (8 per cento separazioni, 6,8 per cento divorzi), tuttavia il ricorso a questo tipo di affido è in aumento. Molto rari in ogni parte d’Italia risultano gli affidamenti ad altri soggetti, quali familiari e istituti per minorenni.
Le cause della separazione
• Matrimoni contratti in età precoce
• Differenze culturali
• Violenze fisiche e psicologiche
• Stress, perdita di lavoro, lutto
• Bisogni insoddisfatti dell’uno o dell’altro coniuge
Il testimone
A volte, come nel caso seguente, i figli sono testimoni involontari di eventi cruciali per la coppia che possono creare situazioni di forte tensione. Francesco aveva undici anni quando i suoi genitori si sono divisi, ma negli anni precedenti era stato suo malgrado al centro di vicende scabrose e di difficile elaborazione per un bambino.
«Mia madre dovette partire immediatamente perché mia nonna stava male. Rimase lontano due o tre settimane. Io e mio fratello restammo con mio padre perché era periodo di scuola. Avevo all’incirca sette anni. Nella casa in cui abitavamo la mia cameretta era accanto alla camera dei genitori. Una notte mi sono alzato per andare in bagno, nel frattempo ho voluto assicurarmi che mio padre fosse a casa, perciò mi sono affacciato alla sua camera e ho visto che al suo fianco nel letto c’era un’altra donna! Difficile spiegare come mi sono sentito. Ero disorientato, però ero certo che quella donna non fosse mia madre. Quella notte capii perché i miei genitori litigavano spesso e perché mamma diceva di non potersi fidare di papà. Nei giorni successivi continuai a ripensare a quello che avevo visto. A scuola ero distratto e a casa non riuscivo a fare i compiti. Avevo bisogno di parlare con qualcuno. Mi sentivo tradito da mio padre. Aveva usato la nostra casa per i suoi comodi senza preoccuparsi dei figli. E poi aveva permesso a un’altra donna di dormire nel posto di mia madre mentre, tra l’altro, lei stava passando un periodo difficile. Quando la nonna si riprese e mamma tornò a casa io non sapevo che fare. Ero molto confuso. Avrei voluto dirle ciò che sapevo di quella notte ma non volevo farla soffrire. Un giorno che mio padre la trattò male dissi finalmente, in presenza di tutti e due, quello che avevo visto. Mamma si infuriò con mio padre ma lui, con aria indifferente e strafottente, negò tutto quanto e disse che io ero un bugiardo o me lo ero sognato. Mamma era innamorata di mio padre perciò, quella volta, preferì credere che me lo fossi sognato. Continuarono a stare insieme per alcuni anni anche se lui a casa ci veniva soltanto per dormire, generalmente tardi, la notte. In seguito mia madre dovette tornare di nuovo al suo paese e trattenersi a lungo per accudire mia nonna che alla fine morì. In quel periodo mio padre, con la scusa del lavoro mandò me e mio fratello a casa di sua sorella, mia zia, che non aveva figli e poteva occuparsi di noi. Con lei viveva suo marito, che con me era particolarmente affettuoso e gentile, mi aiutava nei compiti, mi faceva dei regali; insomma, per farla breve, un giorno questo zio cercò di abusare di me. Improvvisamente da gentile e affettuoso diventò violento. Io riuscii a sottrarmi ma ne rimasi sconvolto. Riferii tutto a mio padre, la sera stessa, ma lui, come aveva già fatto una volta, mi sgridò dicendomi di smetterla di inventarmi le cose e di guardarmi bene dall’andare a raccontare in giro quelle frottole. Io ero confuso e arrabbiato, non capivo perché lui non mi credesse. Che vantaggio avrei avuto a inventarmi una cosa del genere? Da mia zia non volevo più stare, ma non mi sentivo sicuro nemmeno con mio padre che mi accusava di essere un bugiardo. Quando finalmente tornò mia madre le raccontai la vicenda dello zio. Lei capì che non mi stavo inventando le cose. Dopo qualche tempo si sono separati. Forse è stato questo a far precipitare la situazione o forse no, non l’ho mai capito. Mio padre se ne è andato sbattendo la porta e in seguito l’ho rivisto qualche volta ma in situazioni di grande tensione e grandi silenzi. Ancora adesso, quando ripenso a quei momenti e mi chiedo se sono stato io a causare la separazione, non so darmi una risposta.»
L’adulto che nega o minimizza o addirittura accusa il figlio di mentire, quando invece questi dice la verità, lo getta in uno stato confusionale. Un bambino sa che gli adulti hanno un potere assai superiore al suo e perde fiducia nella possibilità di comunicare, di essere creduto, di riuscire a confidarsi. Inoltre, per molto tempo, può continuare ad arrovellarsi intorno a quello che per lui è un problema senza soluzione. I bambini, come i grandi, hanno bisogno di cogliere i nessi che legano tra loro gli eventi significativi della propria vita, di dare un senso alle proprie esperienze e di ottenere conferme e chiarimenti su ciò che vedono, sentono o intuiscono, specialmente quando le loro intuizioni e sensazioni li riguardano direttamente.
Capire a posteriori
Quando la divisione è avvenuta nei primi anni di vita, i figli non ne hanno alcun ricordo o ne hanno uno confuso, anche se ciò non significa che eventuali stress – provocati dai litigi e soprattutto dalla separazione dalle figure di attaccamento – non abbiano inciso sul loro sviluppo. Se il loro bisogno di attaccamento era soddisfatto, se il clima in casa era sereno, a livello cosciente molti figli non hanno avuto la percezione di un cambiamento di rotta; tutto ciò che ricordano lo hanno appreso dai racconti dei parenti.
Un bambino piccolo, che non abbia ancora alle spalle una storia familiare, non può paragonare il “prima” con il “dopo” ed è portato a considerare normale la condizione in cui vive, specialmente se non ci sono tensioni e se mantiene un rapporto continuativo e sereno con una delle sue figure di attaccamento principali. «Della separazione non mi sono accorta perché avevo tre anni quando è avvenuta» racconta Flavia. «La mamma si è risposata e io mi sono affezionata al suo nuovo compagno, che mi ha aiutata molto. Per me la separazione non è mai stata un problema, avevo il doppio di tutto: doppie vacanze, doppi regali, tre coppie di nonni che mi ricoprivano di attenzioni.»
Abitare con la mamma e incontrare il papà nei fine settimana è una condizione che può essere considerata normale da un bambino i cui genitori si sono separati quando aveva uno o due anni, in quanto lui ha conosciuto soltanto quel tipo di vita familiare. Ma può essere considerata una condizione normale anche nel caso in cui la separazione è avvenuta quando aveva cinque o sei anni se, per esempio, il padre non partecipava da tempo alla vita familiare o trascorreva lunghi periodi lontano da casa. È ciò che ha spiegato Riccardo.
«Si sono separati quando avevo cinque anni. Da piccolo non sentivo la mancanza di mio padre perché ho vissuto sempre con mia madre. Abitavo con i nonni e due zii ed ero circondato da molti cugini. Ero felice e non avevo la percezione di una mancanza. Sapevo di avere un fratello che viveva con quello che io chiamavo “il padre di mio fratello”, ossia mio padre, che però vedevo di rado. Per anni mio padre è stata una figura insignificante per me. Più tardi l’ho frequentato un po’ di più perché frequentavo mio fratello, ma lui è sempre rimasto un estraneo, una persona con cui non avevo confidenza. Mi sono reso conto che, nonostante molti bambini vivessero con il papà, oltre che con la mamma, ce n’erano anche alcuni come me, con i genitori divisi. Per me era talmente normale essere figlio di divorziati che lo dicevo tranquillamente a chiunque.»
Una volta cresciuto, un figlio può disporre, a posteriori, di una versione più articolata dei fatti e poco per volta darsi delle spiegazioni. Ascolta i discorsi dei parenti, comprende meglio le situazioni, fa confronti e via via aggiunge nuove tessere al mosaico. È come se di una fotografia all’inizio vedesse soltanto una piccola zona. Col passare del tempo l’area visibile si allarga, compaiono altri settori e il dettaglio iniziale si inserisce in un nuovo contesto che ne trasforma il significato. Quando finalmente tutta l’immagine è visibile, il quadro che emerge è un altro ancora e il giudizio va così nuovamente riformulato. Il racconto che segue esemplifica bene questo processo di approssimazione progressiva alla comprensione definitiva; un processo che, nel caso di Dino, è durato all’incirca dodici anni.
«Avevo quattro anni quando i miei genitori si sono separati. Di quel periodo ricordo soltanto che mamma era stata ricoverata in clinica. Le decisioni le pigliavano loro, i grandi, e per un bambino di quell’età ciò che fanno gli adulti è legge. Non conoscevo la gravità della malattia ed ero convinto che la mamma sarebbe tornata a casa, anche se doveva stare lontano da noi molto tempo (così avevano detto i nonni). Sentivo la sua mancanza, soprattutto la sera, perché lei mi aveva sempre dato il bacio della buona notte. Allora ero troppo piccolo per capire, ma con gli anni mi resi conto di come erano andate veramente le cose e, sebbene comprendessi i motivi che avevano portato al ricovero, non riuscivo ad accettare che mio padre si fosse separato da mia madre solo perché era malata. Quando ho capito cosa aveva fatto mio padre con il consenso dei miei nonni materni, ho perso fiducia in lui e nei nonni. Mio padre si era risposato e il...