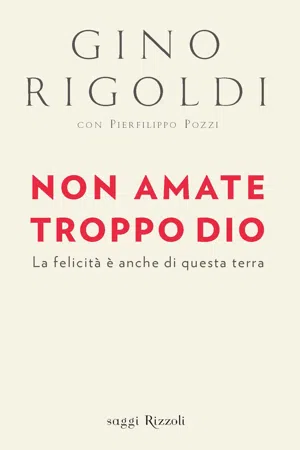![]()
Bisogno d’amore
A casa mia, come in ogni famiglia, la lista dei bisogni è lunga e ricca. Abdel ha bisogno del motorino per andare al lavoro, perché con i mezzi pubblici ci mette due ore. Naturalmente non ha il patentino, quindi ha bisogno anche di quello. Rudi ha bisogno di sapere l’inglese, perché prima o poi vuole andare a fare il cameriere a Londra. Vito ha bisogno di una ragazza, altrimenti continueranno a prenderlo in giro, e Alim ha bisogno di musica, perché dice che il silenzio gli fa venire strani pensieri. C’è poi la lista dei bisogni ricorrenti, quotidiani: magliette e mutande, rasoi, la frutta, un nuovo materasso, un viaggio per andare a salutare una sorella, contanti per arrivare in città, sigarette… L’ampio concetto di «bisogno» include merci, gesti e persone. Include tutto ciò che ci manca e che, a torto o a ragione, riteniamo desiderabile, seppure con gradi diversi di intensità e insistenza.
Tra i ragazzi che ho incontrato e accolto tutti dicono di avere bisogno di aiuto, ma nessuno che abbia mai detto apertamente: «Ho bisogno di essere amato». Le richieste di affetto sono molte – i ragazzi in carcere e in comunità cercano l’abbraccio, mi vogliono sempre salutare con un bacio, oppure si esprimono indirettamente, lamentandosi di essere esclusi dalle attenzioni che invece verrebbero destinate ad altri – ma è raro che vengano espresse chiaramente. Credo che i ragazzi pensino di sembrare ridicoli e deboli. Invece chiedono amore esplicitamente e senza paura tutti i bambini; quelli che hanno i genitori, ai quali chiedono attenzioni e cure, quelli che sono stati allontanati dalla famiglia, che alle educatrici chiedono continuamente affetto, e quelli degli orfanotrofi romeni nei quali ogni anno mandiamo centinaia di volontari: hanno bisogno di amore più di ogni altra cosa, te lo mostrano con ogni gesto, con ogni sguardo. Per loro essere stati abbandonati in orfanotrofi fatiscenti, dove le condizioni di vita sono durissime, significa prima di tutto sentirsi esseri umani di scarto, che non meritano attenzione. Il bisogno di amore diventa bisogno di essere riconosciuti e degni di essere amati. Quando i nostri giovani volontari arrivano lì per i campi estivi, i bambini non chiedono altro che essere guardati, ascoltati e coccolati. Così una delle nostre ragazze ricorda il suo primo giorno in Romania: «L’arrivo fu strano: c’erano bambini e ragazzi entusiasti e altri che ci guardavano dalle finestre. Tutti i loro occhi erano spalancati su di noi per cercare di catturare il nostro sguardo. Dovevo avere un’espressione piena di panico, perché una piccola mi prese per mano e mi portò nel suo posto preferito».
Poi però, crescendo, questa spontaneità nella richiesta di affetto e attenzioni lascia il posto all’imbarazzo: è una mancanza, l’amore, della quale si prova vergogna, come se svelasse agli occhi di tutti che non se ne è stati degni. Non è strano che non si voglia esporre la propria fragilità: è decisamente meglio essere desiderati piuttosto che desiderare. O almeno così sembrerebbe. Intanto, però, a causa di questa mancanza vedo tanti ragazzi e ragazze vivere con grande difficoltà le relazioni e l’affetto, immobilizzati da una bassissima stima di sé, convinti di non essere capaci di fare nulla.
Molti tra loro sono stati abbandonati da piccolissimi, altri quando erano ragazzini. Altri ancora, stranieri, hanno invece sperimentato una forma di abbandono ambigua: ancora acerbi, sono stati trattati come una specie di investimento per il futuro, nella migliore delle ipotesi, e sempre come una fonte di sostentamento per la famiglia. Se entriamo nel cuore di chi è partito verso l’ignoto, spesso attraverso itinerari tortuosi e pericolosi, scopriremo l’ansia terribile generata dalla richiesta di diventare adulti in un giorno solo. Così la speranza di salvezza diventa spesso una condanna: è una condanna disumana quando, sotto gli occhi dei pescatori siciliani, tanti ragazzi tornano a galla senza vita, ma lo è anche quando il viaggio lascia dentro di loro la cicatrice indelebile dell’abbandono.
Alla mamma di Jamal i soldi che lui racimolava non bastavano, così un giorno gli ha detto: «Non restare nel mercato del nostro piccolo paese, non servi a nulla qui, prova ad andare verso la città». E lui, tredici anni, è andato verso la grande città con un suo compagno di avventura. Poi hanno visto una folla di persone che dicevano di andare in Spagna, dove si trovava lavoro: bastava riuscire ad arrivare a Ceuta, una città poco distante ma difesa da un muro di sei metri. Bisognava arrivarci a nuoto, per non essere bloccati alla frontiera. E lì la paura era tanta. E lì il suo compagno non ce l’ha fatta ed è tornato indietro. Allora Jamal ha preso tutto il coraggio che aveva, l’ha gettato in mare ed è arrivato nell’enclave spagnola ingoiando acqua e aria. Poi il cassone del tir e la Spagna, la polizia, la paura e la decisione di tornare a casa. Ma ha preso il camion sbagliato e i cartelli diventavano sempre più incomprensibili, la sua lucidità mangiata dalla fame, il suo respiro soffocato dai tubi di scappamento. Eccolo a Torino, dove un negoziante marocchino l’ha ripulito e rifocillato, poi a Milano, dove ha cercato in ogni modo di farsi arrestare per tornare, ancora, a casa. Ma niente, anche agli occhi dei poliziotti sembrava invisibile. Poi l’arresto, per qualche grammo di hashish in un giardinetto di via Mecenate. L’ultima volta che Jamal ha parlato al telefono con sua madre, lei non era preoccupata, era solo furibonda: dov’erano i soldi che ancora stava aspettando?
Sono i tanti ragazzini che vengono spediti in Europa a lavorare, per guadagnare non solo i soldi da spedire a casa, ma anche la stima della famiglia, che pretende di veder fruttare il proprio investimento. Non possono fallire. Visti da lontano, quando prendono un’ordinazione al nostro tavolo o ci consegnano una pizza, spesso sembrano un po’ troppo scontrosi e ingrati verso il Paese che li sta ospitando, ma quando li conosci da vicino scopri tutta la loro nostalgia, il senso d’abbandono, il bisogno d’amore.
Capitano anche, in particolare nelle famiglie dell’Est europeo, dell’Estremo Oriente e dell’America Latina, gli abbandoni «al contrario», in cui sono i genitori a partire in cerca di fortuna lasciando i figli alle cure di qualche parente, di solito i nonni. Poi, quando la situazione si è stabilizzata, li richiamano a sé. Ma il ricongiungimento non si risolve con i grandi abbracci del rincontro. Dopo i primi entusiasmi, i genitori dovranno fare i conti con un figlio che non hanno visto crescere e che ha nello sguardo un’accusa tenuta dentro per troppi anni, mentre il figlio dovrà rielaborare e accettare le ragioni dell’abbandono, un percorso che spesso non dà i risultati sperati, lasciando posto al desiderio di trasgressione, di fuga, di ricerca di altri adulti come riferimento.
Le storie di abbandono lasciano segni spesso indelebili sulla pelle di chi le ha vissute. Lo si comprende da alcuni segnali rispetto ai quali troppo spesso siamo sordi. Qualche volta è la rabbia, una rabbia che viene dalla convinzione che l’intero mondo sia un debitore moroso nei propri confronti: agli occhi degli estranei si diventa allora antipatici, maleducati, incomprensibili. Si chiede e si pretende come se ogni cosa fosse dovuta per un antico debito mai saldato. E naturalmente si ottiene l’effetto opposto. Ricordo un ragazzo che ha passato qualche tempo nella nostra comunità, riuscendo in breve a guadagnarsi l’antipatia di tutti, dai compagni di stanza agli educatori, dalle psicologhe agli assistenti sociali: per lui erano tutti colpevoli della sua sfortuna, tutti ladri del suo futuro. Senza documenti, senza diritti, era capace di strillare come un’aquila, un’aquila di 198 centimetri, se un assistente sociale lo faceva aspettare dieci minuti fuori dalla porta dell’ufficio. Un’arroganza che gli è costata cara, perché nessuno si è fermato a considerare la sua richiesta di amore. Nemmeno lui, forse, era in grado di capirla.
In altri casi, invece, chi è stato abbandonato veste i panni dell’opportunista a tempo pieno, incapace di amare gratis, sempre pronto a manifestare un affetto che sembra più una moneta di scambio che un sentimento sincero. E poi ci sono quelli che sono rimasti come congelati: non si fidano di nessuno, credono che non si debbano mai allacciare relazioni affettive, soprattutto con gli adulti, perché tanto poi finiscono e vieni abbandonato. Tanto vale allora non amare.
Penso per esempio a due fratelli rumeni che ho conosciuto tempo fa, abbandonati piccolissimi perché di intralcio a un nuovo matrimonio della madre, ripudiata dal precedente marito. Due bambini che a pochi mesi di vita hanno visto dileguarsi ogni adulto di riferimento: per la famiglia materna erano solo un ostacolo, per quella paterna un problema economico. È cominciata allora la solita trafila di orfanotrofi – non bisogna lasciarsi ingannare dal nome: in tanti Paesi, non solo in Romania, non si tratta di ricoveri per bambini senza genitori, ma di magazzini per vite indesiderate – e poi, attraverso i tir, l’arrivo in Italia da clandestini, le comunità per minori una dopo l’altra. Loro erano intrattabili, molesti, insubordinati. Hanno cercato di contattare la famiglia, ma sono stati ignorati. Il padre ha addirittura fatto credere loro di essere morto, inviando una lettera in cui si raccontava del suo funerale ormai celebrato. È comprensibile che per loro gli adulti non possano essere che infidi e profittatori. E così hanno imparato a crescere: sfruttando ogni opportunità senza fidarsi di nessuno. Dall’altra parte, specularmente, c’è un mondo adulto che li etichetta come «inaffidabili» senza farsi troppe domande.
È difficile costruire una relazione solidale con ragazzi come loro. Capita che approfittino anche di me; magari fingono, mentono, cercano di ottenere qualcosa con un piccolo imbroglio. E talvolta pensano anche di essere riusciti a fregarmi. Io glielo lascio credere, perché sono convinto che in quel momento non abbiano scelta, che nel loro attuale orizzonte non possano agire diversamente. Il loro comportamento diventa allora il punto di partenza per aiutarli a trovare altre soluzioni e non il punto di arrivo per un giudizio senza appello. Risentirsi e offendersi, a maggior ragione se si è in una prospettiva educativa, non serve a niente: un cattivo comportamento è sempre sintomo di un dolore e il nostro compito è aver cura di quel dolore affinché diventi possibile un cambiamento, affinché quel bisogno d’amore possa essere colmato.
Perché, come si portano i segni della mancanza d’amore, altrettanto indelebili sono, per fortuna, le tracce dell’amore ricevuto. Così è stato, per esempio, per Chan.
Chan è il secondogenito, con un fratello di poco maggiore, di una modesta famiglia di contadini cinesi. Non sarebbe nemmeno dovuto nascere, secondo le leggi di quel Paese. Una volta nato, non sarebbe dovuto sopravvivere. Invece i genitori l’hanno nascosto alle autorità, facendolo vivere in disparte, in campagna, senza mandarlo a scuola ma lasciando che ricevesse un po’ di educazione da uno zio. Probabilmente grazie ad alcune benevole complicità, il bambino è cresciuto sano, intelligente, sicuro. Nel frattempo i genitori risparmiavano con grande fatica: prima o poi il figlio sarebbe dovuto entrare ufficialmente nel mondo, esposto allo sguardo delle autorità, quindi occorreva prepararsi a un progetto alternativo, la fuga. Quando Chan ha compiuto quindici anni, e non è stato più possibile rimandare, gli hanno dato tutti i risparmi e lo hanno affidato a mani sconosciute, ma pur sempre meno pericolose di quelle ben note dei funzionari governativi. È così che Chan ha viaggiato dalla Cina alla Russia, poi giù attraverso il Kazakistan e verso il Medio Oriente, quindi il Nord Africa e l’arrivo a Napoli, poi altra tappa a Prato, infine Milano. Due anni di viaggio, di paure, di incertezza sull’affidabilità dei passatori, di lavori in nero, nascosto, ancora, agli occhi di tutti. Alla fine Chan è riuscito ad arrivare a destinazione sano e salvo, ma le cose in Italia non sono andate proprio nel migliore dei modi: qualche cattiva compagnia – essere clandestini di solito non permette di frequentare i salotti buoni – ed è arrivata l’accusa di complicità in un tentato omicidio. Dopo un passaggio in un carcere per adulti, Chan è approdato al Beccaria. Oggi, scontata la sua pena, è un ragazzo solido, lavora, ha una casa, la patente e l’automobile. Sogna di farsi presto una famiglia. È un ragazzo generoso e consapevole della propria forza. E io sono convinto che, assieme alle sue doti personali, sia stato grazie a quell’amore ricevuto, a quella manifesta volontà di farlo vivere e crescere nonostante le forze contrarie, che Chan è riuscito a trovare le risorse per conquistare autonomia e voglia di progettare il proprio futuro. Naturalmente il suo sogno è quello di tornare nel paesino tra le colline cinesi, un paesino ormai spopolato, per risistemare la casa natale e riprendere a pescare nel laghetto della sua infanzia. Se ci riuscirà, dovrà farlo con un altro nome, perché in Cina, almeno ufficialmente, lui non è mai nato.
Ho raccontato storie forse estreme, con il rischio che queste situazioni appaiano estranee al nostro sistema di vita, attrezzato con servizi per l’infanzia e assistenti sociali, accompagnato dagli inni alla sacralità della maternità e dei figli. Eppure in Italia i minori allontanati dalla famiglia di origine per essere affidati ad altre famiglie o alle comunità per minori sono quasi trentamila all’anno, dei quali poco meno della metà minori di dieci anni (i dati si riferiscono al 2011 e sono forniti dal Ministero delle Politiche Sociali). Tra questi solo una piccola parte è rappresentata dai minori stranieri non accompagnati (i protagonisti delle storie che ho raccontato, per intenderci, di solito affidati in comunità). E gli altri? Sono in prevalenza italiani e quasi sempre allontanati a forza con un provvedimento giudiziario: rappresentano la parte visibile delle difficoltà che molti genitori hanno nei confronti dei figli. La causa principale dell’affidamento è l’inadeguatezza dei genitori per motivi materiali ma anche per difficoltà relazionali ed educative. Certamente immagino trentamila storie diverse, ognuna con caratteristiche particolari, e non sono così ingenuo da pensare che sia sempre e solo la mancanza d’amore a determinare tutte queste storie.
Ma tra le pieghe delle nostre famiglie, in situazioni di disagio o di assoluta normalità, si nascondono negazioni d’amore, molto più spesso di quanto siamo disposti ad ammettere. Non dobbiamo cessare di interrogarci su questo bisogno primario. Quanti figli, divenuti adulti, recriminano di non essere stati accarezzati, baciati, ascoltati? Quanti genitori sono indaffarati, freddi, forse veramente convinti che nelle intemperie, per quanto precoci, si rinforzi il carattere? E quanti figli delle nostre classi agiate vengono mandati, spesso giovanissimi, nelle scuole d’élite, nei collegi rinomati dove impareranno a tessere relazioni eccellenti? Storie che quasi sempre finiscono bene e aprono le porte a un futuro professionale di successo. Ma anche tra questi casi, certamente più fortunati di quelli con cui ho a che fare tutti i giorni, non sempre le cose vanno per il verso giusto. Ricordo un ragazzo, figlio di una ricca e colta famiglia milanese, spedito in Inghilterra a quattordici anni per frequentare il liceo, che progressivamente manifestò tutti i segnali dolorosi di chi si sente abbandonato, fino ad avere bisogno di cure psichiatriche a causa di imprevedibili scoppi d’ira che sfociavano in violenza. La famiglia di origine leggeva questi comportamenti come una fragilità del figlio alla quale non bisognava cedere. Erano convinti veramente che il loro amore si dovesse manifestare con questa fermezza, che pure provocava angoscia anche a loro. Non volevano cedere. A un certo punto il figlio sparì, ripresentandosi dopo qualche anno in veste di adepto di un’oscura setta religiosa che lo aveva accolto dandogli l’illusione, forse, di essere amato.
L’essere amato e ricevere tutte le cure opportune, dunque, non solo è un diritto riconosciuto dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma è anche la risposta fondamentale per dare ai figli quella dote di risorse affettive importantissime per progettare una vita felice. Senza questa risposta si cresce con un vuoto affettivo che per molti diventerà un motivo ricorrente nel corso della vita. Credo che buona parte dei genitori che hanno difficoltà a manifestare l’affetto per i propri figli, e non solo verso i figli, siano stati a loro volta dei bimbi poco amati.
Il bisogno di amore contempla, oltre al desiderio di essere amati, il suo complemento inseparabile: il bisogno di amare. Si fa molta meno fatica ad ammettere questo aspetto, perché nel nostro immaginario contiene una capacità e non una mancanza, una forza e non una debolezza. Forse ci siamo dimenticati che i due versi dell’amore, donato e ricevuto, sono indivisibili, altrimenti si ricade nel fraintendimento degli amori a senso unico.
Così come capita di non essere amati, può anche capitare di non riuscire ad amare, di negarsi questo bisogno. Può essere una sorta di eredità di quella mancanza di amore ricevuto, che congela i sentimenti e impedisce di esprimerli. Ma concorrono anche fattori culturali, che indicano una nostra precisa responsabilità. In particolare quando ci convinciamo che i bisogni debbano essere negati per rafforzare la nostra illusione di essere del tutto autonomi. Se il bisogno indica uno stato di mancanza, di debolezza, lo associamo spesso, nella ricerca di soddisfazione, a una dipendenza, in questo caso dalle passioni, così che ci sembra sensato tentare di liberarcene. È il popolare «non ho bisogno di niente e di nessuno», un’affermazione che mi fa sorgere sempre forti dubbi sulla reale solidità di chi la pronuncia.
Se l’amore, dato e ricevuto, è un bisogno, allora il primo passo è riconoscerlo. Nella narrazione biblica lo stato di bisogno contraddistingue l’esistenza umana dopo la cacciata dall’Eden. Secoli di filosofia e di letteratura raccontano la condizione dell’uomo come segnata dal bisogno dell’altro, a partire dal neonato che dipende in ogni cosa dalla madre. Forse proprio dalla contrapposizione con lo stato divino nasce la cattiva fama del bisogno come limitazione dell’uomo. Eppure è grazie a questa minorazione che abbiamo costruito la civiltà umana: la ricerca di soddisfazione dei bisogni ha sempre rappresentato un motore per il progresso materiale e spirituale. Nel racconto biblico questo aspetto è mostrato in maniera sorprendente: Caino, l’uccisore di suo fratello Abele, viene condannato all’esilio, ma non a un esilio qualsiasi: è costretto a fuggire verso le terre ignote e minacciose, tanto che lo stesso Dio deve farsi garante della sua incolumità. Sarà proprio Caino – l’assassino, il reietto, insomma la persona più sola e bisognosa – a diventare il fondatore della prima città.
Certo, è molto difficile essere equilibrati in amore. C’è chi ama troppo poco e chi ama troppo. Ma può mai l’amore essere troppo? No, ne sono intimamente convinto, però può essere talmente concentrato su se stesso, sul proprio bisogno di amare, da dimenticarsi dell’amato, della sua libertà. Un po’ come negli amori a senso unico, il proprio bisogno di amare può prendere il sopravvento e finire per creare dipendenza. Può capitare nel caso dell’amore materno, che nel nostro immaginario è simbolo di gratuità e abnegazione.
Nel Cristianesimo l’amore materno è quello di Maria, capace di grande cura ma anche pronta, seppur con dolore, ad accettare le scelte del figlio fino alle loro conseguenze estreme: «Perché il volto della madre non tradisce paura e perché le sue dita non stringono il corpo del suo bambino con una forza che nemmeno la morte riuscirebbe a sconfiggere? Perché non fa nulla per sottrarre il figlio al suo destino?» si chiede Vasilij Grossman guardando la Madonna Sistina di Raffaello. E prosegue: «Ella offre il bimbo alla sua sorte, non lo nasconde». Un amore materno che Grossman paragonerà a quello delle mamme che a Treblinka portavano in braccio i figli entrando nelle camere a gas, ancora capaci di amare nel momento più atroce. È un amore che rivela la capacità di separare il proprio destino da quello dei figli, senza smettere di amarli.
Guardare a queste situazioni estreme può farci sentire dis...