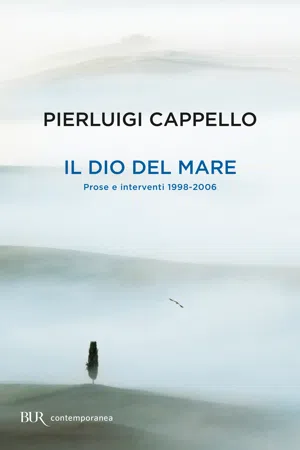![]()
IL DIO DEL MARE
![]()
Non un milligrammo in meno
Nel maggio del ’40, da qualche parte in Francia, un tank tedesco passa nella nuvola dei fiori di un ciliegio dopo averne divelto il tronco: è una celebre immagine della Blitzkrieg. In pieno deserto, nel 1991 un gruppo di marines degli Stati Uniti sfarina delle gallette sui palmi umiliati di soldati iracheni. Nel 2003, in un paese dell’alto Friuli, un uomo ha quasi ucciso un altro uomo a colpi di bastone. Davanti al mio giardino c’è una casa ristrutturata: prima era una casa solo di sassi, adesso è solo una casa di ricchi.
C’è un filo di volgarità che lega queste immagini, la volgarità è di colui che non sa reggere alla propria vittoria. Essere volgari è seducente. Per conto mio, mi ingegno di resistere, per lo più leggo e qualche volta scrivo. Scrivere versi è preparare con ostinazione e con cura il proprio fallimento, portarne tutto il peso, non un milligrammo in meno.
![]()
La mela di Newton
Verrà l’inverno, questo lo so. Il ventinovesimo da quando sono nato, il quattordicesimo, credo, da quando scrivo poesie. La stanza in cui scrivo i miei versi: un tavolo, quattro pareti, scansie con i libri alle spalle, due finestre davanti che mettono a est. Da quella più ampia posso vedere, spostati un po’ a destra, due abeti verdi ma austeri, dietro gli abeti dei culmini rossi, l’andare lento dei colli come dorsi di sauri e, quando il cielo è benigno, fatte d’aria le Alpi, le merlature azzurrine alte migliaia di secoli. Al di là di quelle montagne ci sono gli slavi, al di là respira il Danubio. Il Danubio non c’è non lo vedo lo posso soltanto sentire, come le unghie di questo inverno che viene. Si sente venire l’inverno, non solo perché buca tendini e ossa e io le pareti comincio a guardarle con gli occhi di Giona, l’inverno è presente dentro ogni foglia d’ottobre. Ed oggi è un bel giorno d’ottobre. Ieri però – e anche stanotte – è piovuto, non c’erano montagne azzurrine, né culmini rossi, né dorsi di sauri, c’erano appena i due abeti pesanti, le finestre appiattite contro una luce un po’ baltica e il sospetto che il niente fosse qui attorno. Per questo il sereno di oggi è profondo, lo si guarda accecante sugli orli dei monti come dopo un digiuno che estenui, per questo lo screzio bianco e dentro violetto di nubi superstiti a nord è inciso al bulino e rende ancora più intatta, perfetta la sostanza del cielo. È in giorni simili a questo che esco, fuori è ancora campagna e non è ancora occidente, l’occidente morde il silenzio lontano, dentro i televisori, sulla statale, lontano.
Passeggiare certe mattine in campagna, quando la luce è calva come un sasso di fiume, non è soltanto un esercizio di stile; la mia potenza la mia insufficienza di uomo, la misuro col metro dei colori d’autunno. E la luce che varia. L’altezza afflitta del cipresso. La scapigliatura di erbe lunghe, ad esempio: hanno un loro colore savio ma ingenuo, quasi il saio di un frate, «sempre si more» pare che dica, e poi gli aceri, i roveri, le acacie irsute, la gentilezza slava delle betulle, i gelsi tarchiati, guardie confinarie tra un campo e l’altro di mais; e sono gialli fastosi, ocra discreti, e l’arancio s’incendia di rosso, il rosso si finge amaranto, l’araldica rara che rende più nobile il verde. Per quanti amaranti c’è un nome, per quanti toni di verde, per quanti celesti c’è un nome? Qualche volta mi sforzo e serro le palpebre come di miope o navigante o pittore, ma basta una brezza e dispone un giallo dove prima era verde, con la rètina e, peggio, la penna che in superficie non coglie che crespe, mentre dietro quel muro impassibile sta tutta una peripezia d’elettrone.
Tuttavia esiste, quel nome, ed è un atomo anteriore alle cose e ogni colore non còlto si chiama distanza, ogni sguardo che coglie si chiama poesia. È questa l’ebrietudine d’origine, è questo, mi dico, il corso dei poeti, sbarbicare le parole dal silenzio, farle intatte – rosa di Paracelso –, sentirle pesanti sul palmo, come le teste dei re, dentro il cerchio concluso di monete d’oro o di rame.
II
Allora spiravano ancora i venti cardinali, Austro Borea Zefiro Aquilone, si poteva parlare coi morti così come si parla coi vivi, nelle coscienze dei savi i domìni del bene e quelli del male erano netti quanto i contorni di porpora e d’oro che scintillano dentro le icone, le pietre non erano pietre, le piante non erano piante, le bestie non erano bestie soltanto, ma insieme chiave e chiavarda perché quella visibile era la soglia di un mondo divino dietro le cose. Non so quale vento spirasse sulle cortecce dell’albero bello dove Rolando sfinito andò a posare la nuca e le scapole, la retroguardia dei Franchi annientata, i pagani respinti, Re Carlo salvo in terra di Francia. Olivieri, l’amico più stretto, il compagno più saggio del paladino Rolando li aveva visti arrivare, i pagani: schiere folte dal cuore di Spagna, migliaia di elmi e pennoncelli gialli e scarlatti, dalle cotte inzaffirate – così riporta il testo – armati di spade d’acciaio viennese e spiedi di Valenza, «la salvezza è oltre Roncisvalle, richiama il re, Rolando» avrà suggerito all’amico, «se ti impegni adesso in battaglia nessuno di questi guerrieri che vedi potrà impegnarne un’altra domani». Rolando ignorò il suo compagno, calò la celata sul viso, dalle fessure dell’elmo di ferro spiò l’avanzare dei cavalieri nemici; quattro, cinquecento cavalieri corazzati, con le aste in ordine di battaglia, sporgenti dalla linea compatta dei musi dei cavalli, sono una siepe che è lunga duemila metri almeno e parecchie tonnellate d’acciaio; probabilmente lo schieramento dei Franchi in principio si mosse al piccolo trotto, per liberarsi dall’attrito iniziale e accumulare forza d’inerzia, poi sempre più velocemente, come fa una gigantesca turbina, finché ogni cavaliere ogni cavallo ogni lancia di tutte quelle tonnellate scatenate sarebbe diventato un proiettile solo e avrebbe impattato con altri cavalieri, altri cavalli, altre tonnellate lanciate a una velocità pressappoco uguale e con la medesima determinazione e ferocia: immaginatevi l’impatto contemporaneo e frontale di un migliaio di automobili alla velocità di trenta, quaranta chilometri orari, in un’area così ristretta che potrebbe appena contenerne il numero, immaginatevi l’aria tagliata dal fischio degli spezzoni di lancia, dal nitrito delle cavalcature, dalle teste dei decapitati che l’energia liberata in un solo punto ha fatto diventare veri e propri proiettili, considerate lo scricchiolio di crostaceo delle ossa dei calpestati e il fondo delle gole di chi è rimasto in sella e grida e, rotta la lancia, continua con le mazze ferrate a sfondare elmi e fracassare volti, in uno stato di ascesi sanguinaria, parente della pazzia, che si chiama furor belli e, soprattutto, non dimenticate che quanto ho scritto è solo un battere e un levare di pupi rispetto allo scontro di due formazioni di cavalleria medioevale. La scena della battaglia di Roncisvalle è uno dei passi più frequentati durante le lezioni di epica: non appena la professoressa ne terminò la lettura e in aula ripresero i bisbigli, di sicuro nessuno si avvide della mia fronte un po’ calda, della mia bocca socchiusa, della confusione con cui riposi in cartella astuccio e antologia; quei versi che dicevano di amicizia e di guerra, quelle parole scritte novecento anni prima, di molte delle quali non conoscevo nemmeno il significato, mi erano piovute dentro da una distanza monumentale, e della mia stessa sorpresa io ero diventato lo spettatore contemplante. Non colsi l’aspetto cruento della battaglia, so che i pensieri stilizzati di un dodicenne di montagna avevano, per un istante, collimato con le figure stilizzate del poema; so che da qualche altra parte, in qualche altra classe, gli occhi di altri dodicenni dalla fronte un po’ calda avranno visto avanzare i pennoncelli gialli e scarlatti con la prodezza di Rolando o la prudenza di Olivieri.
Forse l’esito dell’Epos è un risveglio, forse la possibilità di svegliarsi percorre il fondo delle coscienze degli esseri umani come una comune, gigantesca ragnatela, pronta a vibrare ovunque sia suscitata, qui da me, adesso che scrivo, come altrove, al di là delle montagne che vedo, al di là di quelle che non vedo. In ogni caso, quel giorno, per quello scolaro delle medie che ero, la voce dell’insegnante di lettere divenne l’inconsapevole plettro, il privato ecoscandaglio dell’Epos. Continuai a giocare a biglie dopo quel giorno, continuai ad arrabbiarmi se perdevo, a gioire se vincevo, continuai, come tutti i bambini, a non scompormi ai rimbrotti di mio padre, però, intermittenti, magari nel bel mezzo di una partita a pallone o durante una sassaiola o, la sera, dentro il caldo delle coperte, mi tornavano alla mente il bel sole di Roncisvalle, il barbaglio degli elmi, le file fitte delle corazze brune.
Sono persuaso che chi scrive sia, in qualche modo, il collezionista di sé stesso, un uomo pronto a varcare i continenti di memoria che lo compongono, a tacere per mesi, per riportare al sole delle parole rare come cimeli perché sono sue, finché qualche altro essere umano non le farà proprie per seppellirle di nuovo e ricominciare a cercare; ma io non sapevo scrivere, allora, così cominciai a raffigurare per possedere quelle emozioni come fossero oggetti; avevo appena imparato a usare la china e disegnai Rolando, Olivieri, Re Carlo, tratti sghembi di scolaro che volevano significare spallacci, cotte, cimieri su fogli bianchi di cartoncino; a mia madre dicevo, mentendo, che erano esercitazioni di educazione artistica, che non si preoccupasse per la mia imperizia di grafico in erba, ma per tutto quell’anno la mia sollecitudine nel disegnare fu pari soltanto all’indolenza con cui seguivo le altre lezioni.
Rolando morì più o meno a novembre, accettò la sua fine con l’impassibilità di un sacerdote armato, cercò di spezzare Durlindana che si ostinò a non spezzarsi, lo fece con lentezza per tutte le lasse che chiudono l’episodio, perché agli animi grandi si confanno i gesti lenti, la eco dell’ultima nota d’Olifante risuona in me tuttora. A Rolando seguirono Ettore, Odisseo, Enea, altri fogli e altri disegni, le tappe di quell’anno scolastico. Fu il mio primo incontro con la poesia. E oggi qualsiasi cosa mi passi accanto, può suscitare un verso dei poeti che ho letto: è la mia biologia che li porta, il mio ritmo cardiaco, essi vivono nelle mie fibre, talvolta parlano con la mia voce, della rete misconosciuta di strade che li conduce dentro il futuro, io non sono che una remota stazione, finché il Tempo non estinguerà il mio tempo di uomo.
III
Un edificio bruniccio, notturno, scorto di tre quarti dal basso, radicato sui ciglioni dai quali si sporge come un corvo di pietre, insidiato nella sua compattezza di monade soltanto da alcune aperture, più feritoie che finestre, sparse qua e là sulle muraglie in luce. È quanto ricordo del monastero medioevale raffigurato nel mio sussidiario delle elementari. Ricordo anche che preferivo di gran lunga le navi greche di qualche pagina prima, gli occhi grandi, mandorle di smalto disegnate sulle prore, gli scafi snelli, mossi dall’unica vela quadrata e da un ginepraio di remi appena sopra la linea di galleggiamento che le faceva un po’ insetti, millepiedi sull’azzurro elementare del mare. Non meno smagliante mi appariva la batteria di cannoni francesi a Waterloo, con gli artiglieri in alamari e giacca blu che, nel disordine della battaglia, mi suggerivano un’impressione di concitata cura, lontani i bioccoli di fumo fioriti in mezzo alle file rosse della fanteria inglese. Insomma, di tutte le immagini del mio sussidiario, solo i carbonari in cilindro, sinistri come s...