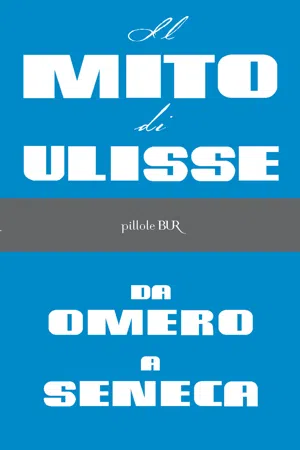
- 144 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il mito di Ulisse
Informazioni su questo libro
A cura di Simone Beta La presenza costante, il fascino che non ha mai cessato di esercitare sull'immaginazione la figura di Ulisse, sono segni del suo portare in sé l'intero nostro destino di uomini. – Piero Boitani ULISSE, l'eroe eterno che vive grandioso e sofferente nella poesia attraverso i secoli, è il solitario protagonista di questa raccolta. Attraverso le parole di Omero, Sofocle, Platone, Ovidio rivivono le peripezie più famose della letteratura occidentale. Una storia insuperata che ha conquistato milioni di lettori, una leggenda che ha travalicato quasi tremila anni di storia.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Print ISBN
9788817016148eBook ISBN
9788858665442IL MITO DI ULISSE
A cura di
SIMONE BETA

Proprietà letteraria riservata
© 2008 RCS Libri S.p.A., Milano
eISBN 978-88-58-66544-2
Prima edizione digitale 2013 da edizione pillole BUR aprile 2007
Copertina Mucca Design
Per conoscere il mondo BUR visita il sito www.bur.eu
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
I VOLTI DI ULISSE
«Non era bello, Ulisse, ma sapeva parlare bene»: così dice Ovidio nell’Arte di amare quando consiglia agli uomini di non puntare tutto sul proprio aspetto fisico ma di lavorare sodo per costruirsi una formazione culturale che possa essere un efficace sostegno alla bellezza. Dovendo indicare un esempio appropriato per provare la sua affermazione, Ovidio sceglie Ulisse, che funziona alla perfezione perché l’eroe cantato da Omero conosceva tutti i trucchi del linguaggio e se ne serviva per ingannare tutti, sempre e comunque. Per non correre rischi, per tenersi sempre aperta una via di fuga o, più semplicemente, per abitudine, Ulisse amava assumere spesso volti differenti: lo faceva ovviamente con i nemici, come il Ciclope (al quale si presenta come «Nessuno») o come i pretendenti (ai quali si mostra nei panni di un vecchio mendicante), ma si comportava così anche con gli amici, per evitare che potessero rivelarsi involontariamente pericolosi (lo fa con Eumeo, al quale racconta la sua frottola preferita millantando false origini cretesi). Anche quando aveva a che fare con le donne (forse perché, come sostiene Ovidio, non poteva fare eccessivo affidamento sul suo aspetto fisico?) Ulisse si camuffava spesso. Non sempre, tuttavia, il travestimento aveva successo.
Con Penelope, il trucco riesce con facilità perfino eccessiva. Non poteva essere diversamente: in fondo, la moglie non lo vedeva da vent’anni! E poi, quando Ulisse sbarca a Itaca, la dea Atena modifica i suoi connotati per renderlo irriconoscibile – e non ci dobbiamo dimenticare che pure Ulisse ci mette del suo, raccontando alla moglie di essere un principe cretese e «dicendo molte menzogne che sembravano vere». L’inganno riesce così bene che, prima di riconoscere definitivamente suo marito, Penelope deve sentirsi raccontare per filo e per segno la storia della complessa fabbricazione del loro letto nuziale scavato in un tronco d’olivo.
Omero ci racconta in modo dettagliato la preparazione dell’inganno puntando il suo obiettivo sulla figura di Ulisse: prima ne descrive la trasformazione fisica (la dea Atena cambia colore ai suoi capelli, toglie morbidezza alla pelle e luminosità agli occhi) e poi si dilunga sui suoi falsi racconti. Delle reazioni di Penelope, solo un particolare ci viene rivelato, attraverso una similitudine: «Come, quando Euro scioglie la neve che Zeus aveva fatto cadere sulle alte cime dei monti, i fiumi scendono a valle gonfi d’acqua, così scendevano le lacrime dalle guance di Penelope, che piangeva lo sposo che le stava seduto vicino».
Certo, sarebbe interessante sapere come le donne di Ulisse reagivano a queste misteriose apparizioni. Alcuni autori lo hanno fatto, variando la prospettiva omerica e dirigendo il loro sguardo privilegiato su Penelope.
Esattamente un secolo fa, nella primavera del 1907, seguendo un suggerimento del soprano Lucienne Bréval (che ne sarebbe stata sei anni dopo la prima interprete), Gabriel Fauré cominciò a comporre la sua unica opera lirica, Pénélope, il racconto del «ritorno di Ulisse in patria» visto con gli occhi della sua sposa fedele. Nel libretto di René Fauchois l’attenzione è rivolta soprattutto alla moglie dell’eroe, che tiene testa con vigore ai pretendenti dichiarando a più riprese la sua incrollabile certezza nel ritorno del marito lontano: nella sua prima aria («Il reviendra..., j’en suis certaine»), Penelope dice ai Proci con tono di sfida di essere sicura che le sue orecchie sentiranno ancora la sua voce, che le sembrerà più bella proprio per essere stata lontana per così tanto tempo. L’eco della voce di Ulisse nella memoria di Penelope percorre tutta l’opera come un Leitmotiv. All’inizio del secondo atto, la regina sale come tutte le sere sulla collina per appendere alle colonne di un tempio le rose che ha colto durante la salita e per osservare il mare, nella speranza che «se la sua nave, all’improvviso, arrivasse in vista della costa, e se Ulisse levasse gli occhi verso le alte colonne del tempio, queste rose gli rivelerebbero il mio amore ansioso e il suo cuore saprebbe subito che Penelope attende fedele il suo ritorno» (un riferimento all’analoga attesa di Cio-Cio-San che nella Madama Butterfly pucciniana scruta l’oceano alla ricerca del fumo che segnali la nave del suo amato Pinkerton?); in cima alla collina, dopo aver parlato a lungo col misterioso straniero (che è Ulisse nei panni di un mercante cretese), al momento di tornare alla reggia Penelope sembra quasi riconoscere la voce di suo marito («Oh! Ta voix, à l’instant, me rappelle...»), ma allontana subito dal suo cuore quella speranza che crede a torto fallace. Questo episodio, che segna un significativo scarto rispetto al racconto omerico, non è l’unico esempio nella riduzione di Fauchois: per sottolineare in modo più forte il ruolo di Penelope, che rappresenta il simbolo dei legami familiari che avevano spinto Ulisse a cercare di raggiungere a tutti i costi la sua amata Itaca, il librettista elimina addirittura dalla vicenda Telemaco.
Un simile sguardo femminile sulle vicende conclusive dell’Odissea è un unicum nella produzione musicale che, dal melodramma di Monteverdi (rappresentato per la prima volta a Venezia nel 1640) alle numerose riprese serie (Luigi Ricci, Ulisse in Itaca, 1828; Luigi Dallapiccola, Ulisse, 1968; Luciano Berio, Outis, 1996) e comiche (le opere buffe di Hervé e Raoul Pugno, intitolate entrambe Le retour d’Ulysse e rappresentate a Parigi rispettivamente nel 1862 e nel 1889), era stata sempre dominata dalla figura del protagonista. Ma, se si passa dal melodramma alla narrativa, esistono altri lavori che hanno messo in discussione la natura «maschile» (o «maschia») del poema omerico: Samuel Butler, lo scrittore satirico inglese famoso per il romanzo Erewhon, dopo aver tradotto nella sua lingua i poemi omerici scrisse nel 1897 un libro intitolato L’autrice dell’Odissea avanzando l’ipotesi che il poema fosse stato scritto da una poetessa siciliana; Robert Graves, l’autore di Io, Claudio, rimase colpito da una simile eventualità e la sviluppò nel romanzo La figlia di Omero, pubblicato nel 1955.
Questa duplice natura dell’Odissea è in un certo qual modo legittimata dal ruolo di primo piano che la presenza femminile, umana e divina, gioca nelle vicende del poema: non c’è solo Penelope, destinata a diventare il paradigma della sposa fedele, ma ci sono anche la regina dei Feaci Arete e sua figlia Nausicaa, ci sono Calipso e Circe, c’è Elena di Troia (che è tornata col legittimo marito Menelao nella sua vecchia casa spartana e riconosce subito il giovane Telemaco per la sua straordinaria somiglianza con il padre), c’è infine la dea Atena, che protegge sempre il suo eroe prediletto.
Pure nei confronti di Arete (e dei Feaci in generale) Ulisse ha un atteggiamento guardingo. Quando la regina gli chiede chi è e da dove viene, Ulisse risponde alla seconda domanda (raccontando la sua partenza dall’isola di Ogigia e il suo naufragio) sorvolando sulla prima: non mente, quindi, ma non dice tutta la verità.
Secondo alcuni filologi di scuola anglosassone, Ulisse mentirebbe ai Feaci anche più avanti, quando, all’inizio del IX libro, dopo aver rivelato la sua identità («Io sono Ulisse, figlio di Laerte, noto a tutti gli uomini per i miei inganni»), racconta la prima parte del suo viaggio. Le vicende più famose del poema (il Ciclope, l’otre di Eolo, le Sirene, Scilla e Cariddi, la discesa agli inferi) sono raccontate da Ulisse, che ne è in fin dei conti l’unico garante perché tutti i suoi compagni sono morti: se il suo contributo personale alla presa di Troia (l’arruolamento di Achille, il recupero dell’arco di Filottete, la spedizione notturna nell’accampamento troiano insieme a Diomede, lo stratagemma del cavallo) avviene sempre alla presenza di altri eroi, le imprese narrate alla corte di Alcinoo nei libri IX, X, XI e XII non poggiano sull’autorità di nessun testimone.
C’è chi ha pensato che questi racconti siano volutamente falsi, proprio come quelli che Ulisse inventa quando giunge nella sua isola (non solo il racconto fatto a Penelope, ma anche quelli fatti in precedenza al porcaro Eumeo e ad Antinoo, il capo dei Proci). L’ambiguità e la molteplicità sono una costante nella figura dell’ingannatore Ulisse e nella sua storia letteraria: Ulisse non è mai una sola persona, perché anche quando, scoperto, si toglie la maschera, non sappiamo mai se il volto che mostra è davvero il suo.
Bisogna però riconoscere che talvolta l’ambiguità generata dal suo personaggio non è voluta da Ulisse. Quando incontra Nausicaa sulla spiaggia di Scheria e le rivolge una supplica, Ulisse non dice bugie: forse, per raggiungere i suoi obiettivi, esagera un po’ («Se sei una divinità che abita il vasto cielo, per me assomigli ad Artemide, figlia del sommo Zeus, per il tuo aspetto e per l’altezza della tua figura...»), ma le sue parole descrivono la propria situazione di naufrago come essa è veramente. Non è certo colpa di Ulisse se Nausicaa si innamora di lui tanto da raccontare alle sue ancelle che vorrebbe sposarlo: la responsabilità ricade tutta sulle spalle di Atena, che prima aveva ricordato alla principessa che il giorno del suo matrimonio non era lontano e poi aveva reso il naufrago più alto e più grande (e quindi più affascinante).
Nausicaa non si innamora né per le parole di Ulisse né per la sua fama. Quando si congeda da lui chiedendogli solo di non essere dimenticata, Ulisse non ha ancora rivelato ai Feaci la sua vera identità, («Possa tu essere felice, o straniero! E quando arriverai nella tua terra, ricordati di me, perché a me per prima tu devi la tua vita»). Con la sua risposta Ulisse la rassicura e – pur se in modo velato, mostrando una delicatezza che non ci aspetteremmo – le confessa perché non può restare («Nausicaa, figlia del magnanimo Alcinoo, se Zeus signore del tuono, sposo di Era, mi concederà di ritornare a casa, anche laggiù ti invocherò come una dea, per sempre, tutti i giorni, perché tu, o fanciulla, mi hai salvato»): il riferimento non necessario a Era, moglie di Zeus e protettrice del matrimonio, fa capire alla fanciulla che il cuore di Ulisse non è libero.
dp n="10" folio="10" ? Ulisse non può restare a Scheria. Deve partire, perché questo è il suo destino. Così dice l’eroe al re dei Feaci dopo aver rivelato la sua vera identità: «Abito nell’isola di Itaca piena di sole, dove sorge una montagna, il Nerito coperto di fronde. Intorno ci sono molte isole, l’una vicino all’altra: Dulichio, Same, la boscosa Zacinto... Itaca è la più bassa, giace verso occidente, mentre le altre sono più lontane, verso il sorgere del sole. Un’isola aspra, è vero, ma i suoi giovani sono valorosi. Non c’è nulla che sia più dolce della propria terra: la divina Calipso mi tratteneva nelle sue grotte profonde desiderando che fossi il suo sposo; anche l’astuta Circe mi tratteneva nella sua casa di Eea desiderando che fossi il suo spo...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio