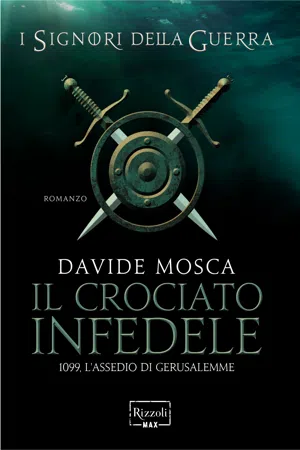![]()
1
Genova l’abbiamo fondata io e Guglielmo Embriaco Testadimaglio su una spiaggia di Giaffa, in Terrasanta, una mattina di giugno dell’anno del Signore millenovantanove. Avevamo vent’anni.
La mente di un vecchio è uno strano scrigno, capita spesso di trovarvi qualche monile che ci si era dimenticati di possedere.
Nelle chiare giornate d’autunno scendo al porto a osservare le navi, e per ozio o vanità mi domando se si possa considerare il vero fondatore di una città colui che ha posto la prima pietra o piuttosto chi l’ha resa grande: Romolo e Remo, oppure Scipione; Teseo, oppure Platone e Pericle. Mentre attendo che siano le onde o le barche a portarmi la risposta, ripenso a tutti i ruoli che ho recitato nella mia lunga vita: console, infedele, mercante, guerriero, pellegrino, diplomatico, generale, scrittore, ammiraglio; e alle persone con cui ho trattato: papi, duchi, conti, vescovi, imperatori, re, cadì, emiri, visir. Ogni volta mi sovviene un personaggio di cui mi ero dimenticato, oppure un mestiere che non ricordavo di aver svolto, ma sempre la mia mente ritorna a quella mattina di oltre sessant’anni fa, quando su una piccola spiaggia si decise il destino di tutto il nostro mondo.
Millenovantanove anni dopo la nascita di nostro Signore, morimmo e rinascemmo a Gerusalemme.
Casa. Fu la prima parola che mi salì alle labbra quando vidi profilarsi la costa della Terrasanta, su cui sventolava la composita bandiera del Mediterraneo, la stessa che puoi trovare su una spiaggia della Liguria come su una dell’Asia Minore: il bianco abbagliante della luce, l’azzurro del cielo intessuto con luminosi fili d’oro e il colore del mare, qualunque esso sia. Omero lo paragonava spesso a quello del vino, e non me la sento di contraddirlo, visto che davvero puoi ubriacartene.
Ero salito su una nave a sette anni e da allora avevo navigato prima con mio zio e poi con mio padre per buona parte di quel Mediterraneo che come una toppa cuciva insieme tutte le variopinte vesti che lo circondavano.
Casa. Fu la seconda parola che mi venne in mente mentre ci avvicinavamo alla baia di Giaffa. Non l’avremmo rivista più, Genova, perché nessuno di noi sarebbe tornato indietro. Se fossimo morti o se invece fossimo sopravvissuti non avrebbe avuto alcuna importanza. Era uno di quei viaggi da cui nessuno fa ritorno.
Genova e il mondo erano assai diversi all’epoca della spedizione in Terrasanta, molto più piccola la prima e molto più grande il secondo. La nostra inaspettata e miracolosa espansione ha poi reso il mondo meno vasto: basta un ponte per domare un fiume e noi ne abbiamo gettate svariate decine nel corso degli ultimi lustri. Se il Mediterraneo era allora un oceano, oggi è un lago. Il nostro lago.
A quei tempi, però, eravamo come uno squalo in una tinozza. Che senso aveva essere potenzialmente l’animale più pericoloso del mare, se non avevi un mare? Il Mediterraneo orientale era saldamente in mano alla flotta dell’impero bizantino, con cui i rapporti non erano buoni come un tempo, mentre quello occidentale era infestato dalla pirateria saracena.
L’unica rotta almeno in parte sicura era quella verso la Francia meridionale, perché i provenzali erano riusciti a distruggere quasi tutte le basi dei pirati berberi, ma un’unica destinazione non era sufficiente per imbastire un vero traffico marino. Ogni rotta commerciale deve infatti formare un triangolo per diventare redditizia: vendi panni a Marsiglia in cambio di sale che poi scambi ad Alessandria d’Egitto per argento e avorio da rivendere infine a Genova. Poiché non era quasi mai facile trovare il terzo angolo, il più delle volte dovevamo affidarci alla buona sorte e alla nostra temerarietà. I saraceni non sapevano mai se indossare i panni dei commercianti o dei pirati, e spesso facevano entrambe le cose: capitava così di concludere buoni affari all’emporio del Cairo per poi essere depredati al largo delle coste iberiche dai pirati berberi.
Insomma, il Mediterraneo non era il più sicuro dei luoghi e molte galee genovesi abbellivano il suo fondale: non erano state costruite per quello.
Sul continente le cose non andavano molto meglio, se è vero che lotte e guerre imperversavano per tutta Europa falcidiando intere generazioni. O, per lo meno, avevano imperversato fino al novembre dell’Anno Domini millenovantacinque quando, a Clermont, il papa Urbano II aveva chiamato i guerrieri europei al pellegrinaggio in Terrasanta.
L’appello arrivava in risposta all’accorata lettera di Alessio Comneno, imperatore romano d’Oriente, che chiedeva l’invio urgente di truppe per aiutare i bizantini a respingere l’attacco devastante dei turchi selgiuchidi. Secondo le ultime notizie, erano dilagati in Terrasanta occupando i luoghi sacri, opprimendo le popolazioni cristiane e rendendo praticamente impossibili i pellegrinaggi, e ora avanzavano in Anatolia puntando addirittura su Costantinopoli. Il passo successivo sarebbe stata l’Europa.
La voce del papa si trasformò in un tifone e nel giro di pochi mesi migliaia di persone si misero in marcia dietro a predicatori itineranti e cavalieri solitari; erano per lo più contadini, popolani, donne, chierici, ragazzini, una schiera composita e rutilante priva di disciplina militare, armi e vettovaglie: non avevano nulla se non il cuore, e quello fu il loro unico bagaglio. Non era a costoro che l’appello era stato rivolto, ma chi poteva fermarli ormai? I principi con i loro séguiti partirono appena qualche settimana dopo: franchi, provenzali, normanni, fiamminghi, nonché tedeschi e italiani delle città libere. Un continente in marcia.
In quei giorni del millenovantasei, io e Guglielmo Embriaco eravamo troppo giovani per partire e tre anni dopo non eravamo certo più maturi, quando ci radunammo nell’antica chiesa genovese di San Siro per accogliere i nostri concittadini reduci dalla Terrasanta, dove erano andati per portare soccorso all’esercito occidentale di liberazione. Erano salpati in duemila l’estate prima, ma appena una cinquantina erano rientrati. Raccontavano di aver partecipato alla riconquista di Antiochia e portavano documenti per testimoniare il successo dell’impresa, ma la loro nave era vuota: nessuna ricchezza, nemmeno una cassa di merci, soltanto un pugno di ceneri che giuravano fossero quelle di Giovanni il Battista. Magri, come se avessero patito la fame, ma negli occhi una luce che a noi ragazzi fece impressione. La luce di chi ha visto qualcosa o qualcuno che nessun altro ha mai visto, una luce che ardeva più intensamente delle candele.
In quei tre anni gli occidentali giunti in soccorso dei bizantini erano riusciti a respingere i turchi dalla penisola anatolica e appunto a riprendere Antiochia, dopo un terribile assedio durato un anno, ma le buone notizie finivano lì: molti uomini erano caduti, l’alleanza con i bizantini scricchiolava, i rifornimenti erano difficili, il tempo ostile e i luoghi santi ben lungi dall’essere liberati.
Sebbene coloro che erano tornati dalla spedizione annunciassero una grande vittoria, ai più sembravano gli ambasciatori di una terribile sconfitta. A nulla valsero i loro appassionati appelli: l’invito ad armare navi per portar soccorso ai fratelli in Terrasanta cadde nel vuoto. Erano tempi cupi a causa delle faide interne e le vacillanti autorità cittadine si rifiutarono di investire in un’impresa chiaramente fallimentare. Dov’erano le ricchezze? Quali merci portavano i reduci? Se la guerra andava bene, perché erano ritornati in così scarso numero e in quelle condizioni?
Chi avesse voluto recarsi in Palestina per andare in aiuto dell’esercito occidentale e guadagnarsi il paradiso, avrebbe dovuto farlo come privato cittadino. La compagine che dirigeva in quel momento la città non avrebbe partecipato. Meglio crogiolarsi in purgatorio, che arrostire all’inferno.
Era un periodo di insanguinate lotte intestine tra i consorzi di famiglie per il controllo del governo e a nessuno andava di lasciare Genova, dove imperversava una sorta di tacita guerra civile. C’erano agguati, rappresaglie, imboscate, piani segreti, e chiunque aspirasse al consolato della città reclutava uomini. A tutti sembrava che andarsene in quel momento avrebbe significato perdere ogni possibilità di carriera e di potere. Un vero suicidio.
Solo una persona la pensava diversamente. E per uno strano caso del destino quella persona era il mio migliore amico.
Guglielmo Embriaco era il figlio cadetto del ramo minore di una potente famiglia di origine viscontile che lottava in quel momento per assicurarsi il controllo di Genova. Nella stessa consorteria di famiglie c’era anche la mia. Degli otto consorzi cittadini, ciascuno ancorato a una porzione di città, il nostro era quello che poteva vantare l’origine più antica, e forse proprio per questo accusavamo il colpo: se avessi dovuto scommettere su chi l’avrebbe spuntata alla fine, noi saremmo stati la terza scelta. E il terzo posto non era male, peccato che i gruppi che avessero reali possibilità di successo fossero appunto tre.
Guglielmo ed io eravamo perciò cresciuti insieme, e chi ci vedeva correre per i vicoli della zona di Castello, il nostro quartiere roccaforte, ci chiamava l’orso e la volpe. La cosa buffa è che io non ero affatto basso, ma quando si cresce all’ombra di un gigante non sempre è facile farsi notare. Non che la cosa mi dispiacesse. Più di una volta lo avevo usato come scudo.
Sebbene le vicende del mare ci avessero portato spesso e volentieri a non vederci per mesi, io sulle rotte per Alessandria d’Egitto e lui verso quelle di Provenza, eravamo rimasti legatissimi e ogni volta che ci si ritrovava a Genova era un’occasione per far baldoria, e in quello non eravamo secondi a nessuno.
Quando lo vidi arrivare sotto casa mia quella mattina di aprile capii subito che aveva preso una decisione, e non era una buona notizia. Guglielmo è uno di quegli uomini le cui scelte hanno sempre un peso e una ricaduta. Un conto è quando cade una rosa, un conto quando cade un albero. E Guglielmo era una quercia secolare.
In quei giorni terribili, poi, le persone normali, e per normali intendo quelle consapevoli di essere mortali, usavano le passerelle mobili di legno per andare da una casa all’altra, da una finestra a quella di fronte: i vicoli erano troppo pericolosi e le imboscate all’ordine del giorno. Una delle definizioni di genovesi che mi divertivo a coniare per il mio personale dizionario: uomini che non hanno il benché minimo timore a percorrere il vasto mare con tutti i suoi pericoli, ma senza il coraggio di passeggiare in città.
«Non dirmi che hai deciso di farti monaco» gli dissi quando me lo vidi davanti, un uomo di otto palmi e trecento libbre che si muoveva con la rapidità di un gatto.
Mi guardò come se avessi indovinato le sue intenzioni segrete. «Ho deciso di farmi monaco, guerriero, mercante, ma anche diplomatico, marinaio, contadino, falegname, medico. E qualsiasi altra cosa sarà necessaria per salvare noi e la città.»
«Guarda che carnevale è passato da un pezzo.»
«Sono serio.»
«E quando mai non lo sei stato?»
«Puoi esserlo anche tu per una volta?»
«E poi chi chiameremmo a bilanciare la coppia?»
«Per favore, Caffaro.»
Sospirai. Fin dall’infanzia avevo sempre avuto l’impressione che un giorno quell’uomo mi avrebbe legato a lui. Così come lui era legato alla ruota del destino. Avevo maturato quell’idea quando a undici anni mi aveva salvato la vita: ci sono momenti nell’infanzia in cui il futuro fa capolino e quel giorno avevo intuito che tra me e Guglielmo non sarebbe finita lì. Finché morte non vi separi, avevo sentito bisbigliare una voce quella mattina di nove anni prima.
«Vuoi guidare una rivolta?» gli domandai, immaginando che avesse deciso di impegnarsi in prima persona nella battaglia cittadina.
«Non è qui che si decide il destino di Genova.»
«Ah no? E dove mai si deciderebbe secondo te?»
«A Gerusalemme.»
«A Gerusalemme?» La parola mi si incastrò in gola. «Scusa se te lo ricordo, ma è dall’altra parte del mondo.»
«Ti sbagli, è di strada. Sulla nostra strada.»
Dato che la geografia non era il suo forte, provai con la politica. «Non hai sentito le autorità?»
«Se le autorità pubbliche voltano le spalle alla giustizia, saranno i privati cittadini ad abbracciarla.»
«Guglielmo, non verrà organizzata alcuna spedizione in Terrasanta.»
«Invece verrà organizzata.»
«E da chi, si può sapere?»
«Da due persone che conosci molto bene.»
Per quanto mi sforzassi di pensare non riuscii a trovare tra i miei amici due uomini così folli, e dire che di pazzi testardi ne avevo incontrati un bel po’. Ma poi all’improvviso capii, e credo che sbiancai perché Guglielmo sorrise e annuì con felicità fanciullesca. «Proprio così. Tu ed io.»
Ed io. Sì, Dio. Ecco quello che ci sarebbe voluto.
![]()
2
Guglielmo era convinto che una persona non è niente, ma due sono una città.
E che due uomini grandi possono mettere in piedi una grande città. Avevo sentito parlare di Romolo e Remo? Io avevo altre idee, decisamente meno eroiche, ma poiché lì a Genova non facevo altro che perdere la guerra cittadina, non vedevo perché non sarei potuto andare altrove per perderne un’altra. Almeno avrei visto terre nuove. E per giunta sante.
Lui disse che si sarebbe occupato di reclutare gli uomini, perché era una questione di cuore, e a me affidò il compito di liquidare la sua parte di eredità paterna per racimolare i soldi necessari ad armare una nave, perché era una questione di soldi, ed io parlavo meglio quella lingua.
Non mi domandò nulla, se non di accompagnarlo, ma quando si parte per quel genere di viaggio non bisogna lasciarsi niente dietro e così anch’io liquidai la quota che mi spettava di patrimonio familiare. Con alcune operazioni azzardate riuscii a raggranellare i mezzi per allestire non una, ma due galee. D’altra parte, con la guerra d’oltremare che volgeva al peggio, aumentando la minaccia di nuovi attacchi della pirateria saracena, i prezzi delle galee erano scesi parecchio negli ultimi tempi. Il mare non era precisamente il più sicuro degli investimenti.
La prima nave la comprai da Ugo di Piazzalunga, un mercante che per anni aveva commerciato in aromi e spezie per produrre farmaci e profumi. Gli aromi arrivavano dall’Oriente via carovana fino ai porti del Libano e della Siria, dove Ugo li acquistava in cambio dei tessuti nordici che si procurava all’annuale fiera di Asti. Una catena lunga dai mari del Nord fino alle steppe asiatiche, e altrettanto lucrosa, che però era stata recentemente troncata. L’espansione dei turchi oltremare, con la conseguente cacciata di bizantini e arabi dai porti mediorientali, aveva infatti deviato il traffico carovaniero e messo la parola fine alla decennale attività di Ugo di Piazzalunga. La parola successiva con cui aveva avuto a che fare era debito, la prossima sarebbe stata fallimento. Termini indigesti per ogni genovese che si rispetti.
Ugo era troppo avanti negli anni per cercare nuove rotte, e in ogni caso si era messo da parte un discreto gruzzolo. I figli, inoltre, avevano preferito investire i frutti delle avite imprese marinaresche nella terra.
«Tu non mi chiedi di venderti la mia nave, ma di regalartela in cambio di un piccolo dono» mi accusò con veemenza Ugo.
«Allora tienitela pure e portala sui campi comprati dai tuoi figli. Sono sicuro che farà la sua figura, a navigare sulle zolle.»
Alla fine, dopo avermi maledetto e insultato come se gli stessi portando via un polmone, mi vendette la galea a un quarto del suo effettivo valore pur di liberarsene.
«Patirò la fame a causa tua» mi rimproverò.
«Il digiuno allunga l’esistenza.»
«Niente come le privazioni l’accorciano. Mi hai tolto cinque anni di vita.»
«E non sei contento? Così sara...