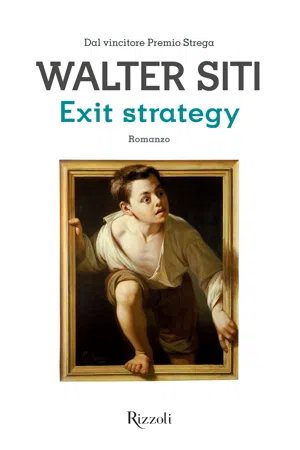![]()
1
Roma palindroma
9 gennaio 2011
La gente è ancora in preda a shopping compulsivo, non si rassegna che le feste siano finite; assediano Foot Locker e perfino la farmacia (compreranno tisane, tavolette dietetiche, zapatos anatomici, saponette a basso pH?); da Franchi in Cola di Rienzo hanno esposto un cartello, “saldi sul caviale”. Sconto del trenta per cento; del cinquanta sul capitone. Pare che le anguille lasciassero i fiumi europei per andare a riprodursi nel Mar dei Sargassi già centinaia di milioni di anni fa, quando era (per così dire) il mare sotto casa; poi la tettonica a placche e la deriva dei continenti hanno progressivamente allontanato il luogo d’affezione e adesso le anguille per accoppiarsi percorrono più di seimila chilometri. Di anno in anno allungavano un po’, senza accorgersi del cambiamento. “È così che ci si adatta”; “ti sbagli, è così che gli stupidi insistono anche quando non sarebbe più il caso”.
L’avvenimento è minimo, un derby all’Olimpico e le strade chiuse o intasate: impossibile secondo Marcello raggiungere casa mia («dall’Acqua Acetosa nun se passa e sotto la galleria me fanno sbucà manca poco a Ottavia, ma che so’ matti?»). Con l’amatriciana già pronta propongo percorsi alternativi, tornare indietro e scendere dai Parioli o addirittura l’Aurelia.
«Nun me va, a Wa’… ’n artro giorno a te che tte cambia?»
«Sei la solita sòla… vabbe’ rimandiamo a domani, dài.»
«Domani ce starebbero un po’ de impicci, giovedì sicuro…»
«Giovedì non ho tempo io, ormai la settimana prossima… o anche alla fine del mese, almeno risparmio.»
«Che stronzo! seh, mo’ a Pasqua… venerdì no?»
«Non lo so, ti chiamo nei prossimi giorni e ti faccio sapere.»
«Mica è colpa mia, oh… te sei incazzato, ve’?»
«Non è mai colpa tua.»
«Io so’ innocente de natura, l’hai pure scritto… porcoddue, me stanno a puntà i viggili, ciao ciao… chiama quanno te pare.»
Episodio minuscolo di una storia quasi decennale. Sofferenza, again? Ma cos’è che mi taglia il respiro in queste circostanze, santo dio? Che cosa mi viene a mancare, di che cosa ho tanta agonia? La scopata no, l’ho posseduto quasi cinquecento volte (quattrocentosettantanove, a esser precisi), posso ricostruire a memoria ogni posizione e ogni mucosa; né la conversazione di routine, né quei quattro sorrisi tirati via o le pose a vantare una forma più millantata che reale – magari qualche gocciolina di sudore sulla nuca fresca di barbiere.
Il primo dato empirico è che ho voglia di vomitare, mi butto sul letto a pancia sotto e l’idea di qualunque cibo mi disgusta; dunque la prima cosa che mi viene a mancare è l’appetito. Non solo di cibo, naturalmente: un’astenia più generale e vasta, basterebbe una telefonata e giovedì ci potremmo vedere, ma perché? A rinnovare che cosa di ormai fossile? È difficile inventarsi un amore se l’altro non collabora. Cosa chiedo, in definitiva, alla sua presenza? Non sarà per caso un’intercapedine? Mi manca di riempire quest’ora che avevo programmato di riempire con lui; mi manca che a lui quest’ora non manchi, che stia già viaggiando sul raccordo con un peso in meno. Se lui fosse qui, controllerei il movimento. Potrei, per un’ora, abitare uno spazio da cui il movimento è abolito.
Mi manca di occupare un tempo che quando io non ci sono lui dedica a quell’altro (che ho finto via via politico verde e antiquario ma che è semplicemente regista teatrale); la guerra è la vita della società, o come diceva Eraclito è la vita della vita stessa. Dunque se Marcello fosse qui potrei sentirmi in pausa dalla guerra e in vacanza dalla vita, sospeso sul mondo e isolato dalle cose; quando dico che lui mi riempie la settimana intendo dire in realtà che me la svuota, che mi libera dal tempo. Tutto scorrerebbe senza incidere; mi manca che, con lui qui, il mondo avrebbe uno scopo senza bisogno che altri lo condividano. Sotto il fastidio animale di un’abitudine turbata serpeggia un’inquietudine più filosofica; mi manca l’autorizzazione a disertare, la garanzia che non mi dimenticherà nei suoi percorsi (quelli ultraterreni, non quelli a San Basilio). Non mi manca il suo corpo ma la certezza della sua visitazione.
Marcello è un grande albero che fa ombra. “Gli angeli più intelligenti” scrive Swedenborg “hanno vesti scintillanti come fiamme; i meno intelligenti hanno vesti candide però senza splendore, e quelli che sono ancora meno intelligenti hanno vestiti colorati; ma gli angeli del cielo intimo sono nudi.” Il mio “non ho tempo” sa troppo di ripicca, la cosa più lontana dall’indifferenza che si possa immaginare. Eppure questo derby dovrò perfino ringraziarlo: sia perché mi ha fatto riprovare la sensazione piacevole (per me in questi ultimi tempi sempre più rara) di non saper controllare le mie emozioni, sia perché mi ha dimostrato che la morsa si sta allentando; che il lessico religioso usurato germoglia sempre più fiacco e la schiavitù impallidisce. Mi manca ciò che provavo cinque anni fa. Senza il potere taumaturgico della sua visita, ho pensato, stanotte non dormirò – invece ho dormito come un ghiro e mi sono svegliato con una musica in testa (“che mele, che mele! son dolci come il miele / son rosse, son grosse, son pronte da mangiar”). Ho sognato che Marcello era un ciliegio frondoso, incurante dei frutti che i ragazzi gli rubavano dai rami. Per lui non avere volontà è normale: domani sarò libero di convocarlo o no, non si stupirà comunque. “La volontà è il secchio rovesciato in cortile dal calcio distratto di un piede che passa.”
Tutto fila liscio fin che funziona la collaudata macchina gnostica: fin che Marcello è qualcos’altro, il suo posto nella mia vita è sicuro. Se dico «è una lente convessa, che concentra il suo fuoco su dettagli quotidiani e li santifica», o se lo leggo come un trattato sulla curvosità, un infinito anello di Moebius di cui è impossibile dipingere un lato senza dipingere l’intero, allora le molecole del suo corpo si trasferiscono nella zona dell’anima sottile e non mi è difficile riesumare alla memoria gli istanti di passione. Quand’ero così pieno di metafore (che lui mi dettava) da non temere le letteralità più crude – al punto che sulla terrazza dell’hotel Baglioni a Firenze un amico dovette moderarmi perché dai tavoli vicini appizzavano le orecchie, trascuravano la colazione e stavano già partendo frizzi e proteste. O quando sul lungomare di Venice toccammo insieme un serpente, credo un pitone accoccolato al sole tra le braccia di un fachiro hollywoodiano – quello stesso gesto, di toccare un serpente addormentato o una reliquia d’oro, ruvida e calda, lo replicai sul letto dell’albergo mentre Marcello guardava su un televisorino da pochi pollici un film di Harry Potter senza capire l’inglese. Il tremore della mano che non sapeva quando e dove posarsi, su quale gruppo di muscoli per non disturbarlo, il suo torpore e il mio batticuore, l’esotica tripudiante ipocrisia di esonerarsi dall’esito di nozze già approvate in cielo. O quando (finalmente posso raccontare quei pochi minuti che nel libro di viaggio ho dovuto censurare sotto un’ellissi pudica) Marcello si costruì il suo teatrino a trenta chilometri da Dubai, resort artificiale per una artificiale luna di miele – e sulla piattaforma rotante in vista del deserto mi rubò il cuore sborrando di fantasia, stropicciando e schiacciando sul materasso il poster gigante di una playmate che lui fingeva di trombare mentre ben altro era quel che sentiva e gridava («sì sì, j’oo sto a sbatte dentro, ah che bello sì… fammelo sentì dentro, bello grosso dài»), tra lo stupore degli orici.
Ma fuor di metafora, nella razionale prigione in cui Marcello non può negarsi come individuo socialmente determinato, compaiono gli incidenti e le stonature; a partire da quel guazzabuglio stridulo di spintoni e cambiali che ho provato a cancellare retrocedendolo al rango di incubo, ma la bisca me la ricordo bene, e le fotocopie con la falsa assicurazione dell’auto, e le minacce e le lacrime e il mio portafoglio barbaramente saccheggiato. O la cocaina a Bologna, quando mi chiusi in bagno per il martellare alle tempie – e il dolore al braccio trascinando la valigia alla stazione protrattosi nei giorni seguenti fin che la cardiologa non escluse l’infarto («se le fa male a premere, è più probabile la fitta intercostale»), e il fioretto di non ripetere l’esperimento mai più, io con le sinapsi ci lavoro. (Però però, che autentica quella premura marcelliana, «nun venì, dài» col calciatore terzo incluso, per timore che poi, data l’età, non potessi raddoppiare con lui.)
La sedicente realtà consequenziale e materiale m’ha regalato il peggio e il meglio, un gioco a nascondino da perfetto semidio. Ho conosciuto la sua verità d’uomo affettuoso: un escort non lo pulisci dalle feci quando si vergogna di chiamare l’infermiera. Ma se il cane dei proprietari (nella villa affittata per girarci una fiction sulla Uno bianca) gli annusa il culo mentre nudo ti sta inginocchiato davanti, come fai a non sentirti coinvolto in un sozzo girotondo di bestialità? Quante telefonate umilianti m’era costato quel piccolo ruolo, e lui lì a stuzzicare una sua ex per convincerla a concedersi ar Zagaja («mòllajela ’na vorta, porello, prima che je danno er definitivo»), sennonché lei si sottraeva perché quel pregiudicato lo trovava troppo atipico («e si m’ammazza?»). Questa vita che si crede intensa non la voglio più, ma non ho niente con cui sostituirla.
La falsa assicurazione costa solo cento euro e ti procura tutti i documenti per la polizia stradale, ma non ti garantisce contro i sinistri. Io mi sentivo più o meno così frequentando il suo ambiente, le bistecche extra size, gli sfottò in palestra davanti alla leg press, il Moulin Rouge sulla Portuense (“indossa il preservativo, l’Aids uccide” su un cartello, e sotto a pennarello “mejo, che finimo prima”), il rumeno con un arnese enorme («oggi m’è piaciuto, oh, l’ho detto»). Le serate tossiche dedicate al travestimento.
«Me so’ acchittato, ho fatto ’a lampada, me so’ levato pure er pelo…»
«Ma non il vizio…»
«Stasera i negri chi li porta?»
«E tu’ moje?»
«Meno ’a vedo, mejo sto.»
«Quella mica piscia da ’e ginocchia, ha sgamato… se dà dda fà pure lei, t’oo dice ’n ignorante.»
«Cià i jeans co’ ’a vita tarmente bassa che si se strigne ’a fibbia se fa ’n ditalino…»
Le treccione bionde tirolesi di Fausto e Maurizio, i due gemelli barbarians, e il sogno in cui Chiara ci spiava dal fondo buio della stanza avendo accanto un obeso florido, eppure Marcello mi tranquillizzava «è ’na fase nòva der matrimonio, nun te preoccupà». La violenza e l’ingiustizia incarnate nei suoi quadricipiti gonfi come tascapani di nuvole, erotomania quale superamento dell’umano; ma l’incarnazione sempre più irrancidita e risaputa in una tavola d’equivalenze lacunosa, sempre più insidiata dalla noia di quei viaggi con un unico obiettivo – a Praga non s’è nemmeno accorto che ci fosse un fiume. Che rumore fa un assoluto che cade?
“Mica sarai così nazista da mollarlo perché invecchia?”
Come spiegarglielo, a chi mi rimprovera per la mia incostanza, che la persona e il simbolo hanno traiettorie disuguali? Quel che per la persona sarebbe una declinazione commovente, per il simbolo assume i tratti della slealtà. Marcello mi bacia sulla pelata, di slancio dopo un orgasmo, e mugola «mmmh, perché nun posso abità qui?»; sui miei cuscini s’addormenta subito, li proclama i migliori, e sulle strisce pedonali di via Leone IV intreccia le dita gelate alle mie («se vede che i Tori, oh, ce l’hanno bollenti per natura»). Una convivenza fantasma, di pura proiezione come un castello di fumo che le frustrazioni alimentano e che basta uno strattone del legittimo guinzaglio coniugale a disperdere in un attimo. Se lo chiamo a metà settimana per sapere come sta, mi risponde «grazie della telefonata»: formula inedita che a stento riconosco sua. Non è abituato alla solitudine e, ora che la moglie è sempre in giro per via della politica, pur di sentire la mia voce (o quella di quell’altro, non mi illudo) si inventa assurde richieste: se nella carbonara ci va la cipolla o se le ultime cifre dell’Iban corrispondono al codice del bancomat. Io gli griderei ti amo, mi strapperei ancora il cuore per farlo contento ma mi trattiene una barriera archeologica: uno strano Ercole d’epoca alessandrina esposto a palazzo Massimo – un Ercole di mezz’età, borghese e ingrassato, con quella che dovrebbe essere una pelle di leone ma che ha tutta l’apparenza di un cappotto di astrakan aperto sul seno abbondante.
Eccolo il tradimento: non la decadenza fisica in sé, naturale, ma il non essere più all’altezza del proprio mandato metafisico.
«Nun me faccio più de gnente (lo piagnucola come un bambino che aspetti un premio)… er bicipite s’è strappato in du’ punti… eh, ero nervoso come ’n babbuino, nun dico depresso ma… la giovane promessa, ariverai lontano, come no, ’o vedi ’ndo so’ arivato… tutto er male nun vié pe’ nuocere, sai quanto me durano mo’ ’sti soldi… te sei sempre er punto mio de riferimento, si me dài coraggio ce posso pure riprovà… pe’ ji over quarantacinque ciò meno concorrenza, er bicipite così strappato pare pure più rotondo, du’ mesi a tavoletta e m’ii magno…»
Lo diceva per gli over quaranta e lo ripeterà per i cinquanta senza mai muovere un dito; i campionati non ci sono nemmeno più, il bodybuilding è passato di moda. Filastrocca di allori che gira a vuoto, anche se la mitologia lo assolve. Secondo la Biblioteca di Apollodoro, Ercole fece un gran casino per rubare le mele d’oro delle Esperidi (uccidere Anteo, liberare Prometeo, reggere la volta celeste eccetera) – ma quando Euristeo le ebbe toccate gliele ridiede e lui allora le restituì ad Atena che le riportò alle Esperidi perché così era giusto. Per i corpi gloriosi, l’inutile circolarità è un obbligo sublime; il deus otiosus ha ancora una funzione, di conservazione del paradosso e del segreto.
Quel che mi scava un solco di rancore è vederlo triste retorico illuso che raddrizza lo shape come se potesse ancora scatenare desideri, senza accorgersi che i deltoidi troppo larghi lo fanno assomigliare a una stampella per armadi – rotto e rimesso insieme come la Creatura del dottor Frankenstein. È il vorrei-ma-non-posso del travet, la parodia, la presa per i fondelli cosmica; il suo corpo mi infastidisce proprio perché ha l’impudenza di alludere al corpo dolcissimo che ancora mi attrae. Come si permette? I corpi detentori d’infinito sono più fragili delle ali di un insetto. Lo accarezzo come una provincia decaduta che non vale più la pena di possedere; o se lo possiedo è per rassicurarmi che non mi fa più niente, come un animale spelacchiato il cui solo ruggito riempiva la foresta di terrore (è questo dunque che mi manca, qualcosa che mi faccia paura dietro il velo del mondo?). Come osa, dopo la selezione di big cocks su Bulk Tube, parlarmi di Atac e di Ama, bussare a regalini e lamentarsi per il mal di stomaco?
«Almeno un par de mutanne m’ee potresti comprà…»
“Nello sguardo impaziente si sostituisce senza posa all’assoluto la forza inesorabile del cattivo infinito.” Stare con lui non ha più senso ma tutto il resto ne ha ancora meno. Il nostro rapporto umano è amministrazione burocratica, bilancio ancipite e ritroso, mentre la staffetta dei fuochi rischia di morire per colpa sua; una pirotecnia così rapinosa non esiste più, come faccio a perdonarlo? Come aprirmi di nuovo ai pendii innevati, se basta una sua visita ad afflosciarmi il pneuma immortale?
19 aprile 2011
Non sono mai stato bravo a descrivere le folle: la massa indistinta e il corteo oceanico mi paralizzano, il loro muggito mi incute diffidenza. Non amo incoronazioni, partite di calcio, dichiarazioni di guerra. Mi riescono meglio i gruppi limitati: una cena, una palestra, un consiglio di facoltà, un briefing. Eppure stavolta devo cimentarmi, lo spettacolo è troppo interessante e, come si dice, emblematico – un’intera nazione si accalca ai cancelli e al buco della serratura. Dal cortile di palazzo Grazioli la marea umana si stende all’indietro su corso Vittorio e piazza Venezia, poi risale via !IV Novembre e i colli e le stazioni, da Roma raggiunge Orvieto. Dalle Marche e dalla Lunigiana aggirano l’Appennino, tutta la pianura padana preme su Milano; suonano i clacson in autostrada, intasano le circonvallazioni; unico è il chiacchiericcio, una la curiosità. Si dirigono verso la Brianza, oltrepassano la reggia di Monza senza degnarla di uno sguardo; dal Nordest arrivano in Lombardia scavalcando l’Adda, dal torinese assediano Meda e Saronno, si stendono in cerchi famelici intorno ad Arcore, bivaccano nel viale d’accesso di villa San Martino. Rimbalzano le voci, le onde radio, i ponti televisivi; da Genova e da Napoli partono i piroscafi, gli yacht, i gommoni, le pesanti corazzate della Toremar e della Costa Crociere. “Che ha detto la Minetti? E Marystel come ha risposto? Allora c’era Topolanek?” Camicie precocemente estive sgomitano agli approdi trascinando per un braccio i figlioletti restii – lungo la Costa Smeralda fino alla villa favolosa, quella del vulcano e dei gelatai, e la collezione di cactus giganti e i tetti di tegole rosse da frugare col teleobiettivo. Grazioli-San Martino-Certosa: triangolo di forze che ipnotizza l’Italia incantandola in un frinire di onde elettromagnetiche. Gli stacchetti, le farfalline, le bandiere; poi anche la tomba monumentale di granito nel parco, le case per i terremotati venute su dal niente in una notte, il ragazzino fatto uscire dal coma col solo esorcismo della voce; ma ancora e soprattutto gli anellini, i tubini, piccola chincaglieria che ammalia e rapisce col suo metallico carillon.
“Punta sul francese che lui sbrocca…”
“Anche la Lisa ha avuto il suo momento…”
“Dopo m’ha dato il braccialetto, ma con un diamantino piccolo…”
“Barbara dài, questi sono solo gli inizi…”
“Le russe no, che sono troppo alte.”
“Vuole che noi coloradine andiamo stasera…”
“Ma come, viene ’sto cesso umano, che non ha capelli, e gli dài venti rose? e a questa che è bella e ne fa di ogni gli offri solo five flowers?”
“Ha chiesto all’onorevolessa ‘per disfare il bagaglio e sistemarmi la biancheria ci pensi tu?’… ma ti rendi conto? roba da m...