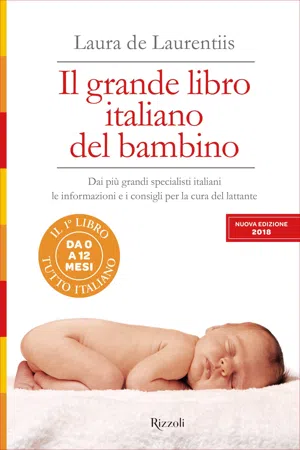
eBook - ePub
Il grande libro italiano del bambino
Dai più grandi specialisti italiani le informazioni e i consigli per la cura del lattante
- 374 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il grande libro italiano del bambino
Dai più grandi specialisti italiani le informazioni e i consigli per la cura del lattante
Informazioni su questo libro
Nuova versione ebook aggiornata 2018 Dal "Bambin Gesù" al "Gemelli" di Roma, dal "Gaslini" di Genova all'Università di Padova, dal Policlinico di Milano all'Istituto Superiore di Sanità: le voci più autorevoli della medicina italiana vi guideranno durante i primi dodici mesi di vita del vostro bambino.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Il grande libro italiano del bambino di Laura De Laurentiis in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788817047951eBook ISBN
97888586663261
I primi giorni
Ènato, è nata: il suo primo vagito, pieno di forza e vigore, è servito a far espandere i polmoni e, quindi, a consentire l’inizio della respirazione autonoma, grazie a cui il bebè può cominciare la vita fuori dall’utero. Il parto è stato un’avventura impegnativa anche per lui (per lei), ma per riposare c’è ancora tempo: dopo essere stato adagiato per qualche minuto tra le braccia della mamma (ed eventualmente attaccato al seno), il neonato viene sottoposto ad alcune pratiche, considerate irrinunciabili sia per il suo benessere psicofisico, sia per garantirgli una tempestiva assistenza in caso di problemi.
Vediamo con la dottoressa Maria Pia De Carolis, neonatologa, ricercatrice del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma, che cosa succede al bambino nei giorni della degenza in ospedale.
Subito dopo il parto
Subito dopo la nascita, e immediatamente dopo aver emesso il primo vagito, il bambino viene posto, ancora nudo e bagnato, sulla pancia della mamma, in modo che la sua testina poggi vicino al cuore di lei. Così il neonato ritrova i suoni familiari (il battito del cuore e il respiro della mamma) che lo hanno cullato durante la gravidanza e ne viene tranquillizzato. Impara anche a conoscere l’odore della pelle materna, che per mesi e mesi eserciterà su di lui un’immediata azione calmante, comprovata dal fatto che, a volte, per favorirne l’addormentamento basta mettergli vicino un indumento indossato in precedenza dalla mamma (a proposito dell’effetto dell’odore materno sul bebè vedi anche capitolo 9 “Psicologia: quel che serve sapere”).
Ma il cerchio magico in cui mamma e bambino si vengono a trovare immediatamente dopo il parto viene giocoforza spezzato: non può, infatti, passare troppo tempo tra la nascita e il taglio del cordone ombelicale che tiene il bimbo ancora collegato alla placenta, che verrà espulsa di lì a poco. In genere, se il bambino sta bene, il taglio viene effettuato dopo qualche minuto dalla nascita, per permettere un adeguato passaggio di sangue dalla placenta al neonato, con il bimbo poggiato sul ventre della mamma.
Per il taglio del cordone (o funicolo) in alcuni ospedali viene coinvolto il papà, se ha assistito alla nascita e quindi è presente in sala parto. Questo straordinario compito è naturalmente facoltativo e rappresenta un gesto di grande valore simbolico, senza dubbio fonte di un’emozione intensa, poiché consente all’uomo di ricoprire per la prima volta un ruolo attivo rispetto al figlio. Se il neopapà accetta l’opportunità, viene guidato nell’operazione (assolutamente indolore sia per la neomamma, sia per il neonato) dall’ostetrica o dal ginecologo.
Non sempre però la routine ospedaliera prevede questa possibilità, così come può accadere che il medico o l’ostetrica ravvedano la necessità di tagliare il cordone più in fretta di quanto lo potrebbe fare il neopapà.
Dopo il taglio del cordone ombelicale, il neonato viene preso in braccio dalla puericultrice (figura ancora presente in alcuni ospedali), dall’infermiera del nido oppure dall’ostetrica, a cui spetta il compito di fargli il primo bagnetto. In molti ospedali, il neopapà viene invitato a seguire questo primo rito o anche a parteciparvi. Dopo aver lavato e ben asciugato il bebè, la puericultrice ha inoltre il compito di pesarlo e di rilevare la lunghezza e la circonferenza cranica.
Quindi lo veste e, particolare buffo, anche se di capelli il neonato di solito ne ha pochissimi, lo pettina con una spazzolina morbida e gli copre il capo con un berrettino.
Per l’identificazione viene allacciato al polso del bambino e della mamma un braccialetto di plastica trasparente che riporta il cognome e un numero, quello del parto. Entrambe le indicazioni scritte vengono fatte controllare dai genitori.
In genere è a questo punto, se tutto è andato bene, che arriva il pediatra-neonatologo per effettuare il primo esame clinico. Lo specialista, dopo aver raccolto le informazioni sull’anamnesi (storia clinica) materna, sulla gravidanza e sull’età gestazionale del neonato (durata in settimane della gravidanza), lo visita.
L’esame clinico in sala parto ha lo scopo di controllare i parametri vitali (“indice di Apgar”, vedi paragrafo seguente, “I primi controlli sul bambino”) e di escludere che siano presenti malformazioni. Lo specialista verifica la cosiddetta “pervietà delle coane”, cioè che vi sia comunicazione tra il naso e la gola, e l’assenza di “atresia esofagea” (è una malformazione dell’esofago). Per finire, con un termometro controlla la “pervietà (apertura) anale” e rileva anche la temperatura corporea che, di norma, non deve essere inferiore ai 36 °C.
Successivamente il neonato viene sottoposto alla profilassi congiuntivale, che consiste nell’applicare negli occhi una piccola quantità di pomata o di gocce antibiotiche per prevenire l’infezione da gonococco, un batterio che può contagiare il bambino durante il parto, al momento del passaggio dal canale vaginale all’esterno. Al piccolo viene effettuata inoltre la profilassi per prevenire la malattia emorragica, che consiste nella somministrazione di vitamina K.
PROFILASSI CONGIUNTIVALE E DELLA MALATTIA EMORRAGICA
La profilassi congiuntivale è detta anche “profilassi alla Credè”, deve essere praticata per legge a tutti i neonati e può essere effettuata, in alternativa alla pomata antibiotica, mediante l’instillazione negli occhi di una soluzione al nitrato di argento all’1 per cento. Il nitrato di argento è efficace, ma può causare congiuntivite chimica, quindi è possibile che venga preferita la pomata oftalmica.
La profilassi della malattia emorragica del neonato si effettua con somministrazione di vitamina K1 per via intramuscolare (1 milligrammo). Il trattamento serve a indurre la sintesi dei fattori della coagulazione (costituzione) che dipendono appunto dalla vitamina K, che nei neonati è presente in quantità scarse.
In camera
Dopo l’espulsione della placenta, che rappresenta l’ultima fase del parto, detta “secondamento”, passate circa due ore in osservazione la neomamma viene accompagnata nella sua stanza dove fin da subito può lavarsi (se ne ha voglia, farlo rigenera e aiuta a recuperare più in fretta le energie), rilassarsi e anche ristorarsi con una bevanda o con qualche biscotto o cracker. Se ha la fortuna di aver partorito in un ospedale dove è adottata la formula rooming-in, nell’arco di poco tempo avrà la bellissima sorpresa di vedere entrare la puericultrice con il bambino adagiato nella sua culla a ruote.
Il vantaggio di questa soluzione è enorme sia per la madre, che può prendere tra le braccia suo figlio e offrirgli il seno ogni volta che lo desidera, sia per il bambino, che può godere del rassicurante contatto con la sua mamma. Anche il neopapà se ne avvantaggia, perché in questo modo gli viene risparmiato il ruolo di semplice spettatore a cui viene concesso di guardare il figlio attraverso un vetro, senza avere neppure la possibilità di toccarlo.
Le quattro possibilità
La degenza del bambino in ospedale può svolgersi nella nursery o nella stanza della mamma, il cosiddetto rooming-in, che a seconda dell’organizzazione dell’ospedale può essere di tre tipi:
- È definito rooming-in totale (o integrale) quando prevede che il neonato sia sistemato nella stanza con la mamma 24 ore su 24, a partire da subito dopo il parto. In questo caso, la mamma può gestire completamente il suo bambino, sia cambiandogli il pannolino quando è necessario, sia attaccandolo al seno “a richiesta”, anche ogni volta che il piccolo piange. Non tutte le neomamme apprezzano però una simile soluzione, soprattutto se sono state sottoposte al cesareo e, quindi, si sentono ancora un po’ deboli o indolenzite dai punti di sutura applicati sull’incisione prodotta dal bisturi. In questa eventualità si può rinunciare alla formula integrale e chiedere che il bebè venga accolto nella nursery, da dove è comunque possibile prelevarlo (o farselo portare dalle puericultrici) all’ora della poppata o in altri momenti della giornata.
- C’è poi la formula rooming-in giornaliero, che consiste nel far rimanere il bambino nella stanza con la mamma durante il giorno, per poi accoglierlo nella nursery nelle ore notturne. Per la poppata di mezzanotte il bambino viene portato alla mamma dalle infermiere addette al nido. Anche nel caso di rooming-in giornaliero si può chiedere alle puericultrici di tenere il bambino nella nursery per alcune ore del giorno, se ci si sente troppo stanche per accudirlo o anche solo se si avverte il bisogno di dormire il più possibile per recuperare le forze prima del ritorno a casa.
- Infine esiste la formula nido aperto, che concede alla neomamma la possibilità sia di tenere accanto il bambino per il tempo che desidera (anche per l’intero arco delle 24 ore), sia di affidarlo alle cure del personale specializzato della nursery. Questa formula è la più apprezzata dalle neomamme per la sua estrema flessibilità.
- Ci sono anche ospedali che per ragioni logistiche non possono offrire alle mamme il rooming-in. In questo caso, il bambino rimane tutto il giorno nella nursery e viene portato alla mamma solo per la poppata, ogni tre-quattro ore circa. Da qualche tempo, comunque, nelle strutture prive di rooming-in vi è molta più elasticità che in passato: le mamme possono entrare a loro piacimento nella nursery almeno durante il giorno, per stare vicino al loro bebè, accarezzarlo e abbracciarlo per un arco di tempo più lungo rispetto a quello concesso dalle sole poppate.
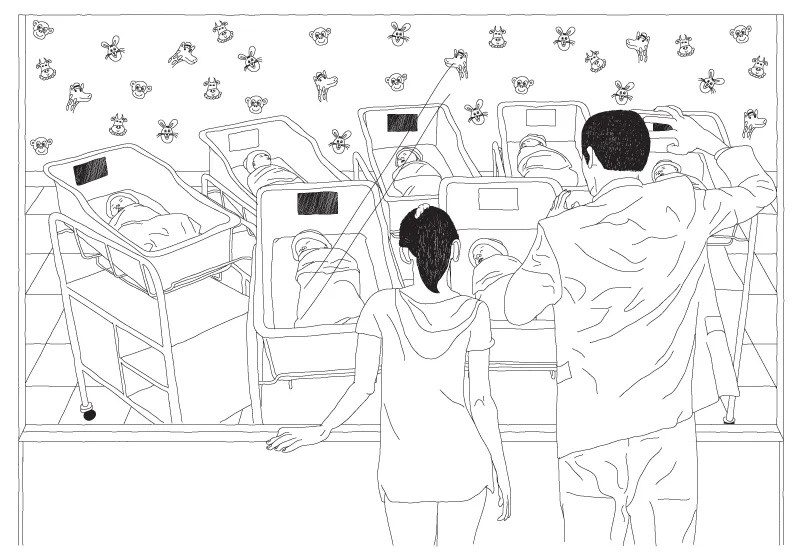
In alcuni ospedali, invece, il tipo di organizzazione non prevede nulla del genere, per cui il bambino viene portato alla mamma solo al momento della poppata e poi riportato nella nursery. Alla cura del piccolo (cambio del pannolino, bagnetto) provvedono le infermiere del nido. Naturalmente, in assenza del rooming-in, il papà ha la possibilità di avere solo brevi contatti con il bambino.
Una precauzione utile
Il rooming-in è senza dubbio la formula che consente al meglio l’instaurarsi del legame profondo tra madre e bambino, il cosiddetto bonding, e l’avvio e il proseguimento dell’allattamento al seno. Al momento delle visite, anche se il regolamento dell’ospedale non lo impone, è comunque consigliato portare il bambino nel nido e lasciarcelo fino a quando parenti e amici se ne saranno andati. Diversamente lo si espone al rischio di venire a contatto troppo precocemente con virus di cui i visitatori possono essere veicolo. Anche dopo la dimissione dall’ospedale il bambino va tenuto lontano da chi ha il raffreddore e la tosse. Nel caso in cui siano la mamma o il papà ad avere un’infezione delle vie respiratorie è consigliabile che si occupino del bambino indossando una mascherina. I virus respiratori si trasmettono, infatti, attraverso le goccioline di saliva che inavvertitamente si emettono non solo quando si starnutisce, si tossisce, si ride, ma anche mentre si parla.
I primi controlli sul bambino
Durante i giorni della degenza in ospedale, il neonato viene sottoposto ad alcuni controlli che servono a verificare il suo stato di salute generale.
La prima pagella: la primissima valutazione, volta a definire la vitalità del neonato subito dopo la nascita e quindi il suo adattamento alla vita extrauterina, è definita in base all’“indice di Apgar”, così chiamato dal cognome dell’anestesista-ostetrica statunitense (il suo nome era Virginia Apgar) che nel 1953 lo ideò. Questo indice, effettuato dall’ostetrica, dal ginecologo o dal pediatra (se presente in sala parto) a un minuto e poi a cinque minuti di vita, considera cinque parametri:
- battito del cuore
- respiro
- tono muscolare
- riflessi
- colorito.
A ciascuna di queste caratteristiche viene attribuito un punteggio che va da zero a due: si assegna il valore di due agli stati di assoluta normalità, il valore di zero alle anomalie maggiori e uno agli stati intermedi.
Il punteggio massimo, pari a 10, viene attribuito se il battito del cuore è maggiore di 100; il respiro è vigoroso con pianto energico; i movimenti (in particolare quelli di braccia e gambe) sono decisi, il viso si contrae in varie smorfie, la pelle del corpo e del viso è tutta rosea.
Il neonato con un buon adattamento alla vita extrauterina ha un indice di Apgar superiore a sette, sia a uno, sia a cinque minuti di vita. Un valore compreso tra quattro e sei corrisponde a un moderato grado di non perfetto adattamento, mentre un punteggio inferiore a quattro, in qualsiasi momento nei primi minuti di vita, esprime un adattamento respiratorio e circolatorio non pienamente efficiente e richiede l’intervento dei medici.
L’analisi del sangue: al momento della dimissione tutti i neonati vengono sottoposti allo “screening neonatale”, per poter individuare tempestivamente la presenza di alcune malattie congenite (per esempio la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo, la fibrosi cistica, la sindrome adreno-genitale), la cui diagnosi precoce, mediante terapia specifica, consente di prevenire danni irreversibili. Il prelievo di sangue viene eseguito al momento della dimissione attraverso una puntura sul tallone.
La fenilchetonuria è la più comune malattia congenita che interessa il metabolismo degli amminoacidi. L’accumulo nel sangue dell’amminoacido fenilalanina, che non viene metabolizzata a causa del deficit di un enzima specifico, comporta gravi danni neurologici che si manifestano tardivamente. Si riscontra con una frequenza di un neonato ogni 10.000-12.000 e la riduzione precoce dell’apporto alimentare della fenilalanina (che viene pianificata con l’aiuto del pediatra al momento dello svezzamento) può evitare il grave ritardo mentale che si manifesta nelle forme non trattate.
L’ipotiroidismo congenito ha una frequenza molto elevata (nel mondo colpisce un neonato ogni 3000-4000) e nella maggior parte dei casi è dovuto a un’alterazione o all’assenza dell’attiv...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Il grande libro italiano del bambino
- Introduzione
- 1. I primi giorni
- 2. L’allattamento
- 3. Prendersi cura di lui o di lei
- 4. Il sonno
- 5. A misura di bebè
- 6. Bimbi nati prima
- 7. I gemelli
- 8. Lo svezzamento (o alimentazione complementare)
- 9. I traguardi
- 10. Psicologia: quel che serve sapere
- 11. Può accadere
- 12. Le vaccinazioni
- 13. Dottoressa, cosa ne pensa?
- 14. Il puerperio: dalla parte della mamma
- 15. Test: quanto ne sai sull’accudimento?
- I consulenti
- Copyright