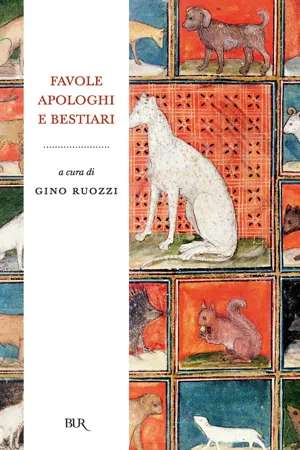![]()
IV
NOVECENTO
dp n="398" folio="382" ? dp n="399" folio="383" ? Le favole del Novecento presentano molti dubbi sul codice di valori da proporre. In buona parte esaurita la spinta educativa dei due secoli precedenti, il Novecento si presenta contraddittorio, in precario equilibrio tra una volontà distruttiva e un costante desiderio di rinascita. Questo Novecento in favole e apologhi si apre con i due maggiori autori italiani di quella che per tradizione è chiamata l’età del Decadentismo o della crisi; crisi di valori e crisi di quelle certezze (o utopie) positivistiche che pure continuarono a nutrire la società in modo sostanziale; lo sviluppo della scienza e della tecnica, la crescita industriale e sociale, la collettiva maturazione politica sono infatti dati effettivi.
Giovanni Pascoli e Gabriele d’Annunzio vivono e interpretano in maniera diversa quest’epoca di imperialismo militare ed economico nel mondo e di Belle Epoque in Europa, di conflitti sociali e di sviluppo del movimento operaio e socialista, di evoluzionismo darwinista, di simbolismo in poesia. Pascoli vive il proprio tempo da protagonista appartato, d’Annunzio da protagonista sul palcoscenico (primo attore su tanti e diversi teatri). L’esibizionismo e l’inesauribile voglia di stupire portano d’Annunzio a misurarsi con la stessa parola biblica e a riscrivere «da avversario» alcune parabole evangeliche, ipotizzando un vangelo alternativo. L’operazione di d’Annunzio non è nuova, specie in età positivistica, quando sono parecchi i testi che indagano in modo critico (storico, filologico e letterario) sulla verità dei vangeli e la storicità di Cristo, dalla Vita di Gesù di Ernest Renan (1863) all’Anticristo di Nietzsche (1888). Qualche anno dopo sulle pagine primonovecentesche della rivista fiorentina «Lacerba» il trentenne Giovanni Papini, già «salvatico» ma ancora lontano dalla clamorosa conversione al cristianesimo del primo dopoguerra, dileggia la chiesa auspicando in «corrosivi aforismi» il cappio al collo per tutti i preti («Se Cristo fosse morto impiccato avremmo la soddisfazione di vedere una forca sopra agli altari e al collo degli ecclesiastici», Schegge, 1913). È in questo contesto e in quest’arco temporale che d’Annunzio scrive le proprie parabole, pubblicate per la prima volta su giornali e riviste alla fine degli anni Novanta (in volume nel 1924), dopo la fine del periodo francescano della bontà e le rivendicazioni di superomismo espresse nel Trionfo della morte (1894) e nelle Vergini delle rocce (1895). L’estetismo, lo spirito di provocazione, la ricerca dell’effetto sorpresa distinguono le parabole riscritte da d’Annunzio (La parabola delle vergini fatue e delle vergini prudenti, La parabola del figliuol prodigo , La parabola dell’uomo ricco e del povero Lazaro); più che la sostanza del pensiero religioso, che resta estraneo a questi testi.
Il genere della controparabola ha avuto un discreto seguito nel Novecento. In questa antologia ve ne sono alcuni esempi; dopo d’Annunzio il primo è quello di Cardarelli, che controinterpreta episodi della Genesi, seguito da Ennio Flaiano, nato nella stessa Pescara (e nella stessa via) di d’Annunzio. Entrambi abruzzesi, entrambi romani di adozione professionale, entrambi uomini di spettacolo, ma radicalmente diversi: prorompente e spaccone il primo, alla perenne conquista di una platea da incantare; disincantato e schivo l’altro, desideroso di «tane» in cui nascondersi. Anche Flaiano riscrive la parabola del figliol prodigo, senza compiacimenti e indugi da esteta; qualche anno dopo la riscriverà pure Sergio Quinzio, questa volta però all’interno di un esplicito (seppure critico) percorso di fede; singolare comunque l’insistenza con cui lungo l’intero corso del secolo si continua a riscrivere e reinterpretare quella che è forse la più nota e insieme misteriosa e irrazionale parabola evangelica. Controparabole ha scritto di recente Guido Conti nel romanzo Il tramonto sulla pianura (2005); e lo sono a loro modo anche i sempre più numerosi apologhi zen che popolano il secondo Novecento attraverso le opere di Italo Calvino, Raffaele La Capria, Ferruccio Masini, Roberto Carifi; controparabole perché prendono a modello non la sapienza cristiana occidentale ma quella alternativa, filosofica e morale più che religiosa, del buddismo zen giapponese e dell’Oriente in generale.
Anche Pascoli scrive parabole, traduce, rielabora, inventa favole, ispirandosi soprattutto ai classici greci e latini. Pascoli è uno studioso, ha fatto propria la straordinaria lezione civile e culturale, erudita e poetica, del maestro Carducci; di fronte al quale rimane però uno studioso minore, meno solido, talvolta più svogliato, senza dubbio originale ed eccentrico (basti pensare alle sue interpretazioni della Commedia di Dante); e soprattutto concentrato sulla poesia, verso cui si indirizzano prioritariamente i suoi interessi profondi. Pascoli scrive favole e apologhi di misura diversa, alcuni brevi, lapidari, quasi scatti fotografici; altri più lunghi e narrativi; traduce Esopo e Fedro, alimentando quella linea di traduzioni d’autore che costituisce una base fondamentale per la fortuna del genere ed è spesso punto di partenza per l’invenzione di nuove favole (anche se già la traduzione è comunque invenzione); si pensi alle traduzioni esopiche di Niccolò Tommaseo, Concetto Marchesi, Pietro Pancrazi. Positivista inquieto, socialista utopista, nelle vesti pubbliche di conferenziere Pascoli immagina e propone mondi di convivenza pacifica (con l’eccezione dei sacri e insindacabili diritti della patria); apologhi, come La giustizia (1901), in cui il dramma violento delle lotte sociali può appianarsi e risolversi nel nome di una superiore saggezza e condivisione umanitaria. Egli compone parabole laiche, di morale pubblica, in cui i valori ideali dello spirito tentano di conciliarsi con i processi concreti della storia.
Ironico, distaccato dalle differenti enfasi dell’uno e dell’altro, è il triestino Italo Svevo, scrittore e industriale, marginale in Italia centrale in Europa, autore di due romanzi tristi (Una vita, 1892, e Senilità, 1898) e di favole che non lo sono meno, ma in cui col tempo si fa strada quel sottile e liberatorio umorismo che porta al romanzo La coscienza di Zeno (1923) e al lungo racconto Una burla riuscita (1927), favola piena di favole. Svevo scrive favole per trent’anni, dalla fine del secolo alle ultime opere narrative. Malinconiche e caustiche, le favole di Svevo nutrono e ravvivano romanzi e racconti, perle che possono sussistere da sole come impreziosire narrazioni di ampio respiro. Anche in questo caso nel pieno rispetto della tradizione del genere, in cui gli animali parlanti accompagnano gli uomini nei pensieri e nei crucci quotidiani. Forse Svevo aveva in progetto un volume autonomo di favole, ma l’intenzione non si è concretizzata.
Opera che invece riuscì al senese Federigo Tozzi con il volume Bestie (1917). Lo scrittore toscano andò oltre, componendo il trittico Bestie, Cose, Persone (il secondo e il terzo rimasero inediti). Contò senza dubbio la suggestione del Bestiario di Apollinaire (1911), uno dei più belli del Novecento. Ma è anche vero che Tozzi si inserisce nella lunga scia dei favolisti toscani antichi e moderni e apre la felice stagione dei favolisti toscani del Novecento, particolarmente generosa nella prima metà del secolo. Non tanto Giovanni Papini e Ardengo Soffici, che pure inserirono favole, apologhi, «storielle tendenziose» nelle proprie opere di frammenti (Schegge e Il sacco dell’Orco per il primo, il Giornale di bordo per il secondo), ma Nicola Lisi, Pietro Pancrazi, Carlo Betocchi, Gianna Manzini, Arturo Loria (emiliano di Carpi ma fiorentino di adozione) e naturalmente Aldo Palazzeschi. In molte di queste favole toscane si respira un’aria diversa da quella mitica e decadente, agreste e colta, cittadina e positivistica di d’Annunzio, Pascoli, Svevo. C’è un ritorno fisico e morale alla campagna e a una supposta purezza del mondo (che non sempre si identifica con l’innocenza); la necessità e la bellezza di uno sguardo aurorale sulle cose, lirico per essenza. Candore e bella pagina si integrano e la favola (morale inclusa) sembra coincidere con la letteratura stessa. Non senza distacchi ironici, specie in Palazzeschi e Pancrazi; o accentuazioni drammatiche, come in Tozzi e Loria (per gli animali di Tozzi si è a proposito parlato di «bestie senza favola»).
Atmosfere lontane da quelle triestine delle favole di Svevo (e talvolta anche di Sa...