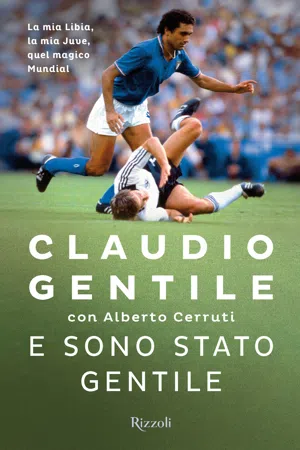![]()
1
La gazzella sparita
La prima notte in Libia, all’Hotel Tibesti di Bengasi, faccio una fatica tremenda ad addormentarmi. Peggio di una vigilia del Mondiale, perché ho troppi pensieri che si accavallano in testa e troppa voglia di andare a vedere come è cambiata Tripoli, per confrontarla con i miei ricordi lontani.
Mi sveglio prestissimo con la fretta di un esploratore che deve scoprire e riscoprire, a cavallo tra passato e presente, ossessionato dall’idea fissa di registrare ogni piccolo particolare nella mia mente. E mentre già immagino quello che racconterò ai miei genitori, scopro quanto mi manca nonna Redenda che aveva aiutato mia mamma a farmi nascere in casa, con una levatrice. Era domenica, un segno del destino visto che quello è il giorno del calcio. Un destino fortunato, grazie anche all’intervento di zio Fernando, il fratello di mia mamma che quel giorno era in casa perché non lavorava. Proprio lui mi ha raccontato di aver fermato appena in tempo la levatrice, che stava per versare l’acqua del parto nel gabinetto. Secondo la tradizione libica, infatti, l’acqua dei maschi va gettata all’aperto, in giardino: porta bene al neonato. Quando ero piccolo non volevo credere a questa storia, ma i fatti hanno dimostrato che sono stato davvero fortunato, e così penso anche allo zio Fernando mentre andiamo, sempre scortati, all’aeroporto di Bengasi, per raggiungere Tripoli.
Gli imprenditori italiani, durante il volo, parlano di lavoro. Cerco di seguire i loro discorsi, ma è impossibile perché, con la scusa della stanchezza, chiudo gli occhi per rivedere il volto di nonna Redenda in questa mia prima mattinata libica. E con lei, improvvisamente, rispunta quella tenerissima gazzella che mi aveva regalato zio Fernando quando avevo quattro o cinque anni. Lui lavorava come meccanico nei pozzi petroliferi nel deserto e proprio nel deserto un giorno raccolse quella gazzella appena nata, che rischiava di essere mangiata da altri animali. Gli fece tenerezza, la prese e tutto orgoglioso, dopo aver attraversato 1.500 chilometri con la sua Fiat, la portò a casa nostra raccomandando a mia mamma e mia nonna di curarla bene, perché voleva che mi facesse compagnia nel giardino dove giocavo con mia sorella più grande.
Anch’io, come lo zio, mi innamorai subito di quella gazzella, così piccola che stava su due mani, ma siccome mangiava soltanto erba mi preoccupavo e pensavo: “Porca miseria, questa muore se non beve mai”. Così, dopo un paio di giorni, decisi di riempire una bottiglia d’acqua e a fatica riuscii a infilargliela in bocca, per farla bere. Poche ore dopo, però, la gazzella si gonfiò, fece strani versi e improvvisamente cadde a terra, morta. Chiamai la nonna che arrivò disperata e mi disse: «Claudio, ma che cosa hai combinato? E adesso lo zio chi lo sente?». Mi spiegò che le gazzelle del deserto non bevono acqua perché si idratano soltanto assorbendo i liquidi delle foglie. Ma io come facevo a saperlo? La nonna Redenda, per fortuna, riuscì a seppellire la gazzella da sola, mentre io piangevo disperato.
«Guai a te se dici qualcosa allo zio, sai quanto ci teneva a questa gazzella.»
«Sì, nonna, ma come facciamo allora?»
«Gli dirò che è scappata e non l’abbiamo più trovata.»
«Va bene, nonna.»
Infatti, quando lo zio tornò, la nonna gli raccontò che avevamo cercato la gazzella dappertutto, ma ormai era scappata chissà dove. Lo zio Fernando ci credette e tutto finì lì. Grande nonna, grazie ancora per avermi coperto, perché lo zio era più disperato di me e se avesse saputo la verità, come minimo, mi avrebbe dato un sacco di botte. Parecchi anni più tardi, infatti, quando il giallo della gazzella era ormai in prescrizione, senza possibilità di condanna per me, chissà perché mia mamma raccontò tutto allo zio che si arrabbiò ancora tantissimo e mi disse: «Sei il solito disgraziato, Claudio. Ti è andata bene che non l’ho saputo subito». E pensare che quello era stato un classico fallo involontario, a ripensarci il primo della mia carriera.
Qualche mese dopo, il vuoto lasciato dalla gazzella venne riempito da un cane, un bastardino bianco e grigio trovato in strada, chiamato Olfi. Per fortuna lui mangiava e beveva regolarmente, per cui non rischiavo di commettere altri falli, più o meno involontari, da cartellino giallo o rosso. Me ne innamorai pazzamente, mangiavo e dormivo abbracciato a lui nella sua cuccia, per la disperazione di mia mamma che non riuscì a tirarmi fuori per una settimana. Però, standogli troppo attaccato mi riempii di pulci e presi una strana malattia, probabilmente un’allergia che mi fece venire la febbre alta. Non ho mai capito come abbiano fatto a guarirmi, ma ricordo ancora il male causato dalle trasfusioni di sangue.
Ripenso alla gazzella senza nome, al cagnolino Olfi e con loro mi sembra di essere ancora nel giardino della nostra casa a due piani nel rione Dhara, dove mia mamma rimproverava invano il giovane Gheddafi, di quindici anni. Mi ha raccontato che Gheddafi abitava lì vicino, faceva il pastore e accompagnava le sue pecore a brucare l’erba nel nostro giardino, entrando senza chiedere permesso e rubava i datteri. La mamma si arrabbiava e gli urlava: «Vai via, io chiamare police, tu capire italiano o no capire italiano?». Lui, però, faceva finta di niente e tornava con le sue pecore il giorno successivo, come se nulla fosse, con già un’aria da prepotente ad appena quindici anni!
Chissà che cosa sarà rimasto di quel nostro giardino con tanta erba. E chissà se lì vicino ritroverò la casa dello zio Fernando, che mi ha incaricato di controllare se davanti a una finestra laterale ci sono ancora i soldi e gli ori che aveva nascosto sottoterra nel 1970, quando era scappato dalla Libia come tutti gli altri italiani.
Appena arriviamo allo scalo militare di Tripoli c’è un altro comitato di accoglienza a riceverci, con auto speciali che ci accompagnano in centro, sempre scortati da una decina di mezzi della polizia. Se a Bengasi c’era stata festa all’aeroporto, qui ce n’è il doppio, anche perché è domenica mattina. Traffico bloccato, gente ai balconi, tutti che mi aspettano e mi salutano. Vorrei farmi accompagnare subito nel quartiere dove sono nato, ma le misure di sicurezza non me lo permettono. Mi dicono di rispettare il protocollo e allora mi rassegno, seguendo la delegazione nell’Hotel Radisson, dove è previsto un pranzo ufficiale.
Ma io non sono un industriale in viaggio di lavoro, io sono un italiano con il sangue libico che mi ribolle nelle vene, mi sento di nuovo un libico tra i libici e allora, a costo di rischiare, esco in strada con il mio amico giornalista Fabio, costringendo gli uomini della sicurezza a seguirmi, perché sono terrorizzati e non vogliono lasciarmi da solo. In realtà, in un attimo, si ribaltano i ruoli: quelli della sicurezza vengono indirettamente scortati da decine di persone di ogni età che vogliono pacificamente accompagnarmi a Dhara. C’è un silenzio irreale, rotto improvvisamente da un urlo che per un attimo spaventa tutti: «Claudiooo, bentornato a casa, Claudiooo».
Davanti a me spunta un uomo che avrà una settantina d’anni, con una lunga tunica bianca come la sua barba, i capelli e il cappellino, il tipico “maaraga”. Mi abbraccia forte, mi dice che si chiama Fat e aggiunge che sono nato di domenica e che lui era lì quel giorno. Gli rispondo che è vero, ma come potrei ricordarmi di lui? Sembra una gara a chi era più vicino a me e alla mia famiglia, quando ero piccolo. Uno che dice di chiamarsi Kali Mohammed El Busadi assicura di aver giocato con me all’oratorio della chiesa di Sant’Antonio, che dà il nome al rione, ma anche in questo caso è impossibile per me ricordare.
E così, in questa pericolosa ma allegra confusione, prima mi fermo a mangiare il mio vecchio piatto preferito, il cuscus con trippa e fagioli piccanti, poi con la pancia piena arrivo finalmente nella zona dove abitavo. Adesso, però, non c’è più niente. Né casa né muri, né giardino, figuriamoci i gioielli, l’oro e i soldi che lo zio Fernando aveva seppellito di nascosto. Le uniche cose rimaste intatte sono i ricordi dei profumi del pane fatto in casa da mia mamma, del capretto che mangiavamo il sabato e la domenica, il sapore indimenticabile di quel dolce arabo, helwa, che per me era la fine del mondo e si tagliava con il coltello a Natale, con tutta la famiglia riunita vicino all’albero. Quanto erano belli quei pranzi e quelle gite in pullman nel giorno di Pasquetta con i miei genitori per andare a vedere a una settantina di chilometri a ovest di Tripoli le rovine romane di Sabrata e quelle di Leptis Magna, sulla strada verso Misurata.
È ancora tutto qui nella mia mente, la messa alla domenica e poi le riunioni al circolo italiano sul lungomare Italia, dove si mangiava e ballava. Eravamo tanti, ci conoscevamo tutti e ci sembrava di appartenere a un’unica grande famiglia perché, anche se molti di noi erano nati in Libia, avvertivamo un legame fortissimo con l’Italia, in tutti i sensi. C’erano negozi che vendevano pasta e prodotti italiani di ogni genere e c’era la tv italiana, con i programmi in bianco e nero della Rai. Ricordo anch’io la musichetta di Carosello, come tanti ragazzi della mia età cresciuti in Italia, con quelle pubblicità piene di personaggi come Calimero, o slogan ritmati tipo “pro-dot-to Bia-let-ti”. Parlavo italiano sia in casa sia fuori, ma l’arabo un po’ lo capivo, anche se non era facile. Ricordo ancora qualche parola, soprattutto i numeri, da uno a dieci: wahid, ’ithnan, thalatha, ’arba^a, khamsa, sitta, saba^a, thamaniya, tis^a, ^ashara.
Fino alla terza elementare andai a scuola a Tripoli, in una scuola italiana, con una maestra italiana, la signora Valenza. C’era l’obbligo di studiare l’arabo un’ora al giorno, scrivevo sui quaderni da destra a sinistra. Una fatica tremenda. In classe c’erano due file di banchi sui quali eravamo seduti due a due, i maschi in un’aula, le femmine in un’altra. Eravamo venti, tutti figli di italiani, con il grembiulino nero e il colletto bianco e io stavo sempre nel secondo banco, vicino al mio compagno Marco. Dietro di me, o nell’altra fila alla mia sinistra, c’erano Claudio Alletto, Riccardo Ghisari, Roberto Cortese, Sergio Di Giorgio, Antonio Fichera, Roberto Cutuli, Claudio Terranova, Claudio Pitti, Franco Macauda, Paolo Cason, Lojacono e Pirosa.
A scuola non ero un campione, facevo i compiti come gli altri, ma senza eccellere. Diciamo che ero un terzino anche in classe, dove usavamo soprattutto le matite, mentre alla lavagna scrivevamo con il gesso, con un cancellino di spugna per ripulire. Tutto come in Italia, perché la Libia per molti versi era un Paese italiano in cui si viveva davvero benissimo. E anch’io stavo benissimo, con i miei amici e la mia famiglia. In fondo gli arabi parlavano l’italiano per cui ci capivamo, e poi erano belli gli scambi culturali a sfondo gastronomico tra le famiglie. Mia mamma, per esempio, insegnava a cucinare la pasta al pomodoro agli arabi, mentre le mamme arabe le insegnavano a preparare il tè alla menta e il cuscus. Andavamo tutti d’accordo e mai avrei pensato di cambiare vita da un giorno all’altro congelando per sempre, nella scatola della mia memoria, tanti frammenti di quell’infanzia meravigliosa.
![]()
2
Grazie Libia
Ai miei genitori, che mi hanno fatto nascere a Tripoli, devo l’orgoglio di sentirmi un po’ libico. A mio zio Fernando, invece, sono riconoscente per avermi fatto diventare juventino, seppure in modo indiretto: è infatti un tifoso del Torino che diventerà poi milanista. Lui che mi ha portato quella indimenticabile gazzella, un giorno mi regala anche una maglia a strisce bianconere, senza numero. Non ho ancora sette anni e quella maglietta, con strane righe verticali che non avevo mai visto prima, mi sembra bellissima proprio perché originale, almeno ai miei occhi di bambino. Senza nemmeno sapere che cosa sia la Juventus, la metto quando gioco di giorno, ma la uso anche come pigiama di notte, facendo diventare matta mia mamma che deve continuamente lavarla. Per fortuna, però, in Libia fa così caldo che basta un’ora al sole e la mia maglietta preferita è già asciutta, pronta per altre partite.
Mio papà non è un grande tifoso, ma un semplice appassionato che in televisione guarda soprattutto l’Inter e in particolare Angelillo, che gli piace molto. Di calcio, però, in casa non parliamo mai, anche se io incomincio a giocare a sei anni le prime partitelle, tutti contro tutti all’oratorio di Sant’Antonio. Indossiamo la maglia biancorossa come i più grandi, quelli che giocano i tornei nell’Antoniana contro l’Olimpia. Ci dividiamo in squadre da sette o otto inseguendo un pallone di cuoio duro e pesantissimo con le stringhe e giochiamo senza ruoli fissi, senza regole, senza arbitro, senza tempo e senza reti alle porte, perché le uniche reti sono quelle metalliche che separano l’oratorio dalla strada. Ce le diamo di santa ragione, botte da orbi su un campo di cemento durissimo, senza un filo d’erba, ma nessuno si lamenta quando cade per terra, non ci sono cascatori e tantomeno proteste. Alzarsi e camminare, come sentirò poi dire in televisione, nei miei primi anni in Italia, dalla voce del grande telecronista Nicolò Carosio. Imparo a correre all’infinito e soprattutto a non mollare mai, anche perché sono quasi sempre il più piccolo della compagnia e ho una gran paura di essere lasciato fuori se mi fermo per stanchezza o per qualche botta.
All’oratorio vado d’accordo con tutti, ma se qualcuno più grande cerca di fare il furbo, per farmi rispettare rispondo con la prima parolaccia che ho imparato in arabo: “andinummuk”, l’equivalente del classico e universale “figlio di puttana”. E a quel punto, tra un andinummuk e l’altro, mi sento più grande e soprattutto più sicuro anch’io. Non smetterei mai di giocare: quando sono a casa mi alleno per diventare più bravo, prendendo a calci i palloni ormai inutilizzabili che mi regala don Marcello se lo aiuto a servire messa la domenica mattina. Rompo non so quanti vetri della cucina, facendo impazzire mia mamma che mi nasconde quella specie di palla fino a quando io la ritrovo, promettendole di non fare altri disastri.
Per lei, però, è una battaglia persa, perché dopo una settimana di castigo ne combino una grossa. Calcio quel mezzo pallone contro un armadio leggero, che cade verso il centro della stanza, facendo volare sul pavimento una montagna di banconote arrotolate. Nonna Redenda, che ha fiutato il pericolo, arriva di corsa disperata: quei soldi – piastre libiche – sono i suoi risparmi, nascosti proprio sopra l’armadio, perché a quei tempi non si portano in banca. Lei è una sarta eccezionale, ricercata da tutti perché si dice che abbia le mani d’oro, infatti guadagna tantissimo facendo anche le divise ai militari. Da quel giorno, però, per colpa mia cambia il nascondiglio dei suoi soldi, che nessuno scopre più. Intanto io mi prendo un’altra bella sgridata e da quel momento non rompo più nessun vetro.
Una sera mio papà, durante la cena, dice che forse dovremo lasciare la Libia per andare in Italia. Divento triste per la prima volta: non capisco perché dobbiamo abbandonare quella bella casa con il giardino dove stiamo bene, la scuola, l’oratorio, gli amici. Passa qualche giorno e lui torna sul discorso. Dice che qualcosa sta cambiando, in peggio purtroppo. Lui è un muratore capomastro, che alle sue dipendenze ha operai libici, con i quali non ha mai avuto problemi di alcun genere. Ma poco alla volta chi lavora con lui incomincia a contestarlo, gli dice che non devono essere gli italiani a comandare. La goccia che fa traboccare il vaso della pazienza di mio papà è il furto della bicicletta con cui andava in cantiere, sempre rimasta in giardino, senza catene né lucchetti. Per lui è il segnale definitivo che è meglio cambiare aria. Anche perché, come se non bastasse, gli uomini libici incominciano ad avere meno rispetto nei confronti delle donne italiane. Io sono troppo piccolo per rendermi conto della situazione e non dico nulla. Se mio padre ha deciso, vuol dire che ha ragione. Si parte e non si discute. Si va in Italia, un Paese di cui ho tanto sentito parlare in casa e a scuola, che per me però rimane misterioso.
Così, improvvisamente, arriva l’indimenticabile giorno dell’addio a Tripoli. Mabruka, la nostra donna di servizio che mi parlava in arabo e ci preparava quel buonissimo tè alla menta, è la più triste di tutti. «Mio piccolino Claudio, torna presto» dice abbracciandomi più forte del solito, mentre ci accompagna al porto e intanto piange, perché immagina di non rivederci più. C’è una nave enorme che ci aspetta, più alta delle case, e una confusione pazzesca al porto di Tripoli. Tanti salutano sventolando fazzoletti, altri gridano, qualcuno prega. Io ho un po’ di paura e allora prendo per mano mia sorella Maria Rosa, mentre mia mamma tiene in braccio il mio fratellino Massimo che piange perché ha fame. È sera e ci aspetta un viaggio di tre giorni e tre notti che mi sembra interminabile. Ci danno le coperte per ripararci dal vento sul ponte della nave, dove ci sistemiamo in qualche modo su alcune sedie che assomigliano vagamente a sdraio. Proviamo ad addormentarci tutti lì, appoggiati uno vicino all’altro, io, i miei fratelli, mio papà e mia mamma che deve allattare Massimo. Nonna Redenda, invece, rimane a Tripoli con zio Fernando e gli altri suoi tre figli, perché non può lasciare il lavoro di sarta grazie al quale ha sempre mantenuto tutti da sola, senza marito.
Mi attende una nuova vita in Italia, ma se dipendesse da me non partirei mai. Ho imparato davvero molto nella mia infanzia a Tripoli. Cinque anni lì sono come dieci in Italia, perché si diventa grandi molto più in fretta. Quando vedi bambini capaci di dare da mangiare a un cammello così alto che potrebbe schiacciarli, o altri che tengono a bada da soli un gregge di pecore, senza avvertire il peso della responsabilità, comprendi il valore del sacrificio. Ecco perché, se ho imparato subito tante cose della vita, non smetterò mai di dire grazie alla Libia.
![]()
3
Il consiglio di Riva
Mio papà aveva avuto il fiuto di un goleador, o meglio l’anticipo di un difensore. All’inizio del settembre 1969, ad appena ventisette anni, il colonnello Gheddafi sale al potere e incomincia a islamizzare il Paese, vietando il consumo dell’alcol. Quel prepotente, che a quindici anni entrava a rubare i datteri nel nostro giardino facendo arrabbiare mia mamma, espelle gli americani e nel giro di pochi mesi rende la vita impossibile agli altri stranieri, a cominciare dagli italiani. Chi può parte subito, prima che esploda il caos nell’estate del 1970, quando nel giro di poche settimane devono andare via tutti, abbandonando il lavoro, la casa, i risparmi. I miei zii, come le migliaia di altri italiani rimasti a Tripoli, scappano impauriti, costretti a fuggire con soltanto i vestiti addosso, senza collane, orecchini e tantomeno orologi, perché il massimo consentito sono le fedi nuziali al dito. In meno di due mesi, non ci sono più italiani in Libia. Tutti spariti. Una fuga di massa per la sopravvivenza che purtroppo rivivrò con tanta tristezza quando la tv trasmetterà le drammatiche immagini dei profughi libici e siriani in cerca di una nuova vita. E io, dopo i racconti dei miei zii e dei miei amici, avrò per sempre i brividi, continuando a maledire Gheddafi.
Negli anni Cinquanta, però, nessuno può immaginare che la Libia precipiterà così in fretta dal paradiso all’inferno, figuratevi un bambino come me che dal porto di Siracusa sta andando a Noto, dove ci aspetta una sistemazione provvisoria in casa della sorella di mia mamma, la zia Pina. Ci va di lusso, perché gli altri nostri compagni di viaggio sulla nave, che non hanno parenti in Italia, vengono accolti in un campo profughi a Siracusa.
A Noto, la terra da cui erano partiti i miei nonni paterni per trasferirsi in Libia, quando mio papà aveva meno di un anno, rimaniamo sei mesi. Per aiutare i miei genitori lavoro in una falegnameria, piallando con le mani il legno di porte e finestre. Ho soltanto otto anni e sono i miei primi guadagni, anche se io ho in testa soltanto il calcio. Il falegname Giovanni, un signore alto e biondo, dice a tutti che diventerò un grande giocatore. Ma nemmeno io gli credo perché non mi sembra di fare cose straordinarie. Semplicemente corro e mi butto su tutti i palloni all’oratorio, senza paura di affrontare quelli più grandi di me, perché in ...