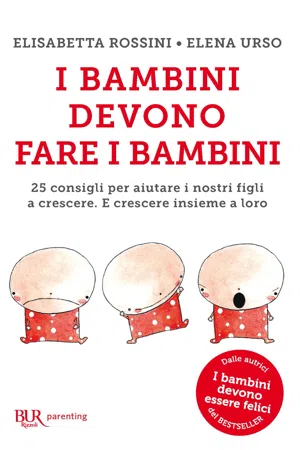![]()
SITUAZIONI E SOLUZIONI QUOTIDIANE
![]()
1
AUTOREVOLEZZA
Per i figli dobbiamo essere genitori. Non amici.
Per essere genitori bisogna essere adulti. È un’affermazione apparentemente banale, ma che racchiude il senso profondo dell’essere genitori e dell’esserlo in modo sufficientemente buono.
Essere adulti implica una serie di caratteristiche assai vantaggiose e gravose al tempo stesso.
Ne elenchiamo solo alcune:
› indipendenza emotiva e intellettuale;
› consapevolezza di sé e degli altri;
› senso di responsabilità;
› capacità progettuale.
Insomma, talvolta si preferirebbe non crescere mai... E si potrebbe anche decidere di farlo, se a un certo punto non si diventasse genitori! A quel punto bisogna fermarsi e diventare grandi, anche in un colpo solo se è necessario. I bambini hanno bisogno di adulti forti e saldi, prima per sopravvivere, poi per crescere.
Dato questo presupposto, saremo pronti per praticare con i figli quell’arte oscura che è l’autorevolezza.
L’autorevolezza è un comportamento che miscela, con pazienza e cura, l’autorità che i genitori devono esercitare insieme con l’ascolto e la capacità di mettersi nei panni del bambino, che ha competenze specifiche diverse da quelle degli adulti.
Questo comportamento inoltre affonda le radici nell’amore incondizionato che mamma e papà provano e dimostrano ai figli.
Come abbiamo detto, l’amore è un bisogno primario, fondamentale per vivere e crescere come il sonno, il cibo e le funzioni organiche. Ecco perché non deve mai essere messo in discussione.
Come fare? Con i ben noti piccoli gesti quotidiani in grado di coniugare azioni pratiche e stati emotivi:
› quando siamo arrabbiati dichiariamolo in modo inequivocabile, aggiungendo che mamma e papà amano i loro figli anche quando sono arrabbiati (“La mamma e il papà ti vogliono bene, ma questa cosa non si può proprio fare”). Così i bambini capiscono che quell’amore non dipende dall’umore dei genitori né muta in base al proprio comportamento;
› evitiamo di pronunciare frasi ricattatorie come “Se fai così, non ti voglio più bene”, perché sovraccaricano il piccolo di un peso emotivo ingestibile. Invece un bambino ha bisogno di sapere che è amato in ogni caso, anche quando si comporta male. Pian piano imparerà che ci sono comportamenti che meritano approvazione e altri no; imparerà a distinguerli e a prevedere le reazioni degli adulti nei vari casi;
› circoscriviamo complimenti e rimproveri alle azioni. Per esempio: “Non mi piace quando fai così”, oppure: “Sei stato molto bravo a fare quel disegno, mi piace molto!”. In questo modo il bambino sa che il giudizio è rivolto a un ambito specifico: non è assoluto sulla sua persona. Sarà motivato a migliorare in caso di errore, anche perché avrà sperimentato con piacere l’apprezzamento. E non si abbatterà in caso di mancata approvazione, perché non sentirà minacciato il valore della sua persona in modo totale;
› insegniamo loro gradualmente a scegliere: dai 2 anni circa possiamo partire dalle piccole cose, offrendo al bambino due alternative tra le quali riteniamo che possa scegliere. Per esempio: “Vuoi la maglia con l’ape o quella con il cane?”; “Vuoi mangiare pasta o riso?”. Evitiamo di far incombere su di lui scelte troppo importanti, come la nascita di un fratellino o la scelta della scuola materna: sono troppo piccoli per decidere in merito a questioni simili. Ma soprattutto non saprebbero letteralmente cosa stanno scegliendo. Anche scegliere è una competenza che si sviluppa un passo alla volta.
PICCOLI ARTISTI
Ricordiamoci che, di fronte alle produzioni artistiche dei nostri bambini, è bello non limitarci a dire un “bravo!” generico. Proviamo a sottolineare quello che ci è piaciuto di più, la scelta di un colore, un elemento particolare e chiediamo loro di raccontarci il disegno: sarà una bella occasione per parlare di sé e per raccontarsi senza giudizi, percependo un autentico interesse da parte nostra.
Con questi pochi esempi abbiamo ottenuto un’idea di cosa significhi in termini concreti essere genitori autorevoli: dare ai bambini regole precise, senza farli sentire ricattati né inadeguati; governare le situazioni per loro, coinvolgendoli attivamente secondo le possibilità tipiche della loro età; accoglierli sempre a prescindere dal proprio stato d’animo o dal loro comportamento; comprendere ciò che sono e ciò che fanno senza per questo giustificarli in tutto. Significa, infine, stare accanto ai figli, senza prenderne il posto.
Altro aspetto fondamentale dell’autorevolezza è il tipo di relazione che lega piccoli e adulti: per i figli dobbiamo essere genitori. Non amici. Di amici infatti ne avranno tanti, ma di genitori solo due (più o meno)! Essere autorevoli vuol dire saper distinguere molto bene i ruoli, pur in un clima di accoglienza e amore incondizionato.
I genitori sono una guida, un punto di riferimento, coloro che prendono le decisioni e che dettano le regole. Il rapporto con mamma e papà non è un rapporto paritario, perché siamo noi ad aver deciso di avere dei figli, noi abbiamo le esperienze necessarie per sapere cosa fare e cosa no e noi ci prendiamo la responsabilità dei nostri piccoli. Tutte le responsabilità: anche quella di non piacere ai nostri figli, quando è necessario. I bambini hanno bisogno di dipendere dai genitori per poter crescere e diventare indipendenti a loro volta. Questa dipendenza, inizialmente totale, è la condizione migliore affinché possano apprendere e adempiere tutti i compiti evolutivi (camminare, mangiare, parlare...). È come se la mente e il cuore del bambino dicessero: “Va bene, questo è un luogo sicuro in cui stare; quando mi sento pronto posso andare, sperimentare e sbagliare perché c’è qualcuno sempre lì vicino a me, non per evitarmi di cadere, ma per insegnarmi come ci si rialza”.
Inoltre i genitori sono le figure da cui i ragazzi devono staccarsi per diventare grandi. Anche questo è un compito fondamentale: dobbiamo consentire ai nostri figli di criticarci per poter attuare il distacco e intraprendere il cammino verso l’autonomia e l’indipendenza.
“Fare gli amici” li confonde perché i bambini hanno bisogno di una guida sicura che indichi loro la strada, li accompagni fino al punto da cui possono muoversi da soli o, appunto, con nuovi compagni di viaggio.
La relazione di amicizia è paritetica e reciproca, quella tra genitori e figli asimmetrica; gli amici non hanno la responsabilità l’uno dell’altro, i genitori hanno la responsabilità dei figli; gli amici danno consigli, i genitori regole; i genitori educano, gli amici no; i genitori pongono i limiti che i figli tentano di superare; gli amici sono i compagni con cui questi limiti vengono superati. Alcune amicizie durano per tutta la vita, altre finiscono, ma l’amore di un genitore per il proprio figlio non finisce mai.
![]()
2
REGOLE
Le regole sono la prima forma di libertà per un bambino.
I bambini hanno bisogno di regole e di esempi da seguire per imparare come comportarsi e crescere nel rispetto di sé e degli altri: se l’ambiente familiare è troppo permissivo tali esempi vengono a mancare.
Se non abbiamo autorevolezza, saranno i bambini a imporsi e a decidere cosa vogliono fare, ma questo non li farà stare bene, anzi! I bambini non saranno mai realmente soddisfatti, perché non sanno davvero quello che vogliono e cosa li fa stare bene.
Un bambino che non ha regole chiare, precise e adeguate a cui riferirsi, a cui viene data sempre ragione, è un bambino lasciato solo: crescerà convinto di essere il migliore di tutti, perché non viene mai contraddetto, o di essere un’eterna vittima, perché davanti ai no del mondo esterno reagirà come se fossero una gigantesca ingiustizia. È un bambino che non avrà stima per gli altri o per se stesso. È un bambino che, in ogni caso, avrà dentro di sé un grande dolore. Le regole sono una dimostrazione d’amore: alla lunga un’estrema tolleranza può essere confusa con l’indifferenza, perché l’assenza di regole allontana i bambini dalla libertà e li avvicina alla solitudine.
È importante che le prime regole e i primi divieti siano sperimentati in famiglia: è la palestra ideale per verificare sulla propria pelle, protetti e sereni, che rispettare le regole è possibile e che i rimproveri non vanno temuti ma compresi. I genitori infatti, molto più di chiunque altro – insegnanti o amici – hanno la possibilità di sopportare e gestire con efficacia le reazioni oppositive dei bambini.
Ma che cosa sono le regole?
Le regole sono una disposizione interiore che orienta il pensiero, il comportamento, la relazione con sé e con gli altri. E questa disposizione nasce dall’esperienza.
Molto per un adulto, troppo per un bambino, che di esperienza non ne ha.
Ecco perché dobbiamo aiutare i piccoli a percepire come concrete le regole presentandole come vere e proprie indicazioni da seguire, in modo che anche loro facciano l’esperienza necessaria a formarsi, da un lato, un’inclinazione personale e, dall’altro, a sviluppare la capacità di auto-disciplinarsi.
Il procedimento è sempre lo stesso che abbiamo visto applicato anche alle emozioni, nella sezione precedente: rendere concreto, tangibile e praticabile un concetto troppo astratto per essere elaborato dalla mente dei piccoli.
Ciò che i piccoli imparano gradualmente a interiorizzare attraverso le regole sono la declinazione pratica e la procedura tecnica di quella disposizione interiore, che si formerà proprio su queste basi.
Un circolo virtuoso! Vediamo come:
› poniamo poche e chiare regole inderogabili.
Poche: dare mille indicazioni è come darne nessuna. Perciò prendiamoci un tempo per stabilire quali sono le regole davvero imprescindibili per la nostra famiglia. Fino all’anno di età è più facile: si tratta di regolare gli orari dei pasti, del sonno, dei cambi... Dopo l’anno, il bambino si muove con più autonomia e aumentano anche i pericoli in cui incorre. Adesso alle regole si affiancheranno i divieti, perché occorre garantire la sua incolumità fisica.
In ogni caso possiamo seguire un criterio generale: la regola deve essere adeguata all’età e deve tenere conto dei bisogni del bambino. Se risponde maggiormente a un’esigenza nostra più che a quella del piccolo, è bene modificarla. Per esempio, ai bambini piace camminare a piedi nudi; è davvero sempre sconsigliabile? Abbiamo case così fredde da non poter consentire loro di passare almeno una parte del pomeriggio solo con le calze? Forse la nostra è una preoccupazione eccessiva che ci porta a iper-proteggere i bambini. La regola del “non si cammina scalzi” quindi è forse modificabile.
Chiare: perché un bambino possa seguire una reg...