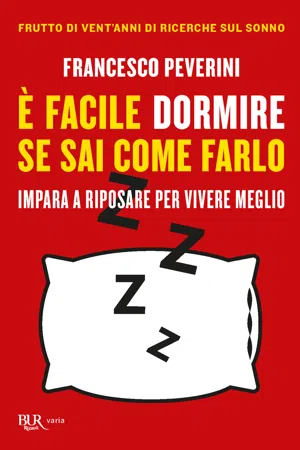![]()
SECONDA PARTE
quando non si dorme più bene
![]()
5
PERCHÉ È DIFFICILE DORMIRE BENE?
La salute è considerata la somma di tante buone abitudini, tra le quali, spesso, una strategia che coinvolge la scelta di cibi nutrienti e sani, e una sufficiente quota di tempo spesa nell’esercizio fisico.
Ma se non si hanno almeno sette ore di sonno ogni notte, si può minare ogni sforzo compiuto in tale direzione.
Di quanto sonno si ha veramente bisogno?
Tutti avvertono una piacevole sensazione di benessere dopo un buon riposo notturno. Ma non basta.
Grazie a molteplici studi scientifici sappiamo che si può puntare a un numero di ore di sonno mirate all’età di ogni persona, bambino, adulto e anziano che sia, con un intervallo che permette di rispettare anche le differenze individuali (che sono su base genetica).
| Neonati tra 0 e 3 mesi | 14-17 ore |
| Neonati tra 4 e 11 mesi | 12-15 ore |
| Bambini tra 1 e 2 anni | 11-14 ore |
| Bambini in età prescolare tra 3 e 5 anni | 10-13 ore |
| Bambini in età scolare tra 6 e 13 anni | 9-11 ore |
| Adolescenti tra 14 e 17 anni | 8-10 ore |
| Giovani adulti tra 18 e 25 anni | 7-9 ore |
| Adulti tra 26 e 64 anni | 7-9 ore |
| Anziani con più di 65 anni | 7-8 ore |
Fattori genetici, comportamentali e ambientali aiutano a determinare la quantità di sonno necessaria a ogni singolo individuo.
Ma cosa accade quando non si consegue un buon sonno?
Dormire meno del necessario ha un impatto negativo anche sulla salute, causando tanti e differenti problemi.
Complicazioni a breve termine possono includere:
• Mancanza di attenzione; una riduzione di un’ora e mezzo di sonno può avere un impatto negativo sull’attenzione.
• Alterazioni della memoria; la mancanza di sonno può influenzare la capacità di pensare e di ricordare o elaborare le informazioni acquisite.
• Stress di relazione; se si dorme poco è possibile sentirsi irritabili e si ha una maggiore probabilità di creare conflitti con gli altri.
• Alterazione del giudizio morale.
• Peggioramento della qualità della vita; senza una notte di riposo alle spalle si può diventare meno propensi a partecipare alle normali attività quotidiane.
• Maggiore probabilità di incidenti stradali; questo è un dolente capitolo che sposta la percezione del disturbo del sonno da una sfera privata a una più rilevante quale quella sociale.
Se si continua a vivere senza un sufficiente apporto di sonno, possono insorgere gravi problemi di salute, come la pressione alta (ipertensione), il diabete, l’infarto, l’insufficienza cardiaca e l’ictus.
Altri potenziali effetti negativi sulla salute includono l’aumentata incidenza di obesità, la depressione e la riduzione del desiderio sessuale.
Una cronica privazione del sonno può anche influenzare l’aspetto fisico di un individuo: nel corso del tempo compariranno rughe premature e cerchi bluastri e scuri sotto gli occhi, e gonfiore della cute del volto.
Inoltre, tanto nell’adulto quanto (come abbiamo già visto) nell’adolescente, porta a un aumento del cortisolo circolante. Questo ormone dello stress, tra l’altro, può rovinare il collagene, la proteina che mantiene la pelle liscia.
Nei più piccoli, una continuata mancanza di sonno può generare una paradossale iperattività, scarsa capacità di apprendimento e deficit di attenzione.
Sia negli adulti sia negli adolescenti, può invece determinare obesità, stanchezza, depressione, ridotta capacità di consolidamento della memoria, ricerca di “stimolanti a portata di mano” come le sigarette, fino a un aumentato rischio di assunzione o abuso di sostanze farmacologicamente attive.
Una categoria di persone che comprende bene gli effetti di una privazione estrema e acuta del sonno sono i militari che, per ragioni molto evidenti, manifestano (o dovrebbero manifestare) un vivo interesse per l’argomento. La maggior parte degli studi e degli esperimenti condotti sulle forze armate di molti Paesi, mostra che dopo circa trentasei ore senza sonno i soldati cominciano a provare un significativo deterioramento in termini di prestazioni fisiche e mentali. Gli effetti sono cumulativi ed esponenziali, tanto che dopo circa settantadue ore senza sonno i soldati non sono in grado di svolgere compiti complessi come guidare un veicolo o sparare con un’arma verso un bersaglio designato. La maggior parte dei soldati inizia a addormentarsi involontariamente anche quando si trova in piedi e molti avvertono allucinazioni.
Negli esperimenti che coinvolgono i civili, i partecipanti sottoposti a privazione del sonno manifestano reazioni che li portano a diventare progressivamente più lunatici, irritabili, aggressivi e maleducati. Come del resto avviene per molti adolescenti.
Ciò che è stato meno compreso fino a poco tempo fa, è che non ottenere un sonno qualitativamente buono per un periodo di tempo prolungato ha un effetto negativo sul benessere fisico e mentale a qualsiasi età.
Anche ridurre soltanto di un’ora e mezza le ore di sonno nel corso di una singola notte rispetto a quanto consigliato può ridurre la prontezza intellettuale di quasi un terzo delle persone.
Sonno e scuola
Gli adolescenti, come abbiamo visto, hanno una costituzionale difficoltà a svegliarsi presto: in troppi casi, purtroppo, l’inizio dell’anno scolastico segna per molti adolescenti anche l’avvio di un lungo periodo di privazione del sonno, che diviene cumulativa e influenza il loro benessere fisico e mentale e di conseguenza la loro capacità di imparare.
Tutti sappiamo per esperienza che gli adolescenti lasciati a se stessi amano fare le ore piccole e dormire fino a tardi, talora fino al primo pomeriggio. Per molti genitori questa è semplicemente una delle tante manifestazioni del malumore giovanile e della naturale ribellione associata all’adolescenza, così come la difficoltà ad alzarsi al mattino viene vissuta come un altro espediente per evitare di dover andare a scuola. Ma cosa accadrebbe se tutti prendessero coscienza che tali malumore e ribellione sono, almeno in parte, causati da una privazione cronica di sonno su cui gli adolescenti e i loro genitori hanno poco o nessun controllo?
Non solo.
A una sempre più frequente cronica carenza di sonno degli adolescenti si associa inevitabilmente, data l’età dei soggetti, un certo numero di fattori di disturbo tra cui cambiamenti fisiologici associati con la pubertà (di natura ormonale), scelte di vita delle famiglie ed esigenze e decisioni accademiche.
Si possono facilmente riscontrare quanti siano gli elementi che influenzano negativamente la capacità degli studenti delle scuole medie e superiori di ottenere un sonno sufficiente e ristoratore.
Queste considerazioni accompagnano anche il dibattito sull’inizio dell’orario scolastico. Un numero consistente di ricerche ha ormai dimostrato che ritardare l’inizio dell’orario scolastico potrebbe dimostrarsi un’efficace contromisura per arginare la perdita cronica di sonno dei giovani studenti, con molteplici potenziali benefici per quanto riguarda la salute fisica e mentale, la sicurezza e lo stesso rendimento scolastico. L’associazione americana di pediatria (AAP) lo professa in modo esplicito ormai da diversi anni, con opuscoli e richieste al mondo politico.
Tuttavia, almeno in Italia, cambiamenti dell’orario scolastico per un ingresso che vada oltre le ore 8:30 possono incidere fortemente sulle abitudini delle famiglie e sull’orario di inizio del lavoro. Tale modifica, dunque, non sarebbe a costo “zero” come molti ricercatori anglosassoni vorrebbero far credere, ma avrebbe un serio impatto economico.
Nonostante le prove scientifiche, infatti, fino a oggi nessun Paese ha modificato queste abitudini. L’unica eccezione è rappresentata dalla Gran Bretagna, dove sarà avviata una sperimentazione con studenti di cento scuole, autorizzati a iniziare le lezioni alle 10. Uno studio pilota che ha coinvolto una singola scuola con un orario ritardato di un’ora ha intanto consentito di rilevare un miglioramento delle prestazioni nelle materie in esame in circa il 20% dei casi.
Ritengo oggi opportuno, per ottimizzare il sonno degli studenti, sollecitare i docenti delle scuole elementari, medie e superiori a svolgere programmi di formazione che prevedano di incoraggiare le famiglie (attraverso gli alunni stessi) a dare ai propri figli i livelli ottimali di sonno previsti.
Generalmente, possiamo dire che il fabbisogno medio di sonno di un bambino delle elementari arriva anche a dieci-undici ore, e quello di una adolescente a dieci ore; tuttavia numerosi studi scientifici ne testimoniano una drastica riduzione nel mondo industrializzato.
Anche gli operatori sanitari, che trattano abitualmente la salute degli adolescenti, dovrebbero provare a educare ragazzi e genitori sull’importanza di un orario di sonno adeguato per il mantenimento di salute e benessere.
Alcuni suggerimenti possono stimolare una maggiore attenzione a questi problemi e aiutare ad avere un approccio meno problematico alla questione.
• Pianificare gradualmente una buona durata di sonno notturno. Cominciare l’anno scolastico dopo aver disciplinato il sonno dei ragazzi almeno una settimana prima dell’inizio della scuola. Non potremmo, infatti, ottenere nulla in una sola notte.
• Restare coerenti con gli orari stabiliti anche durante il fine settimana, quando sia i genitori sia i ragazzi sono tentati di fare molto tardi la sera e poi recuperare tutto il mattino successivo, cosa che non potrà avvenire il lunedì.
• Cercare l’aiuto della luce al mattino, che, determinando una più vantaggiosa produzione di melatonina, può dare una mano a resettare l’orologio interno (il ritmo giorno-notte) segnalando alla corteccia cerebrale che è il momento di essere svegli, e regolando anche meglio l’assunzione di cibo.
• Ricordare che è altrettanto importante svolgere attività fisica durante il giorno, per giungere “stanchi” la sera, al momento di addormentarsi. È questo un altro determinante meccanismo fisiologico che ci porta poi a dormire meglio la notte.
• Non permettere che i bambini assumano bevande contenenti caffeina oltre un certo orario la sera. La caffeina stimola il sistema nervoso centrale, rendendoli forse un poco più attenti ma quasi sicuramente insonni.
• La tecnologia non è un tabù, ma troppa luce da schermi retro-illuminati (televisione, computer, tablet, telefonini) incrementa l’attività elettrica del cervello di un giovane, l’esatto opposto di quello che dovrebbe accadere prima di andare a dormire. La luce artificiale può “confondere” la naturale produzione di melatonina.
• Non impiegare rimedi farmacologici per aiutare i ragazzi a dormire. Parlare con il medico quando gli sforzi per aiutarli a ottenere un buon sonno sembrano ripetutamente fallire.
Un sonno insufficiente, ormai piuttosto comune tra i giovani studenti, è associato a diversi rischi per la salute, troppo frequentemente ignorati sia dai genitori sia dagli insegnanti.
Il più importante è il sovrappeso: dormire meno accentua la produzione di ormoni che stimolano l’appetito (la grelina) e provoca la riduzione o l’insensibilità ad altri ormoni che utilizzano il grasso a scopo energetico (la leptina). Bambini privati di un sonno corretto dimostrano un peso maggiore rispetto a coetanei più fortunati e meglio dormienti.
La percentuale di studenti delle scuole superiori che non acquisiscono un sonno sufficiente (due su tre) è rimasta stabile dal 2007, e non sembrano profilarsi miglioramenti spontanei all’orizzonte.
Gufi e allodole
Non sempre è facile distinguere i disturbi del sonno, identificare le cause di una sonnolenza o capire di quante ore di riposo ha bisogno ognuno di noi.
Basti pensare che se, nel caso di un adulto, le cause di privazione cronica di sonno possono bene o male essere fronteggiate in autonomia o decidendo di andare da un medico, per bambini e adolescenti le cose si complicano ulteriormente.
Come osservo nella pratica cli...