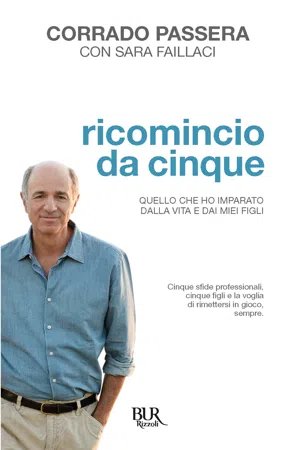![]()
1
I piedi per terra
Se dovesse scegliere un’immagine che racconti la sua infanzia, quale sarebbe?
Il lago. Sono nato a Como e sono cresciuto in un appartamento al decimo piano, da cui si godeva una vista bellissima: da un lato si vedeva il lago salire su verso Cernobbio, dall’altra il centro storico della città circondato dalle mura. Ci trasferimmo lì quando avevo cinque anni; ricordo la sensazione del giorno in cui entrai per la prima volta in quella casa: fui investito dalla luce e dalla bellezza del paesaggio. Era l’inizio degli anni Sessanta, il palazzo era stato appena costruito, moderno, e noi eravamo i primi ad abitarci. A me sembrava bellissimo anche se oggi mi rendo conto che era un condominio come tanti altri.
La sua famiglia era ricca?
I ricchi a Como sono sempre stati gli industriali della seta, molti abitavano nelle ville sul lago. I miei erano bravi albergatori, quindi benestanti. Mio nonno Antonio era partito da zero: arrivato con sua moglie Clelia da Salsomaggiore a Como come cameriere, era riuscito a diventare direttore di ristorante sui grandi battelli di quel tempo; poi aveva preso in gestione un albergo e infine ne aveva acquistato uno. Aveva quindi potuto far studiare i figli, mio padre Gianni e mio zio Corrado, che fecero crescere l’azienda; papà andò alla Bocconi, che riuscì a finire prima di partire volontario per la guerra. Quando sono nato, gli alberghi erano diventati tre: due nel centro storico di Como, uno in riva al lago. Qualcuno pensa che sia nostro anche l’hotel cinque stelle lusso Villa D’Este, ma in realtà ne abbiamo posseduto solo una piccolissima quota, che mio fratello vendette quando la proprietà si concentrò sostanzialmente in una sola mano.
Sua madre era di Como?
No, era piemontese, di Vistrorio Canavese. A trentatré anni venne a Como in vacanza e conobbe mio padre, allora trentacinquenne, che ha sempre detto di non essersi sposato prima perché l’aveva aspettata. Hanno avuto tre figli: io fui il primo, due anni dopo arrivò Antonello, e infine Bianca, quando io avevo sei anni.
Che bambino era?
Dell’infanzia ricordo poco o nulla. Le nostre giornate erano scandite in maniera netta: scuola la mattina, attività sportive il pomeriggio, e poi i compiti. Gli amici veri sono arrivati più tardi, con le superiori; ero un bambino che non aveva problemi a stare da solo, così come oggi: la libertà è anche questo. Per molti anni ho avuto il desiderio, mai realizzato, di comprare o affittare un faro lontano dalla confusione.
La sua famiglia era religiosa?
Credente e anche praticante, ma senza eccessi. In realtà, per noi figli, da bambini, la religione coincideva con il momento della preghierina serale che facevamo con la mamma, prima di andare a dormire. Anche papà faceva il possibile per essere a casa con noi in quel momento, ma non succedeva spessissimo. Ricordandomi quanto lo aspettavo da bambino, quando sono diventato padre a mia volta ho voluto ricreare quel momento anche per i miei figli e ho cercato di esserci il più spesso possibile: preghiera insieme e poi una favola già a luce spenta. Il difficile era inventarne ogni sera una diversa perché erano loro a dare il tema: un animale, un oggetto o un colore. E da poco ho ripreso a farlo per i più piccolini.
Che tipo di educazione ha avuto dai suoi genitori?
Mio padre ha condizionato molto il mio modo di essere, era un esempio di dedizione al lavoro, senso del dovere, rigore morale e, al tempo stesso, apertura mentale, lungimiranza, pragmatismo. Senza dubbio è stato un modello a cui, consciamente o inconsciamente, mi sono sempre ispirato. Nella prima adolescenza sentivo molto la sua mancanza e ricordo di avergli rimproverato d’essere stato troppo assente: non lo vedevo quasi mai. Quando facevo la terza media, spinto da un bisogno che non riuscivo a esprimere a parole, gli scrissi: «Ma noi abbiamo un papà?». Lui lesse la lettera e ne fu colpito, ma era difficile cambiare il suo stile di vita che era per lui una regola esistenziale. Papà andava a lavorare alle otto di mattina e tornava alle otto di sera quando andava bene, per lui sabato e domenica non esistevano; in compenso mia madre è sempre stata una presenza costante e rassicurante per noi. Il momento della famiglia era il venerdì, quando venivano a prenderci a scuola in macchina e si andava a mangiare fuori noi cinque, in un ristorante ogni volta diverso. Poi c’era il pranzo domenicale, insieme allo zio e a mia nonna, in uno degli alberghi di famiglia, il San Gottardo, all’epoca considerato «il ristorante» della città.
Che ricordi ha dell’albergo?
Era il luogo di lavoro di papà, quindi per me un posto quasi sacro. Con i miei fratelli la domenica rappresentava un evento, perché avevamo l’abitudine di pranzare lì e poi ci era consentito giocare, partecipando alla vita dell’albergo e del ristorante. Io volevo sempre stare al centralino dove su una grande consolle bisognava collegare le telefonate interne ed esterne con degli spinotti di vario colore. Anche aiutare alla cassa nel dare i resti ai camerieri non era male, mentre mio fratello Antonello si divertiva soprattutto a stare al bancone centrale della cucina, dove si coordinavano i vari reparti e il collegamento con la sala.
Che rapporto avevano i suoi genitori con il denaro?
La filosofia di mio padre era molto semplice: gli utili dell’azienda andavano tutti reinvestiti per farla crescere. Non si è mai parlato di comprare seconde case o macchine di grossa cilindrata, tantomeno barche. Anche in questo mio padre e mia madre avevano la stessa naturale sobrietà in tutto ciò che facevano. Di denaro non si parlava, ma era implicito che non si doveva sprecare: bisognava spegnere la luce quando si usciva da una stanza, e per meritarti la paghetta settimanale dovevi rendere conto di come si erano spese quelle precedenti. Ricordo che per acquisti un po’ fuori dalla norma – un paio di scarpe più care del solito – si andava a chiedere il permesso a papà. Sembrano cose fuori dal tempo? Eccesso di rigore? Forse, ma sono grato ai miei genitori per questo. Anche perché, di contro, si ponevano ben poche limitazioni agli «investimenti» utili per la nostra formazione: lezioni, corsi e viaggi di studio.
Al di là della sua etica professionale, che tipo era suo padre?
Un uomo tutto d’un pezzo. Partì come volontario per la Seconda guerra mondiale, da ufficiale degli alpini. Dopo l’8 settembre, non prese nemmeno in considerazione la possibilità di collaborare con i tedeschi e venire meno al suo giuramento di lealtà al Paese. Nonostante avesse trascorso mesi durissimi nei peggiori campi di prigionia, e malgrado fosse molto corteggiato dai nazisti per via della sua laurea e della sua conoscenza del tedesco, non cedette mai, anche se gli facevano soffrire la fame. Recentemente mia sorella Bianca ha ritrovato a Como il suo diario di soldato e le sue lettere da prigioniero. Leggere quelle pagine mi ha emozionato moltissimo: da ogni frase traspare un senso della famiglia e della patria sinceri, radicati ma naturali, senza nessuna enfasi retorica. Per papà lo Stato era un valore superiore e probabilmente fu questo a farmi commuovere quando, il mio primo giorno alle Poste, vennero a prendermi all’aeroporto con una macchina che aveva, a fianco alla targa, la placchetta argentata rotonda con su scritto «Servizio di Stato».
Che cosa sognavano i suoi genitori per lei? Avrebbero voluto che si occupasse dell’attività di famiglia?
Avrebbe sicuramente fatto piacere a entrambi ma hanno sempre lasciato liberi noi figli di decidere che strada prendere. Non solo: fecero il possibile per spingerci ad andare fuori e fin da giovanissimi ci stimolarono ad allargare il più possibile l’orizzonte. Non è un caso che noi tre fratelli, dopo esserci laureati in Bocconi – una scelta che misteriosamente fece anche mia sorella Bianca, nonostante il suo temperamento più creativo –, abbiamo preso strade così diverse. Io diventai un manager, mia sorella Bianca aprì la sua società di pubblicità per poi passare a occuparsi dei nostri alberghi, in particolare delle ristrutturazioni, Antonello decise subito di continuare la tradizione di famiglia. La nostra libertà era comunque «condizionata» da una regola fondamentale che mi è rimasta dentro per la vita: qualsiasi fosse la scelta, bisognava portarla fino in fondo e al meglio. Era una delle tante cose su cui papà e mamma erano in piena sintonia. Mio fratello, per esempio, non entrò direttamente in azienda, ma fece una mezza dozzina di stage in giro per il mondo per conoscere dal basso tutte le funzioni di un albergo. Poi entrò da dipendente in Ciga (Compagnia Italiana Grandi Alberghi) e fece tutta la sua brava gavetta fino a diventare direttore d’albergo. Solo a quel punto mio padre gli permise di affiancarlo e gli cedette un po’ alla volta le sue responsabilità. Entrambi avevano personalità molto forti, ma furono bravi a gestire quel delicato passaggio generazionale che di solito è il momento in cui si schiantano molte famiglie imprenditoriali.
Un carattere risoluto, quello di suo fratello, a dispetto dei problemi di salute che hanno segnato la sua infanzia. Da bambino, infatti, soffriva di cuore. Questa sua fragilità ha condizionato in qualche modo il suo ruolo di primogenito?
Antonello era una forza della natura, era parecchio più scatenato di me. Eravamo ancora molto piccoli quando i miei scoprirono che aveva un difetto all’aorta. Fino alle medie la sua vita non è stata come quella degli altri bambini della sua età: non poteva mai stancarsi, tantomeno fare sport. Mi sentivo investito di una particolare responsabilità soprattutto quando d’estate ci mandavano in colonia da soli ed era sottinteso che avrei dovuto badare a lui. Ma alle medie tutto cambiò: i miei lo fecero operare a Parigi, in un centro specializzato, e da quel momento tutti i suoi problemi di salute furono risolti. Quell’estate in casa ce la ricordiamo tutti: mamma era a Parigi con Antonello, mentre mio padre aveva mandato me e mia sorella rispettivamente in Inghilterra e in Francia per studiare le lingue. Le vacanze studio sono sempre state una fissazione di papà: per lui era fondamentale che facessimo delle esperienze in ambienti diversi, fuori dal contesto familiare, per renderci forti e indipendenti. Quell’anno, mia sorella Bianca fu mandata per un mese a Montreux, da sola. Aveva solo nove anni, soffriva di solitudine e piangeva continuamente al telefono. Io avevo quattordici anni e invece mi stavo piuttosto divertendo ma, per confortarla, le scrivevo delle lunghe lettere dall’Inghilterra. Non solo: prima di rientrare in Italia decisi di farle una sorpresa e andai a trovarla. Non dimenticherò mai la sua faccia quando mi vide. Mi fece una tale tenerezza che le dissi: «Bianca, non ti preoccupare: adesso vado a casa e parlo io con papà».
Sua sorella Bianca dice di lei: «Corrado ha sempre sentito forte, su di sé, il ruolo del fratello maggiore; da bambino era particolarmente sensibile e anche protettivo nei confronti miei e di Antonello, tanto da intervenire più di una volta, con le sue doti diplomatiche, per ammorbidire certe rigidità dei nostri genitori». Ha raccontato, come esempio, quella volta che vostro padre vi portò a visitare un collegio. Ricorda quel giorno?
Il mitico collegio di Schwyz, come dimenticarlo. Papà voleva che Antonello imparasse il tedesco, quindi partimmo tutti e cinque per la Svizzera tedesca diretti verso questa scuola che nostro padre aveva selezionato tra le migliori. Quando entrammo nell’atrio, io e Bianca ci guardammo con orrore: mi ricordo un imponente scalone di pietra e un ributtante odore di minestra; se chiudo gli occhi posso ancora sentirlo. Papà ovviamente non fece una piega e si accordò con il rettore sull’iscrizione di Antonello per l’anno seguente. Quando finalmente fummo fuori, io andai da mia madre e le dissi: «Ma siete proprio sicuri di voler mandare Antonello qui? Avete deciso davvero? Dopo due giorni Antonello scapperebbe e avrebbe ragione». Non potevo crederci, quel collegio era davvero troppo.
Alla fine Antonello ci andò in quel collegio?
Per fortuna no. I nostri genitori non erano severi tanto per esserlo e capirono che non era la cosa giusta. Erano piuttosto rigorosi ma sempre per il nostro bene e quelle regole ci sono servite molto e hanno contribuito a tenerci sempre con i piedi ben piantati per terra. La componente più di introspezione, di guardare dentro le cose e trovare il loro significato profondo, mi venne invece da un sacerdote: don Virgilio Bianchi.
Era il vostro parroco?
No, era il mio professore di religione al liceo. Ma non si immagini il classico prete inquadrato, don Bianchi era decisamente illuminato e mi aiutò a capire quanto la fede può riempire di senso la nostra vita. Oltre a farmi capire il significato profondo della storia e della letteratura, don Bianchi mi insegnò che la religione andava ben oltre gli aspetti di rito, e mi aiutò a trasferirla, valori cristiani compresi, nella vita concreta di tutti i giorni.
Anche nel lavoro?
Certo. Anche il lavoro si può vivere da cristiani, se si è disposti a farlo diventare uno strumento per realizzare cose positive per gli altri. Don Bianchi mi insegnò come si vive in una comunità, spiegandomi l’importanza di regole chiave come l’accettazione del diverso. Tutte le volte mi stupivo di quanto tempo mi dedicasse: aveva così tanto da fare, eppure stava ore ad ascoltarmi, senza guardare mai l’orologio. Il senso di gratificazione e la felicità che mi dava, questo suo rimanere attento nell’ascolto, ha fatto sì che sempre, nella mia vita, mi sia preoccupato di comportarmi alla stessa maniera con le persone con cui venivo in contatto, per ragioni personali o di lavoro.
C’è stato qualche momento difficile che ricorda di aver superato grazie a don Bianchi?
È successo di sicuro, perché parlavamo di tutto. Ma io, come mio padre, tendo a rimuovere le cose negative o che sono state motivo di sofferenza; vado oltre e le dimentico velocemente. Di problemi a casa si parlava poco, c’era un certo pudore e la tendenza a risolverli da soli. D’altra parte la famiglia di mia madre era piemontese, piuttosto riservata per natura. Mio nonno materno è stata la terza figura maschile di riferimento per me.
Lo vedeva spesso?
Sì, perché mia madre tornava spesso a trovarlo e noi la accompagnavamo; ogni estate, da piccoli, appena finivamo la scuola, andavamo tutti a Vistrorio dal nonno tranne mio padre, che restava a Como a lavorare. A quella casa sono legati alcuni tra i ricordi più belli della mia infanzia; il nonno era un modello per me. Non era un semplice medico condotto, ma un punto di riferimento per tutta la sua valle, la Valchiusella: una persona seria che non esitava ad andare dove lo chiamavano o dove c’era bisogno, un tempo spostandosi a cavallo, da vero gentiluomo dell’Ottocento qual era. Aveva due figli: oltre a mia madre, un maschio che faceva anche lui il medico nella zona. Ero fiero e orgoglioso di essere suo nipote, cercavo di passare con lui più tempo possibile. Ancora oggi, se chiudo gli occhi, mi ricordo di quando ero piccolino e lo vedevo, dal suo studio dove riceveva al primo piano, scendere le scale di casa e raggiungermi in giardino, con il suo camice bianco e gli occhi buoni, nelle pause tra una visita e l’altra. Curava le sue rose e mi spiegava nel dettaglio le differenze tra le varie specie.
Tornando al lago, che rapporto c’è con il paesaggio della sua infanzia?
Il lago per me è casa, armonia e bellezza. Mi piace guardarlo nelle limpide giornate di sole, dopo che il vento ha spazzato via le nuvole, ma anche in quelle di nebbia e bruma che a molti fanno malinconia ma a me per nulla. Sarà che la malinconia è uno stato d’animo che non conosco, come del resto la nostalgia: guardo sempre avanti, non fatico a l...