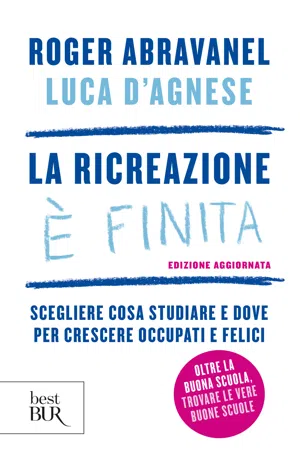![]()
IV
Come scegliere?
![]()
14
Le prime scelte, dopo le medie inferiori
«La cosa più importante di tutta la vita è la scelta di un lavoro ed è spesso affidata al caso.»
BLAISE PASCAL
In molti Paesi del mondo in cui le famiglie danno molto valore agli studi dei loro figli, si compiono grandi sforzi per scegliere le scuole migliori. E queste scelte vengono fatte il prima possibile. In Cina, Corea e Giappone è essenziale riuscire a entrare nelle scuole elementari migliori, da cui gli studenti potranno accedere alle scuole medie più selettive, che a loro volta garantiranno l’accesso alle più importanti università. In diverse città degli Stati Uniti il prezzo delle case è più alto se il quartiere dove si trovano consente l’accesso agli asili e alle scuole elementari migliori.
Questo carico di aspettative sugli studi di bambini ancora nel pieno dell’infanzia è oggetto di molte critiche da parte di pedagogisti e psicologi di tutto il mondo. E le autorità scolastiche dei Paesi interessati stanno valutando cosa fare. Lo stress per gli studenti e le loro famiglie è elevato e tanti ritengono che non ne valga la pena. In questi Paesi una delle domande più importanti che si deve porre la famiglia è come bilanciare le giuste motivazioni con un carico di stress accettabile, come spingere i figli sul percorso per loro migliore equilibrando i successi scolastici con le aspettative di un’infanzia normale.
In Italia la situazione è molto diversa: di fatto, scegliere la scuola elementare e media basandosi su criteri di eccellenza o di affinità tra il programma e la vocazione o gli interessi del ragazzo è un evento rarissimo. E, a giudicare dai casi più estremi che si verificano all’estero, non è detto che sia un male.
Alle superiori però il quadro si fa diverso. Non perché l’interesse per le scuole eccellenti si stia diffondendo anche da noi, ma perché sarebbe bene che lo fosse. Perché voler proteggere a tutti i costi i nostri figli dallo stress diventa, da una certa età in avanti, eccessivo e controproducente, anche perché la disinformazione e il pregiudizio che conducono a scelte sbagliate cominciano a pesare in maniera significativa sul futuro dei ragazzi. All’uscita dalle superiori un ragazzo è nell’età in cui inizia a confrontarsi col mondo del lavoro, deve prendersi le sue responsabilità e affrontare un certo livello di stress, mentre si riducono i margini di recupero per un’educazione insufficiente.
Come scegliere allora nel modo più corretto la scuola dei nostri figli? Molto dipende dalla personalità, dalle aspirazioni e dal talento dei ragazzi, mentre non dovrebbero contare le decisioni prese troppo presto sulla carriera da intraprendere, a partire dalla domanda che si fa a tutti i bambini: «Cosa vuoi fare da grande?». Alla quale sconsigliamo di rispondere.
Non chiedersi mai: «Cosa voglio fare da grande?»
Per diversi secoli la nostra civiltà ha offerto ben poche possibilità di scelta ai giovani: i ragazzi ereditavano il mestiere dei padri. Nelle famiglie nobili, con l’eredità che andava al primogenito, i figli minori potevano scegliere (quando non sceglieva la famiglia per loro) tra la vita militare e il clero. Per le donne, la domanda generalmente riguardava il loro matrimonio.
Solo nel secolo scorso i giovani, maschi e femmine, hanno avuto qualche reale possibilità di scelta. Certo, la trasmissione del mestiere di padre in figlio è rimasta, almeno in Italia, ancora (troppo) diffusa. Ma molti hanno avuto l’opportunità o la necessità di fare una scelta diversa. E per quasi tutti optare per un mestiere, che fosse quello di famiglia o meno, significava decidere un «percorso» coerente che partiva dagli studi, proseguiva con l’ingresso nel mondo del lavoro – in azienda, nella pubblica amministrazione, in uno studio professionale – e si sviluppava in una carriera che seguiva anch’essa un percorso ben definito.
Oggi sappiamo che le cose sono diventate più complicate. Che i percorsi spesso non funzionano, che l’ingresso nel mondo del lavoro è sempre più difficile e la carriera sempre meno pianificabile. Eppure in molti (troppi) continuano a cercare la logica del percorso definito. Spesso è quello che viene dalla tradizione della famiglia o dalle aspirazioni dei genitori, con i problemi che abbiamo visto. Ma anche quando la scelta non è eterodiretta, e sembra perciò più direttamente legata alla vocazione individuale, può nascondere una trappola. Che è quella di bloccarsi in una strada senza uscita e rinunciare alle opportunità che la vita intanto ci offre.
Questa scelta sbagliata parte dalla domanda: «Cosa voglio/vuoi fare da grande?» e coinvolge schemi mentali come quello che ci porta a «cercare una strada». Il che presuppone che la strada esista, sia già segnata anche se nascosta, e si tratti solo di trovarla. Spesso con l’aiuto da quegli stessi genitori (e nonni) che dicono di aspettare la fine degli studi per iniziare a lavorare.
È uno schema sbagliato, perché nel mondo di oggi, con le possibilità e le incertezze che crescono a dismisura, cercare di pianificare tutte le scelte della vita è una strategia perdente. Bisogna fare come il giocatore di scacchi che, quando inizia il gioco o anche nel corso della partita, non si chiede come farà a dare scacco matto, ma come conquistare una posizione forte, che gli consenta di difendersi, non lo esponga a rischi eccessivi e gli dia le massime opportunità per il prosieguo del gioco.
Questo non significa non specializzarsi in nulla. In molti casi (ovviamente non per discipline come la medicina), una specializzazione serve come «biglietto d’ingresso» più che per l’effettiva utilità della materia studiata sul lavoro. Perché serve all’inizio della carriera in azienda, anche se molto meno dopo. E perché i datori di lavoro apprezzano la capacità di conseguire risultati in campo scolastico o accademico.
Uno dei valori principali della specializzazione è quello di consentire allo studente di affrontare problemi veri, che nella maggioranza degli studi generali, anche universitari, spesso mancano. Per quanto si seguano programmi all’avanguardia, che si basano su efficaci simulazioni di problemi reali attraverso il case study o la realizzazione di progetti, si tratta appunto di simulazioni, ovvero di situazioni artificialmente semplificate in modo da consentire allo studente di padroneggiarne gli elementi essenziali senza bisogno di mesi di lavoro. I problemi reali, viceversa, offrono una gamma di sfide pratiche e concettuali che nessuna simulazione potrà eguagliare.
Partecipare a un esperimento scientifico vuol dire far parte di un team che progetta e realizza l’apparato sperimentale, occupandosi di questioni tecnologiche ma anche di budget, che fa i calcoli per progettare lo strumento di misura, che scrive o adatta i programmi che acquisiscono i dati e li analizzano, e che all’occorrenza ripara lo strumento se si rompe. Oltre ovviamente a registrare, interpretare e comunicare i risultati dell’esperimento.
E questo non si applica solo alla ricerca scientifica, ma vale per qualsiasi attività. Gli studenti che, negli istituti alberghieri all’avanguardia, imparano a confrontarsi con i problemi reali della cucina di un ristorante (approvvigionamenti, organizzazione del lavoro, utilizzo di tecnologie per le preparazioni più sofisticate) devono saper padroneggiare una conoscenza specialistica. Confrontarsi con problemi reali è un modo diverso di imparare rispetto all’apprendimento teorico basato su nozioni preconfezionate.
Il modello di specializzazione vincente lo abbiamo già descritto ed è la «T» del progetto Oivallus. Le soft skills sono rappresentate dalla barra orizzontale e la specializzazione da quella verticale.
Ma se la scelta di «cosa si vuol fare da grande» non ha molto senso, e la specializzazione derivante dall’esperienza che si fa direttamente sul lavoro conta di più delle tecniche che si apprendono a scuola, quali sono le scelte, le mosse che, all’uscita dalle medie, rafforzano la posizione di uno studente nella partita a scacchi per il lavoro futuro?
La prima, che sembrerà banale ma è largamente sottovalutata, è partire da quello che il ragazzo sa fare e ha voglia di fare nell’immediato, per scegliere la scuola che lo valorizzi al meglio. A partire dalla domanda: quale tipo di scuola?
La scuola superiore più giusta
La prima domanda che gli studenti e le loro famiglie si devono porre alla fine delle medie inferiori è: liceo, istituto tecnico o professionale? Negli ultimi trent’anni gli iscritti al liceo, classico e scientifico, sono aumentati dal 23 per cento al 33 per cento (con una grande crescita dello scientifico a scapito del classico), mentre è diminuita in misura pressoché uguale la percentuale di iscritti agli istituti tecnici (dal 45 per cento al 33 per cento). Il 10 per cento di aumento degli studenti liceali si riflette in un aumento analogo (dal 53 per cento al 63 per cento) dei diplomati che si iscrivono all’università.
Una fotografia tutto sommato abbastanza simile da una generazione all’altra. E infatti per molti studenti la scelta della scuola superiore è spesso scontata e dipende ancora molto dal background familiare. Le famiglie di tradizione benestante, infatti, scelgono spesso il liceo. Purtroppo ancora oggi un’indicazione, anche se indiretta, di quanto pesi il ceto sociale nelle scelte scolastiche è data dall’ubicazione delle scuole all’interno delle città, con le scuole «d’élite» in centro e quelle più «popolari» in periferia. A Milano, per esempio, otto licei classici su dieci sono nelle zone centrali e semicentrali, mentre gli istituti tecnici nelle stesse zone sono due su quindici. Considerando che il criterio principale di ammissione è ancora la residenza vicino alla scuola, si capisce che la distribuzione delle scuole riflette in buona misura quella degli alunni.
Alessandro Lega della Federazione maestri del lavoro sostiene che «in Italia l’orientamento è molto più indietro che in altri Paesi. In Francia e in Germania si inizia dalle elementari a valutare i punti di forza e debolezza degli studenti e si continua fino alle superiori, così che la scelta di quale tipo di scuola superiore fare è il risultato di un periodo abbastanza esteso. Da noi la scelta viene fatta all’inizio dell’anno solare dell’ultimo anno delle medie, basandosi su pochi elementi oggettivi e molto spesso sulla base di aspetti emotivi fortemente influenzati dai genitori…».11
E allora, che fare? È difficile offrire raccomandazioni sensate e valide per tutti, e le scuole di uno stesso tipo sono anche molto diverse tra loro, esistono pessimi licei e ottimi istituti tecnici e professionali, ma i tassi di occupazione dicono che la scelta di frequentare l’università è mediamente quella più giusta. E il liceo rimane nella maggior parte dei casi la scuola migliore per prepararsi a una laurea, soprattutto al centro-sud, con buona pace dei sostenitori a spada tratta dei diplomi cosiddetti «utili».
Lo dicono, contrariamente ai luoghi comuni, gli stessi datori di lavoro. Lorenzo Biffi di Adecco lo afferma in modo chiaro: «A meno che non si abbia qualche particolare passione, fare il liceo premia sempre, a condizione ovviamente di averne le capacità». Lo dicono i risultati degli ultimi test Pisa e Invalsi, in cui i licei ottengono un punteggio medio in italiano e matematica, rispettivamente di 217 e 212 contro 194 e 199 degli istituti tecnici e 167 e 173 degli istituti professionali. Si potrebbe sostenere che queste competenze siano meno determinanti per fare il cuoco o il barista, non però per fare l’imprenditore della ristorazione, come magari è nelle aspirazioni di un ragazzo che frequenta l’alberghiero. Lo stesso vale per un impiegato del marketing in amministrazione o un tecnico di laboratorio in azienda, che sono le professioni cui dovrebbe preparare l’istituto tecnico: sapersi esprimere nella propria lingua e capire la matematica sono essenziali. E, mediamente, gli istituti tecnici formano queste competenze meno dei licei.
Esistono ovviamente le eccezioni: in provincia di Trento gli allievi degli istituti tecnici hanno un punteggio alle prove di matematica pari a quello dei liceali nella stessa provincia (e superiore a quello della media dei licei del resto d’Italia). Molte scuole d’eccellenza, tecniche e professionali, in altre parti d’Italia potranno sicuramente vantare risultati simili. Ma in media in tutte le regioni italiane, a eccezione della provincia di Trento e della Sardegna (in cui sono invece i licei ad andare male), i punteggi Invalsi dei licei superano quelli degli istituti tecnici di 10-15 punti e quelli professionali di 30-40.
Ovviamente la causa di queste differenze non è detto che risieda nella formazione ricevuta alle superiori. Gli alunni più bravi tendono a scegliere i licei, così come quelli provenienti da famiglie più acculturate e tendenzialmente benestanti. Si crea così una polarizzazione – famiglia benestante-alunni bravi-liceo e famiglia poco acculturata-alunni meno bravi-istituto professionale – che ha una componente meritocratica (che riguarda le capacità) e una antimeritocratica e classista (che riguarda il ceto e la zona in cui si abita).
Che piaccia o meno, questa polarizzazione è un dato di fatto nel nostro Paese. A partire da questa consapevolezza, si danno diverse strategie possibili. Quando lo studente va bene a scuola, anche e soprattutto se lo fa superando l’handicap di una famiglia di estrazione sociale meno elevata, la famiglia dovrebbe fare di tutto per mandarlo prima al liceo e poi all’università, perché quelli che seguono questo percorso hanno più probabilità di trovare lavoro e di guadagnare di più. Quando lo studente non va tanto bene a scuola, invece, si presentano due possibilità. Una, adottata dalla maggioranza delle famiglie con genitori diplomati o laureati, punta a mandare i figli nelle scuole migliori, scegliendo quasi sempre il liceo o, in qualche caso, almeno l’istituto tecnico. L’altra, raccomandata da molti professionisti del mondo della scuola, punta a non forzare il ragazzo in un percorso di studi in cui rischia di fallire: al liceo, uno studente non preparato ha buone probabilità di non farcela. E infatti i numeri degli abbandoni e delle bocciature nelle prime classi sono elevati.
Spesso, dunque, i genitori fanno troppe pressioni, soprattutto quando si tratta di professionisti: si considerano gli istituti tecnici scuole di serie B, ma è un paradosso perché chi ha un livello culturale medio-alto dovrebbe avere anche l’apertura mentale sufficiente per uscire da un sistema di gerarchie scolastiche del tutto opinabile. Anche gli istituti tecnici, se fatti bene, offrono la preparazione necessaria per frequentare l’università.
Bisogna dunque cercare di tenere in seria considerazione le disposizioni e le capacità dei ragazzi, ma allo stesso tempo evitare di dare per insuperabili le difficoltà che possono incontrare negli studi. Come quando sentiamo dire che qualcuno «non è portato per la matematica», dando così per scontato che le nostre capacità, la nostra intelligenza siano caratteristiche innate e immutabili. Come in tutte le abilità umane, l’allenamento e l’impegno fanno una differenza enorme.
Quindi l’unica raccomandazione che possiamo fare è di scegliere una scuola con standard di difficoltà alla portata del ragazzo, ma che richiedano il suo impegno per raggiungerli e che offrano attività e programmi che lo stimolino davvero, evitando i preconcetti.
Troppo spesso, invece, il consiglio dei professori delle medie di lasciar perdere il liceo e andare in un istituto tecnico o professionale arriva in una famiglia di genitori laureati come una doccia fredda. Le scuole medie inferiori alla fine danno a tutti la sufficienza, e i genitori la prendono come un segnale che tutto va abbastanza bene. Quindi non si adoperano per far nascere nei loro figli quel misto di curiosità intellettuale e voglia di impegnarsi che costituiscono due ingredienti fondamentali per il loro sviluppo personale e l’inserimento nella società. Troppo spesso, confortati dai falsi incoraggiamenti di voti un po’ regalati, si rendono conto della situazione quando è ormai troppo tardi.
L’indicazione da parte dei professori delle medie su quale percorso intraprendere prende di solito la forma di una lettera di poche righe scritta dalla docente d’italiano, che ha la delega informale da parte del consiglio di classe sull’orientamento, perché è quella che passa più tempo con gli studenti. Secondo molti presidi questo processo è imperfetto per due ragioni. La prima è che i genitori sono impreparati, perché non hanno passato abbastanza tempo a parlare con tutti gli insegnanti per capire i punti di forza e di debolezza dei propri figli, indipendentemente dai voti. La seconda è l’influenza preponderante, nel giudizio, del docente d’italiano, che giudica spesso come lo studente scrive o si esprime oralmente più che, per esempio, la sua capacità di risolvere problemi. Per questo l’unico modo per i genitori e i ragazzi di prendere la decisione giusta è avviare un processo che inizi molto prima e che preveda una discussione continua tra genitori, insegnanti e studenti, volta più a comprendere cosa debba fare il ragazzo per migliorare un voto che a negoziare un voto più alto.
Un passaggio u...