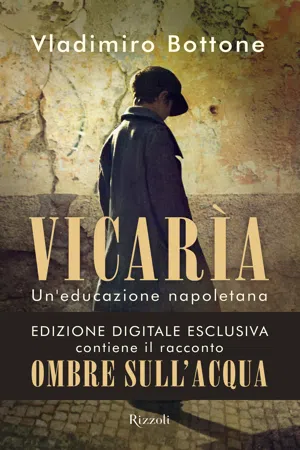![]()
1
Un lampo giallastro, uno schianto. Il fulmine ha spaccato in due il crepuscolo su Napoli. Questa fenditura ha aperto le cateratte. Per i vetturini, i carrettieri neanche il tempo di lanciare i cavalli al trotto e si è scatenato il diluvio. Un cielo fangoso sopra, la terra fangosa sotto. Questo gorgoglio limaccioso dalle colline che incombono sulla città. In un quarto d’ora il nubifragio ha già trasformato i pendii di Capodimonte in un ribollire di acque piovane. Dalla sommità dei Camaldoli iniziano a gonfiarsi, senza più argini, torrenti di pioggia e melma. Da Materdei, da Santa Teresa, dal Cavone queste masse alluvionali precipitano a valle, verso la loro fossa biologica, il loro ricettacolo naturale: Napoli.
Anche dal canyon di San Rocco le acque pluviali prendono velocità attraverso i valloni, si incanalano ciecamente per le strettoie nel tufo. È la lava di Napoli, il suo scolo. Una fiumana che, presto, comincerà a ruscellare pure di fianco a quest’immenso edificio, spettrale dietro il velo d’acqua: il Reale Albergo dei Poveri. Una cittadella autosufficiente, una città nella città. Un reclusorio, un ospizio di mendicità, un brefotrofio. Un ricovero destinato ai vecchi inabili, alle donne perdute e all’infanzia che si perderà. Per i napoletani è il Serraglio. Come a dire una specie di carcere. Un’opera mastodontica, nata con l’ambizione megalomane di risanare le sette piaghe cittadine. Quasi da subito, però, si è aggiunta a esse divenendone l’ottava. Ottava e, come tutte le cose nate storte, ugualmente indistruttibile. L’impressione, difatti, è che le sue mura ciclopiche non temano neanche un Giorno del Giudizio come questo. Perché, in verità, niente riuscirebbe ad allagare il Serraglio. Al massimo il nubifragio può affogarne la visione in quest’aria fosforescente, che somiglia a un abbassamento della vista. Una sorta di cecità come quella calata su Antimo che se ne sta qui, vicino a uno dei dormitori, accucciato in fondo alla cesta. Una delle canestre in vimini, alte quanto un cristiano, dove ammucchiano la paglia usata e i cambi settimanali delle lenzuola. Lenzuola fetide di polluzioni, sudore, piscio irranciditi. Inevitabile, visto che là dentro si sono voltati e rivoltati centinaia fra bambini e adolescenti come lui. Idem per la paglia, usata per riempire i materassi. Così si è formato un ammasso che schiaccia Antimo sul fondo di vimini, non lo fa quasi respirare. Un’oppressione che gli grava addosso e gli lascia sì e no un filo di ossigeno. Quanto basta, comunque, per tenere in vita una ridda di pensieri ossessivi. Sempre quelli. Non è che i facchini si mangeranno la foglia e andranno a chiamare il superiore? Allora sì che lui sarebbe spacciato: quello è capacissimo di mozzargliela, la testa. Con le mani sue. Altro rischio: gli ultimi ragazzi a rientrare in camerata. I più grandi. I caporioni che, ogni tanto, si sfogano prendendo a pedate tutto ciò che trovano. Quante volte si sono divertiti a far capitombolare le ceste per le scale. E a mimetizzarsi in mezzo agli altri, prima che il Sergente raduni nuovamente fuori la compagnia, per l’estrazione a casaccio del colpevole… Ancora: non è che la canestra si sfonda appena tirata su, con lui dentro? Non sarà che è diventato troppo pesante?
Per fortuna chi non ha nulla da perdere, come Antimo, può contare almeno sulla forza della disperazione. Sull’istinto di sopravvivenza, che prende a infondergli coraggio nel buio. Ma quale peso e peso se lui tiene sette anni e le sue sono quattro ossa gracili con poca carne malnutrita attorno. Una carne a cui Antimo, intirizzito com’è per l’umido e la tensione, rinuncerebbe con tutta l’anima. Specie adesso: deflagrato l’ennesimo tuono, gli sembra di distinguere un mormorio in avvicinamento.
Capace che è la ronda di guardia, il turno serale che monta. Solo che non è il loro giro di sempre. Non è che, in dormitorio, hanno già fatto e rifatto l’appello? I grandi occhi scuri del bambino, dilatati fin quasi a scoppiare. Fare la conta delle voci: se sono quattro è la ronda, è l’Inferno.
Tutto come previsto, invece: si tratta solo dei facchini, quelli dell’ultimo carico. Sono andati a procurarsi un sacco di tela grezza, l’hanno scucito per ricavarne un paio di cappucci. Fuori è malacqua.
«Masto Pe’, ma nun putìmmo aspetta’ ca schiove?»
«Eh, accussì chiste ce chiudono dinto…»
Hanno paura di restare chiusi dentro, i liberi. Non sono nati in cattività come Antimo.
«No: è meglio ca ce facimmo vede’. Scennìmmo abbascio e ce facimmo vede’. Si po’ schiove, scarichiamo e ce ne iammo a casa.»
Lo scricchiolio della cesta, le cinghie in trazione.
«Pronto? Uno, doie e tre.»
Hanno issato sulle stanghe il carico dei due cestoni, appesi per delle corregge di cuoio. Antimo comincia a essere sballottato. Il dondolio. Adesso non si torna più indietro. Non gli rimane che masticare la solita giaculatoria. Impetrare una grazia a chella bella Maronna d’o Carmene. Serve come scongiuro. Serve per drogare una metà del suo cervello, mentre l’altra è tesa a carpire ogni minima eco da fuori. Conferme sul percorso, per esempio. Pressato com’è in fondo al carico, Antimo può solo fare affidamento sull’udito. La sua ricostruzione, momento dopo momento, come fosse un cieco. Uno dei tanti che, nei suoi sette anni di vita, ha visto brancolare qui al Serraglio, tastando mura e porte.
Addo’ stammo? Dove siamo? Il passo regolare dei portatori, l’acustica sorda di questi interminabili corridoi tenebrosi anche in pieno giorno. Un difetto di concezione, il loro peccato originale. Le loro volte unghiate, troppo alte. Le poche finestre troppo elevate, pochi sfoghi di luce e aria.
Antimo riceve il primo, vero sobbalzo. Sono cominciate le scale, consumate giorno per giorno da centinaia e centinaia di piedi. I gradini di quest’ala, che Antimo conosce uno per uno. La loro pedata larga e l’alzata quasi piatta. Tre rampe, Antimo tiene il conto: diciotto gradini per arrivare ai dormitori del piano di sotto. D’improvviso uno scossone ha sbilanciato tutto. La bestemmia. Uno dei vastasi alla stanga era lì lì per perdere l’equilibrio.
«Addirizza! All’ànema ’e chi t’è vivo!»
Ora le ceste si sono riequilibrate, pare. Comunque c’è mancato un pelo che si ribaltasse tutto, incluso il clandestino.
E se lo scoprono? Antimo se lo sta tornando a chiedere. Come fa meccanicamente, ossessivamente dall’altra notte. Da quando gli è caduta la benda, con un bagliore ancora più accecante di quelli che lampeggiano sulla facciata chilometrica del Serraglio. La ripresa dei gradini, della discesa. Che gli fanno, se mò lo trovano? La risposta è nello scoppio del tuono. È nei tonfi del suo cuore da lepre spaurita. È nelle unghie con cui si incide la carne del braccio, per non pensare. Per non pensare se non a questo: che la fuiùta, intanto, va avanti. Procede. La seconda tesa di scale è finita. Qua dobbiamo stare vicino alla Cappella. Mò comincia il corridoio del piano terra. Si passa vicino al teatro, alla Fabbrica degli spilli, dove i serragliuoli si consumano dita e occhi. Il reparto delle piastre da fucile viene più avanti. Siamo in un corridoio lungo venti finestroni, tutti con delle grate impossibili da passarci in mezzo o da segare. Staremo sfilando di fianco alle stanze del Segretariato, l’archivio dove è vietato l’ingresso… Un corridoio lento, interminabile, ma destinato a finire come tutto. A finire male. Con quest’intimazione militaresca.
«Chi è là? Chi va là?»
Antimo si è sentito morire. Anche se doveva aspettarselo: a pianterreno staziona in perpetuo il corpo di guardia. Due piantoni detti quartiglieri, agli ordini di un caporale. Il Serraglio è come una caserma. Questi hanno delle consegne tassative.
«Chi è là? Chi va là?»
«Bellu gio’… E chi dobbiamo essere?» il capoccia tra i due facchini, «simmo nuie: paglia e lenzòla.»
In secondo piano, la voce irridente del capoposto.
«Ah, ’e lutammàre.»
Da lutàmma: raccoglitori di merda equina e paglia, ottima per concimare. A parità di peso vale più di un serragliuolo.
«Falle passa’, falle…»
Il capoposto, stavolta con degnazione. Andrà per i diciassette anni: sarà uno dei grandi, con la schiena brufolosa. Il solito mezzo guappo, tutto tronfio con la divisa di un soldato morto che gli hanno aggiustato addosso. La sua sarcastica raccomandazione.
«Passate, passate. Vedite sulo e nun v’nfònnere.»
Il suo subalterno – un quindicenne non ancora incallito – è meno strafottente.
«Ve cunvenésse ’e aspetta’. Magari, a ’n’atu poco, schiove.»
Mentre, per il momento, la pioggia flagella ancora la facciata dell’Albergo. L’unico carro in circolazione sta provando a guadare la spianata davanti al Serraglio; il padrone frusta e bestemmia come un invasato.
«Ve cunvenésse ’e aspetta’. Magari, a’n’atu poco, schiove.»
Come Antimo temeva, la coppia di facchini si è lasciata convincere. Le sue preghiere sono rimaste inascoltate. Capita, a volte, che la Madonna del Carmine ruoti i suoi occhi bizantini da qualche altra parte, verso qualche altro supplice. Fermi, dunque. E ad Antimo sembra d’impazzire, vorrebbe mettersi a scalciare, dare sfogo alla disperazione. Come può essere? Fermi a trenta passi dal portico a tre archi, dal cancello finale. Poco più in là, come sa ogni napoletano, la vistosa scala esterna a doppio braccio. Altri diciotto gradini allo scoperto. Poi, finalmente, quel crocevia aperto in tutte le direzioni. Il Borgo di Sant’Antonio Abate, lo stradone di Foria, la barriera del Dazio, la via del Campo, che s’inerpica verso Poggioreale…
E allora, come può essere? Come può essere che proprio mò il bicchiere d’acqua si ritira dalla bocca dell’assetato? La Madonna bruna: è stata lei a negargli il proprio soccorso. Quella bella Mamma l’avrà disconosciuto per via del suo unico peccato mortale. L’origine di tutte le sue disgrazie, la causa di questa fuga. Il confessore l’aveva chiamato così: un peccato che grida vendetta al Signore.
Antimo non può accorgersene, nell’ottundimento del suo nascondiglio. In realtà sembra che il piovasco voglia dare un po’ di tregua. Il prospetto dell’Albergo non è più schiaffeggiato con l’inclemenza di prima. Addirittura pare quasi che laggiù, in linea con i tetti piani dell’Arenaccia, si stia riaprendo una palpebra di chiaro. Forse si tratta dell’occhio provvidenziale che veglia sugli orfani derelitti come Antimo.
«Ccà sta schiuvenno. Iammuncenne.»
La voce rediviva del facchino più vecchio. Vorrebbe approfittare della schiarita imminente per trasbordare i cesti sul carretto e chiuderla, la sua giornata di fatica.
«E forza, iatevénne» la voce annoiata del capoposto. Ora lui e un suo subalterno si staccheranno dalla guardiola per scortare gli uomini di fatica fino all’uscita. Così succede. Il capoposto e l’altro orfano di guardia – il quindicenne dal largo faccione paesano – si sono affiancati alle due ceste, al loro traballare passo dopo passo. L’aria della libertà che si lascia quasi odorare. Eppure Antimo prova un’incredibile fitta di nostalgia per il Purgatorio che si sta lasciando alle spalle. È l’altra faccia della paura per l’ignoto che gli si spalanca davanti. Napoli lo aspetta, Babilonia ha già le fauci spalancate.
Lo sferragliare delle chiavi l’ha fatto sussultare. La cancellata che cigola. Un gemito, come davanti alle porte del Paradiso in procinto di socchiudersi.
Antimo, di nuovo librato a mezz’aria. Di nuovo il buio della cesta che si è messo a ondeggiare. Antimo la sospinge avanti con la forza disperata del pensiero. Le tre arcate dell’ingresso, le volte a crociera che scorrono sulla testa dei vastasi. Per Antimo si prospetta nuovamente un futuro, la salvezza. Non morirà senza avere vissuto. Fra poco, il tempo di quattro Pater e un Gloria, dovrà ingegnarsi con tutta la sua vitalità per sgattaiolare senza farsi scorgere dai vastasi. Il resto sarà come una corsa della lepre in mezzo ai campi.
Un nuovo arresto, di botto. Stavamo quasi fuori… Che altro è successo, mò? Gli occhi di Antimo, ingranditi nell’oscurità. Non può sapere che una folata di vento, semplicemente, ha fatto volare via il berretto a uno dei facchini. Questo berretto infeltrito con la visiera, che un elastico invisibile attira fino ai gradini di marmo della scala esterna, scivolosi di pioggia. Un contrattempo banale. Un imprevisto fatale. Sfortuna, malaciorta, casualità. Nel grande Lotto dell’esistenza è stato estratto il numero sbagliato. Uno sbattere di tacchi. Posizione di at-tenti!
«Vuie! Addo’ iate?»
Una voce terza, metallica. Si è stagliata sulla testa di Antimo, poi si è abbattuta come una ghigliottina. In uno con quest’intimazione.
«Turnate arrèto! Indietro, forza!»
Un comando che non ammette discussioni, che le previene sul nascere.
«Senza fa’ storie: ispezione! Iammo a ce mòvere!»
Nessuno fiata. Per miglia intorno si può sentire solamente il cuore di Antimo che pulsa impazzito, come quello di una lepre credutasi cucciolo di volpe – e oramai accerchiata dai cacciatori.
«Ccà! Pusàte ccà ’nterra!»
Il brontolio di tuono in allontanamento. Il brivido tra le fronde degli alberi, che iniziano a tremare come le ossa infreddolite di Antimo. Il terrore, senza più argini.
Lui l’ha riconosciuto il proprietario di quella voce rasposa. ’O Cummannante, il Comandante. Don Michele Florino. Antimo vorrebbe poter minimizzare, ma sa bene...