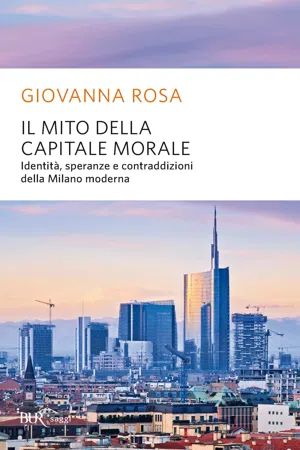![]()
1
Milano e l’Esposizione del 1881
Per Walter Benjamin le esposizioni universali segnano un passaggio cruciale nel clima ideologico e artistico che caratterizza l’età dello sviluppo capitalistico.
Le esposizioni mondiali edificano l’universo delle merci. […] La fantasmagoria della città capitalistica tocca la sua espansione più radiosa nell’Esposizione universale del 1867.
I promotori dell’Esposizione delle Arti e delle Industrie, allestita nel capoluogo lombardo nel maggio del 1881, erano certamente ben lontani dallo spirito spettacolare descritto da Benjamin in Angelus Novus: non solo Milano non era Parigi, secondo un ritornello comune e diffuso, ma soprattutto la filiera delle manifatture e del commercio di cui la Mostra dava conto non ammetteva paragoni con i traguardi raggiunti dai paesi europei.
Eppure, al di là dello scarto evidente fra le due capitali, con l’Esposizione del 1881 anche Milano si impegna a offrire ai visitatori una festa coinvolgente, tesa a celebrare l’avvio del processo industriale: la città, mettendo in vetrina la propria immagine solare, si dichiara decisa a percorrere senza incertezze o tentennamenti la strada intrapresa.
L’evento, che coinvolse l’intera collettività ambrosiana, esprimeva lo slancio espansivo di cui erano dotate le forze imprenditoriali più dinamiche della penisola: quei padiglioni, pieni di merci e prodotti, rappresentavano l’operosità infaticabile di una città che, a vent’anni esatti dalla costituzione dello Stato unitario, si proclamava con fierezza «la capitale morale d’Italia». Versione moderna del vecchio proverbio popolare «Milan dis, e Milan fa», l’espressione rilanciava il senso di orgogliosa supremazia maturato durante le Cinque giornate del ’48, quando tutto il popolo ambrosiano insorse contro gli austriaci: il 18 marzo, «Milano mandava, dopo tanta pazienza e soggezione, il suo formidabile grido di collera»; il 23 marzo, mentre le truppe di Radetzky lasciano la città, «il sole fulgido dava alle strade affollate un giulivo aspetto di festa». La doppia citazione è tratta da Entusiasmi, romanzo di Roberto Sacchetti uscito in quello stesso 1881.
Sull’onda travolgente delle musiche del Ballo Excelsior, allestito per l’occasione al Teatro alla Scala, l’Esposizione voleva testimoniare il fervore con cui la città riaffermava il suo ruolo di guida, orientando l’antagonismo polemico non più verso la Torino sabauda, ma verso Roma, capitale politica della nazione unita.
Milano rivendica il suo primato – capitale morale, non ufficialmente accreditata – in nome di un paradigma di valori radicati nella modernità urbano-borghese: la ricca e operosa società civile si faceva portavoce della nuova etica del lavoro produttivo.
A dare corpo alla mitologia ambrosiana è la riflessione collettiva che si sviluppa nel capoluogo lombardo a cavallo degli anni Ottanta, quando, sotto la spinta delle suggestioni della sociologia positivista, intellettuali e ceti dirigenti si interrogano sui destini futuri dell’area milanese. Espressione privilegiata di queste tensioni ideologiche e culturali è la serie di opere che vengono pubblicate a complemento della Mostra: Mediolanum, in quattro grossi tomi per i tipi di Vallardi; Milano 1881, edizione Ottino; Milano e i suoi dintorni, pubblicato da Civelli.
Questi volumi compongono pagina dopo pagina il ritratto a tutto tondo di una comunità urbana che si è ormai avviata a sciogliere il «paradosso delle “città del silenzio”» (Gramsci), acquistando quei caratteri originali che a tutt’oggi la definiscono: un’idea di progresso cauto, capace di legare l’interesse del singolo al bene comune; un sapere «positivo» ancorato ai principi di laica tolleranza e solidarismo caritatevole; il culto dell’efficienza pragmatica, che si traduce in «cose serie, cose sode»; la promozione delle «utili cognizioni» nel rifiuto delle utopie astratte e delle teorie speculative; la ricerca costante delle mediazioni e dell’equilibrio; la diffidenza accentuata verso la dimensione politica a cui si contrappone il buon funzionamento della macchina amministrativa. Norma suprema il buon senso, che è misura di ordine e moralità.
Dai libri che illustrano l’Esposizione emerge un’immagine ideale di collettività che compone in sintesi «l’unico mito ideologico serio, non retoricamente fittizio, elaborato dalla borghesia italiana dopo l’Unità» (Spinazzola), così radicato nello spirito cittadino da oltrepassare la soglia del XIX secolo e prolungarsi, anche se in modo discontinuo e contraddittorio, per tutto il Novecento.
Sullo sfondo di piazze e strade animate da una folla attivamente affaccendata, la «città più città d’Italia» – come la definisce Verga in un articolo scritto per Milano 1881 – mostra il suo volto cordiale e laborioso, sollecitando l’intera comunità a riconoscersi nei principi della nuova etica produttiva. Il progetto è possibile grazie al fervore intraprendente di un’editoria che si sente comprimaria dell’evento. Vallardi Ottino Civelli, e poi Hoepli Treves e Sonzogno chiamano a raccolta le schiere di intellettuali umanistici e scientifici che operano nel capoluogo lombardo: tutti accolgono l’invito, ingegneri ed economisti, tecnici e scienziati, letterati e giornalisti.
Progetti ideali, ipotesi strategiche e convergenze professionali si saldano in una operazione ad ampio raggio che, dichiarando apertamente la sua borghesità, assume uno spessore originalmente moderno.
Il compito di tratteggiare il ritratto a tinte terse e nitide della capitale morale era tanto più urgente quanto più acceso era lo sdegno con cui i «palombari del sottosuolo sociale» si accanivano a lanciare invettive violente contro la corruzione cittadina. Le inchieste giornalistiche di Corio Giarelli Valera, anch’esse frutto delle suggestioni positivistiche, descrivevano i quartieri miserevoli della «Milano in ombra», rivelando i tratti di quella questione sociale che gli organizzatori dell’Esposizione credevano componibile entro la rete municipale dei circuiti assistenziali.
A rafforzare l’esigenza di una riflessione collettiva sul futuro del paese era il riconoscimento comune del ritardo con cui l’Italia si era inserita, come nazione libera e indipendente, nell’assetto capitalistico europeo. La situazione squilibrata in cui versava la penisola, resa ancor più acuta dall’esito del moto risorgimentale, induceva i ceti colti a confrontarsi da vicino con lo spettacolo inedito della «fiumana del progresso», evocata da Verga nella prefazione ai Malavoglia, edito da Treves in quel 1881. Se la scoperta dei gravi conflitti che lo sviluppo industriale aveva alimentato nelle società più avanzate induceva molti ad assumere posizioni di nostalgia recriminatoria, se non regressiva, in altri la meditazione sulla fine della civiltà d’antico regime alimentava suggestioni più appassionatamente inquiete e conturbanti. L’apertura all’Europa, nella città che per prima l’aveva sollecitata fin dai tempi del «Caffè» di Verri e Beccaria, invitava a non abbandonarsi alla deprecatio temporum, in nome magari degli antichi valori delle comunità organiche, e suggeriva, piuttosto, di cercare percorsi inediti per un progresso equilibrato, a misura ambrosiana. Il programma elaborato dai ceti dirigenti milanesi ipotizzava un’espansione graduale delle strutture produttive, fondata sulla concordia municipale e incardinata a un ordine etico che, senza fratture, si innervava nella tradizione.
In quest’intreccio di motivi risiedono la ricchezza culturale e l’interesse rappresentativo delle opere pubblicate in occasione della Mostra: l’analisi dei numerosi articoli d’impianto economico e tecnico permette di individuare le linee portanti del progetto di sviluppo che le forze imprenditoriali più attive proponevano alla nazione da poco unificata; l’esame delle scelte espressive ed editoriali chiarisce le coordinate storiche del mercato delle lettere e dell’orizzonte d’attesa più all’avanguardia della penisola e, nel contempo, getta luce sulle inclinazioni assunte dai diversi gruppi della cultura umanistica e scientifica davanti alle dinamiche della civiltà urbano-borghese.
In questa prospettiva la collaborazione che si realizza durante l’Esposizione fra la classe dirigente e l’intellettualità cittadina acquista il valore di una testimonianza esemplare: primo terreno d’incontro fu l’organizzazione avanzata di cui si era dotato il mondo giornalistico-editoriale nei decenni postunitari: «le officine della letteratura» e la «repubblica della carta sporca», per usare i termini d’allora, erano un osservatorio privilegiato per indagare l’impatto che lo scenario della modernità aveva su chi si dedicava professionalmente alla scrittura e all’arte. Se il rispetto del motto ambrosiano «cose, non parole» era garanzia di serietà per gli studi analitici, la diffidenza per le teorie e le sintesi di pensiero poneva un freno al coinvolgimento dell’élite umanistica nel processo di ammodernamento culturale del paese. La sfida lanciata dalla capitale morale contro il sapere tradizionale, incline alla contemplazione disinteressata, trova, così, nei volumi dell’81 un importante momento di verifica.
Non c’è dubbio che il capoluogo lombardo possa vantare il merito di aver superato per primo la mentalità erudita, in nome di idee e progetti innovativi. Un ritornello si ripete di articolo in articolo nei libri dell’81: Milano è la capitale morale d’Italia per la solidità e intraprendenza delle strutture editoriali, per la ricchezza del sistema della stampa, per le articolazioni del pubblico di lettori. Nelle pagine di Mediolanum e Milano 1881 emergono in primo piano i «prerequisiti» intellettuali del primato cittadino: il rifiuto di ogni arroccamento difensivo a favore dell’accoglienza ospitale e tollerante, la trama fitta di relazioni e interessi di quella cultura «politecnica» con cui Cattaneo proponeva coraggiosamente di «convertire il mondo moderno in mondo nostro».
Seppur con andamento altalenante, questa tensione ideale permane lungo l’arco parabolico del secolo breve: a testimoniarne la vitalità più che lunghi elenchi di nomi, valgano alcune testimonianze novecentesche, fra loro molto diverse ma tutte ugualmente significative.
Nel 1941, in pieno conflitto bellico, per i tipi di «Corrente», la rivista fondata e diretta dal giovane Ernesto Treccani, esce un annuario La luna nel corso, dedicato alla città. Antonio Banfi vi collabora, firmando un saggio dedicato alla Cultura milanese:
Noi, milanesi di razza abbiamo, e tutti lo sanno, una nostra Milano, una Milano che ha il suo cuore profondo nell’ombra alta tacita del Duomo, e la sua vita vibrante d’opera giù per i corsi radianti, oltre la cerchia del Naviglio, sino alla quiete suburbana dei Corpi Santi che la cinge di rinnovata intimità. Ma noi sappiamo, e ne siamo fieri, che questa nostra Milano, questo mito del nostro ricordo, del nostro affetto, della nostra semplicità, del nostro sogno di pace, continuamente si dissolve, fluisce e s’avviva in una più grande Milano, ch’è patria di chiunque vi giunga, vi lavori, vi soffra e vi gioisca, la Milano che s’estende nelle vie senza volto, sfrecciate di luci e di suoni fino al fragore delle officine nella chiarità azzurra della periferia che tra le alte costruzioni pallide sente ancora le frescura di acque correnti sui prati verdi.
La cultura milanese, che fonde l’eredità della ragione illuministica e del sentimento romantico – «un illuminismo senza ideologismi dogmatici, teoricamente prudente e positivo, lievemente scettico e vigorosamente pratico al tempo stesso, […] e un romanticismo che è senso della realtà viva, semplicità di commozione e d’espressione, entusiasmo ideale e non ideologico» – conserva l’energia propulsiva di un patrimonio forte di valori e idee, sempre in bilico fra rispetto delle tradizioni e ansia di novità.
Vi è così – e noi lo riconosciamo senza incertezze – nella vita milanese un contrasto fra un conservatorismo ingenuo o scettico e uno spirito progressivo e cosmopolita ricco d’ardimento; contrasto che è forse solo necessario equilibrio. […] Suoi caratteri sono piuttosto un realismo semplice e schietto, una positiva chiarezza ed obbiettività intellettuale, aliena dall’esercizio dialettico come dalla fantasia metafisica, un tono d’umorismo scettico, che improvvisamente si risolve in una immediata commossa partecipazione umana: e un andare incontro alla vita senza difese e con slancio, che ha la sua sicurezza e la sua gioia solo nell’opera concreta, nel lavoro collettivo, nella soddisfazione del costruire continuo e progressivo.
Il carattere idiosincratico della milanesità, che rifiuta steccati e recinti di ogni tipo, è ribadito da Guido Piovene che, all’indomani del boom economico, intraprende il suo Viaggio in Italia: Milano è
l’unica città d’Italia in cui non si chiami cultura soltanto quella umanistica. Non vi è la mania delle lauree, e sono cultura a Milano anche le capacità tecniche. Poi ricordare che a Milano la cultura, più che vagante è concentrata in scuole, istituti imprese: per esempio il Corriere della sera e le case editrici. […] non direi che esista a Milano una società artistico-letteraria distinta dalla società in generale. Milano ospita un buon numero di persone dedicate all’arte che hanno trovato in essa lavoro e fama (Viaggio in Italia).
Infine all’inizio del nuovo millennio, quando l’orgoglio cittadino rischia, ed è forse più che un rischio, di impantanarsi nella sbruffoneria ferravilliana del «ghe pensi mì» o nella ricerca regressiva di un’inesistente identità padana, un milanese d’adozione rivendica il senso profondo d’appartenenza. Franco Loi, il grande autore dialettale di Strolegh, si autodefinisce
milanes pusè d’un milanes
anca nassu de mama colornesa
e’n sardegno cressu de genoves
perché non solo Milano «è l’unica, vera città italiana. L’unico posto che mescola il mondo» ma, soprattutto, sono sempre parole del poeta,
È proprio il nesso etnia-città che non ha mai avuto corso a Milano: da sempre la città assume e produce un tipo d’uomo che viene detto milanese anche se è nato in Francia come Henry Beyle, o a Luino come Vittorio Sereni, o a Stradella come Carlo Dossi («Corriere della Sera», 5 gennaio 2003).
O a Voghera come Arbasino, ad Alessandria come Umberto Eco, nella lontana Sicilia come Vittorini e Consolo, nella più vicina Toscana come Bianciardi, Fortini e Del Buono. E così via, nei campi più diversi delle professionalità umanistiche, in cui la cittadinanza non conosce distinzione di nascita o provenienza: Ojetti Buzzati Zavattini Montanelli e Biagi; Gatto Sinisgalli Fortini Solmi Giudici, e poi Persico Pagano e Rogers, Gae Aulenti, Rubino Steiner Max Huber, Lucas e Berengo Gardin: sullo sfondo numi tutelari come Mattioli e Sraffa, Musatti e Paci, Linder e Strehler.
Da questa indicazione prospettica ha preso avvio la ricerca sul mito della capitale morale: ancorata al terreno specifico della storia delle idee, la lettura dei volumi dell’81 ha privilegiato l’analisi delle componenti interne dell’ambrosianità, per mettere in risalto l’organica coerenza e le contraddizioni intrinseche con cui la città ha promosso la propria personale «invenzione della tradizione» (Hobsbawm): ovvero quell’«insieme di pratiche, in genere regolate da norme apertamente o tacitamente accettate, e dotate di una natura rituale o simbolica» che, legittimate da narrazioni, figure e modelli esemplari, radicano il paradigma assiologico del lavoro produttivo non solo nelle articolazioni della società civile e delle istituzioni culturali, ma anche nelle menti e nei cuori di una collettività sempre più ampia e variegata. Un mito a forte valenza ideologica, certo, che le dinamiche della storia mettono ben presto alla prova e spesso travolgono, ma la cui lettura consente di focalizzare gli elementi di forza e i nodi di problematica ambiguità.
Nel secolo e mezzo che ci separa dall’Esposizione del 1881, Milano non solo ha conservato il suo primato culturale, ma lo ha consolidato, in una costante e mai pacifica dialettica fra l’élite intellettuale e la moderna opinione pubblica. Nello stesso lungo arco temporale, la borghesia ambrosiana ha mantenuto non solo una diffidenza tenace verso la sfera dell’agire politico, ma anche una riluttanza palese a concedersi all’ariosità delle grandi narrazioni: alla sfuggente, per non dire mancata, rappresentazione di sé come classe dirigente...