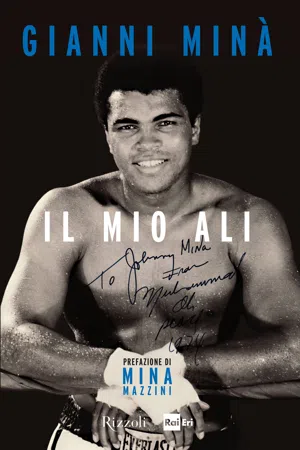![]()
A Manila aspettando Frazier per la terza sfida
E DOPO CHE FARANNO I DUE EROI DELLA BOXE ANNI ’70?
Nelle Filippine finisce un’epoca e anche il secondo matrimonio di Ali. Le nuove strategie dei Black Muslims
Corriere della Sera, 1 ottobre 1975
Che faranno domani Clay e Frazier? Fino a pochi giorni fa la domanda, a detta dei critici, era proponibile solo per Frazier. Di questi due campioni, che hanno illustrato di sé il pugilato degli anni ’60, Smoking Joe sembrava e sembra decisamente il più logoro, il più provato dalle dure battaglie. Ma da qualche giorno alcune contrarietà sono venute a intaccare l’olimpica sicurezza di Ali. Problemi familiari, incomprensioni, leggerezze. Ali, nella parte finale della sua carriera, ha dimenticato una parte del suo puritanesimo, e ora, anche se tutti lo negano, alcuni del suo clan sono preoccupati. Anche se non è più quello di una volta, Ali è inattaccabile se è sereno, ma non lo è più se qualcosa si è rotto dentro di lui. Sono queste le preoccupazioni della parte più responsabile dei suoi compagni e cioè Herbert Muhammad, il suo amministratore, fratello del nuovo leader dei Musulmani Neri, e ancora Angelo Dundee. E lo stesso organizzatore Don King, ex galeotto di San Quintino diventato in un anno il grande “patron” della boxe mondiale e che spera di montare ancora due grandi show, la “bella” con Norton (ormai famosissimo per il film Mandingo) e la rivincita con Foreman, se George si sveglierà dal torpore che lo ha attanagliato dopo il malinconico match di Kinshasa.
Voglia di show
Ma prima che Ali scivolasse sulla buccia di banana di una certa leggerezza nella sua vita pubblica, nella sua continua voglia di show, tutti i critici l’interrogativo sul domani se lo ponevano solamente riguardo a Joe Frazier. Joe era arrivato a Manila con la sua solita aria di cane bastonato non certo in lite con tutto il mondo come Foreman, ma comunque silenzioso, come uno che deve recitare l’ultima scena di una bella storia che però è alla fine. Un giornale filippino aveva addirittura scritto: «Frazier si allena solo all’alba ignorato da tutti come un ladro di notte» e non era una esagerazione. Il buon Frazier, che non ha una psicologia fragile, ma comunque non poteva non risentire della guerra dei nervi scatenatagli contro da Ali, aveva chiesto addirittura a un certo punto al presidente Marcos di poter fare footing alle 4 del mattino, cioè a un’ora in cui in questo Paese, che è libero ma non tanto, vige il coprifuoco. Marcos gli aveva dato il permesso.
Però, per la fantasia dei giornalisti, questo allenamento mattutino per Joe era diventato una specie di fuga dall’atmosfera di freddezza, di noncuranza, che Ali aveva creato intorno a lui. Una strategia ben studiata, considerando anche che i filippini da sempre sono dei grandi appassionati di boxe.
Mentre Frazier infatti stava chiuso nel suo albergo a giocare a blackjack con alcuni amici e a “pelare pompelmi”, come scrivevano ironici anche i giornali americani, Ali andava per le strade ad accarezzare bambini, a firmare autografi, a svolgere la sua solita parte di public relations di se stesso. Ai filippini questo piaceva. È una parte che da anni recita anche il vecchio campione Gabriel Flash Elorde, il più grande pugile di questo Paese che, a quanto affermano a Manila, la mattina accompagna sempre la moglie a far la spesa con i guantoni sulla spalla, pronto a infilarseli per divertire o per far sentire contento qualunque filippino voglia fargli vedere come è impostato pugilisticamente e quanto ama la boxe. Una specie di maestro pubblico o, se volete, di accondiscendente stimolatore delle speranze di tutti, una specie di transfert itinerante per le strade della città. Ali si era mosso con la stessa condiscendenza, con la stessa simpatia. E per tutti, filippini e non, il “che cosa farà domani?” era riservato solo a Frazier. Ma adesso è cambiato e l’interrogativo incomincia a riguardare tutti e due.
Joe si dedicherà alla palestra che con alcuni soci possiede a Filadelfia, e molto probabilmente anche alla musica. Il jazz, nelle sue espressioni più moderne, è stato sempre il suo secondo amore. Non si sa se Frazier continuerà a cantare, forse non ha doti sensazionali in questo senso, ma potrebbe muoversi nel mondo della discografia americana come produttore, come scopritore di talenti, come intrattenitore. Sa essere divertente, il buon Joe, ed è anche un discreto parlatore; la sua sfortuna è che sulla sua strada un giorno è capitato Muhammad Ali, che però sembrava essersi autoeliminato. Da quel giorno per Frazier non c’è stato più palcoscenico, anche se nella famosa sfida del ’71 seppe vincere.
Più ricco, più esaltante, più smisurato, il futuro che aspetta invece Ali. Niente può intaccare l’incredibile costruzione pubblicitaria che questo personaggio ha saputo mettere alle sue spalle. Intanto è sorprendente come, unendosi a un personaggio colorato, pieno di contraddizioni come l’organizzatore Don King, sia riuscito a rompere le vecchie tradizioni della boxe. Don King ha affrancato Ali dai padroni del pugilato bianco americano, dai grandi magnati del Madison, e Ali adesso dice:
«Il Garden muore, perché io me ne sono andato. Ma l’America non poteva più contenere il mio mito!».
Muhammad esagera, e lo sa, ma si diverte un mondo. È vero però che in uno sport che muore, come il pugilato, un personaggio come Ali non poteva essere proprietà privata di un mondo che alla boxe aveva dato momenti di grande luce, ma anche la malinconia dello sfruttamento della personalità umana, la tristezza di aver trattato troppi eroi del ring come oggetti.
È la constatazione di questa realtà che probabilmente ha spinto Ali sempre più verso l’incrollabile fede del suo movimento religioso e che lo ha convinto, appena possibile, a lasciare i vecchi padroni per affidare se stesso a questi fratelli neri che gli offrivano l’enorme felicità di ritrovare in Allah una identità umana e culturale.
Il problema che potrebbe incontrare nel futuro, una volta fuori dal ring, è però quello di capire filosoficamente, politicamente, quali sono le esigenze di un movimento di cui egli ha finora abbracciato il più immediato messaggio religioso, ma di cui forse non ha ancora capito tutte le sottigliezze sociologiche. Poche sere fa, per esempio, Don King, anch’egli musulmano nero, ma certamente più sfrontato di Ali in certe sue esibizioni esteriori, ha offerto una festa per quattrocento persone. C’erano ermellini, oro e belle donne anche piuttosto scollacciate. La sorpresa per tutti era la presenza alla festa di Herbert Muhammad, il manager di Ali e fratello del nuovo supremo ministro dei Musulmani Neri. Il manager musulmano di Ali, malgrado le rigide regole morali della sua religione, non è apparso sconcertato da questa festa mondana. Esperti dei movimenti ideologici religiosi di un Paese pieno di contraddizioni come l’America sostengono che Wallace Muhammad, il nuovo capo del gruppo in cui si muove Ali, vorrebbe cambiare l’immagine chiusa, diffidente, cocciutamente puritana del movimento.
Elijah Muhammad, il padre di Wallace, una quindicina di anni fa aveva imposto all’attenzione dell’America la sua filosofia, fondandola su una frase: “I bianchi sono diavoli…”; ma in questi anni, anche per il grande contributo offerto dalla popolarità di Clay-Ali, il movimento è diventato una realtà non trascurabile nella società americana. Ora i militanti sono oltre tre milioni e il sistema, il governo, è dovuto venire a patti con questo gruppo che ha ormai la più numerosa rappresentanza fra i neri d’America. Il dover trattare con il sistema ha fatto evidentemente capire ai leader dei Musulmani Neri che bisognava aprirsi a certe realtà, anche perché il movimento poteva diventare “ricco” soltanto commerciando, solo stabilendo rapporti di affari e diplomatici con i Paesi del Terzo Mondo o, meglio ancora, con i Paesi di fede musulmana, magari con Ali nella parte di intermediario e ambasciatore.
Mondo borghese
E si sa che, quando diventano importanti diplomazia ed economia, possono diventare necessari anche mondanità e belle donne, almeno in un mondo borghese. Forse in questa nuova strategia esteriore dei Musulmani Neri sta la spiegazione della diversa immagine pubblica che Muhammad Ali ha offerto ultimamente di sé. Forse il fatto di apparire più frivolo, più aperto, meno misterioso è voluto da coloro che lo affiancano e lo dirigono nella sua vita. Insomma potrebbe essere una spiegazione. Anche se il nervosismo di Ali non sembra avvalorarla del tutto. Ma il campione di Louisville, sotto quella sua patina di sicurezza, è un inguaribile ingenuo. E senza dubbio non avrebbe litigato con sua moglie Belinda, e lei non se ne sarebbe andata appena dodici ore dopo essere arrivata a Manila, se l’atteggiamento fosse stato la scelta di una nuova strategia esteriore del gruppo di cui Ali è una bandiera. Non bisogna però pensare che quest’uomo al centro dello sport, della società moderna, combatta le sue battaglie come un burattino tenuto per i fili. E questa è la realtà che ci fa capire come in futuro Ali, nel movimento dei Musulmani Neri, non sarà un gregario, ma un personaggio di rispetto. Proprio i più importanti giornali americani, presentando questa ultima sfida con Frazier, hanno sottolineato come sia completamente sbagliato pensare a un uomo condizionato da interessi superiori. Ha dato molto al suo movimento ma è ricchissimo; ha fatto delle scelte precise nella sua vita, ma non ne è mai rimasto travolto. Anche nella sua attività di pugile è incredibile come sappia imporre sempre, il luogo, il tempo e lo stato d’animo che più gli si confanno.
Muhammad Ali, anche se ha dovuto venire a patti col sistema, anche se ha dovuto attenuare la sua vecchia rabbia di nemico del sistema, è uno che non se n’è andato dal suo Paese, come ha fatto la maggior parte dei leader “arrabbiati” degli anni ’60, né si è fatto schiacciare. È rimasto e lavora per la sua gente: ospedali, case di riposo, catene di negozi, per non dipendere più completamente dal sistema bianco americano. E molto di più si impegnerà domani.
Muhammad Ali vs Joe Frazier
(Manila, Filippine, Araneta Coliseum, 1/10/1975)
W KO 14
![]()
Una boxe stanca, ma agonisticamente senza eguali
UN TALENTO PIÙ FORTE DELL’USURA DEL TEMPO
Nell’ultimo round, a Manila, Smoking Joe non ha trovato la forza di rialzarsi dallo sgabello. Clay vince ancora, ma afferma: «È stato quanto di più vicino alla morte io abbia provato».
Joe Frazier, comunque, è apparso meno logoro di quanto si pensasse
Corriere dello Sport, 2 ottobre 1975
Per chi ha visto il match in diretta Tv (grazie all’emittente svizzera italiana) Muhammad Ali-Cassius Clay aveva, senza discussione, almeno due punti di vantaggio nel momento in cui Frazier non ha trovato la forza di alzarsi dallo sgabello per il quindicesimo round. Uguale il parere per la maggior parte dei critici a bordo ring, ma c’è anche un gruppo di giornalisti che è di opinione contraria; era Frazier che stava vincendo il match, e questo malgrado il tredicesimo e quattordicesimo round che erano stati drammatici per lui, apparso a momenti anche sull’orlo del ko. Secondo noi, a parte i diversi canoni, le diverse convinzioni che contraddistinguono la difficile valutazione di un match di boxe, la sorprendente disparità di giudizio fra i critici ugualmente qualificati è dovuta alla violenza dello scontro, o meglio ancora all’incredibile tensione drammatica che si era stabilita sul ring fin dal primo scambio di colpi fra Ali e Frazier. Anche se i due grandi campioni sono apparsi un ricordo non lontanissimo, ma sempre un ricordo di quello che erano una volta, lo spettacolo pugilistico da essi offerto, almeno sul piano agonistico, è stato eccezionale, difficilmente ripetibile ai nostri giorni su qualunque altro ring del mondo, anche con campioni più giovani.
Ali, che all’inizio provava a essere l’istrione di sempre, ma senza convinzione, come se recitasse un copione a cui non credeva poi completamente, non danzava più, non tentava nemmeno di far rivivere esaltanti ma irripetibili immagini di ieri, metteva invece il suo ben noto talento pugilistico al servizio di quello che il suo fisico, sollecitato da troppi impegni, da una frenetica e snervante vita pubblica, e ora anche da alcune complicazioni con la moglie Belinda, poteva permettergli in quel momento. Quindi, passetti laterali o indietro e quel fastidioso sinistro come un pungiglione sulla fronte di “carro armato” Joe Frazier che cercava cocciuto di venire avanti. Poi, come lampi di un temporale d’estate, i suoi stupendi uno e due, belli come non se ne vedono più sui ring della boxe moderna. Così vinceva tranquillamente le prime due riprese.
Ma la freschezza atletica, la possibilità di boxare come un peso medio e non come un peso massimo, non sono più una ricchezza su cui Ali può contare sempre. Sono passati quindici anni da quando il più grande pugile degli anni ’60 comparve sulla scena mondiale; della sua generazione è rimasto “vivo” (e neanche tanto…) solamente Mantequilla Nápoles, mercenario cubano-messicano senza età e senza avversari seri fra i pesi welter. In più la vita di Ali in questi quindici anni non è stata certo né sempre facile né sempre serena, così ora, se non combatte contro i mezzi campioni come Bugner, o contro forzuti coraggiosi solo con il coltello in mano, come Lyle, Ali, dopo due o tre round di impegno, deve tirare il fiato. Oltretutto ieri notte l’arbitro filippino, tutto compreso nella sua parte di maestrino, non gli permetteva di aiutarsi con mestiere, cioè con le trattenute o con certe “trovate” che gli hanno sempre permesso di rompere il ritmo agonistico troppo pressante, violento, proposto da avversari meno classici, ma più determinati come appunto Joe Frazier.
Nel terzo round, quindi, Ali si chiudeva a riccio alle corde tentando quella tattica del rope-a-dope (presa al laccio di un imbecille) che gli era riuscita stupendamente nel ’74, a Kinshasa, contro il forzuto ma moralmente fragile Foreman, e che non trovava però risultati contro Frazier, sia perché Joe non si faceva impressionare troppo dalle sue provocazioni («picchiami, gorilla» gli urlava Ali da dietro i guantoni) sia perché Joe è abilissimo, finché non è intaccata la sua integrità fisica, a passare sotto i colpi di sbarramento di un avversario più tecnico e a imporre, subito dopo, tremende serie ai fianchi e al fegato.
Inoltre appariva chiaro che il lungo riposo (appena due match piuttosto facili con vecchie cariatidi come Ellis e Quarry in quasi due anni) aveva giovato e non impigrito il cocciuto Frazier che sapeva arricchire il suo “lavoro” ai fianchi con sventole improvvise al viso che The Greatest neutralizzava in parte solo per la sua abilità nell’accompagnare i colpi. Così, dopo due round pari (il quarto e il quinto) Frazier, malgrado le provocazioni dell’avversario che come sempre dirigeva il coro della folla a lui favorevole, imponeva a metà match la sua tremenda macchina da pugni, la sua abitudine alla sofferenza, alla trance agonistica che gli permetteva di sopportare stoicamente i pigri diretti dello smarrito Ali di questi round, pur di imporre nello stesso tempo le sue serie a corta distanza.
Ali accusava un brutto destro nel quinto round, poi un paio di sinistri nel sesto, si difendeva col mestiere, ma più che altro si chiudeva passivo negli angoli in un atteggiamento psicologico sconosciuto per lui. Era quasi un’esasperazione della tattica usata contro Foreman, ma era anche la fotografia di una condizione psicologica e fisica carente, che noi avevamo intuito alla vigilia nei colloqui telefonici col suo “clan” e avevamo in parte previsto quando, ad aprile, lo avevamo seguito per tre settimane documentando in Tv il suo frenetico modo di vivere, di servire la causa del suo movimento religioso-politico e di essere personaggio nella società americana.
Non si possono seguire tutti questi interessi, queste iniziative e fare anche il pugile. Tanto meno se, a causa delle vicende della vita, hai riconquistato tardi, dal punto di vista sportivo, quello che ti apparteneva e ora ti trovi a bruciare le tappe dello sfruttamento del tuo successo (quattro difese del titolo in un anno). Per ironia della sorte Frazier, così come era successo nel ’71 (quando Muhammad, dopo tre anni di inattività, era stato costretto a stringere i tempi del suo ritorno sul ring) si trovava ancora una volta nella condizione di poter approfittare di una preparazione fisica e psicologica affrettata del suo avversario, e chiaramente non si lasciava sfuggire l’occasione. Dalla settima all’undicesima ripresa si sviluppavano così come in un film thrilling (d’altronde “Thrilla in Manila” era lo slogan del match…) una serie di colpi di scena, con round vinti alternativamente dai due contendenti e Frazier, che magari all’ottavo round sembrava sull’orlo dell’abisso per un tremendo destro, che si riprendeva e metteva subito dopo Ali nella situazione di soffrire passivo sulle corde. E ancora il campione di Louisville, che nel decimo round sparava i suoi bei colpi danzando, ma appariva pesante come non mai, quasi senza energia in quelle braccia che pure si muovevano ancora con fantasia, velocità e tecnica. Crediamo sia la valutazione molto sottile e complicata di queste cinque riprese, difficilmente attribuibili con sicurezza all’uno o all’altro contendente, a dividere la grande massa di critici favorevole ad Ali, dal gruppo che invece sosteneva la malasorte di Frazier per non aver potuto proseguire dopo la quattordicesima ...