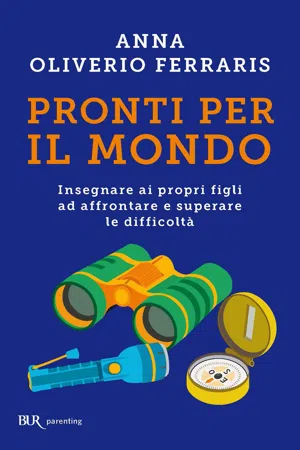![]()
1
ESPERIENZE ESTREME
La resilienza è la proprietà che hanno
i metalli di tornare alla loro forma iniziale.
C’è chi crolla di fronte a difficoltà di lieve entità e chi invece riesce a resistere a esperienze che per altri possono essere molto dissestanti. Ognuno di noi ha avuto modo di conoscere persone dell’uno e dell’altro tipo o di sentire citare i casi di persone deboli e di persone resistenti, di individui che tendono ad arrendersi subito e di altri che invece continuano a combattere fino allo stremo delle forze, senza mai perdere la speranza di potercela fare, prima o poi.
Quale sia la natura della forza che manca ad alcuni e che invece altri riescono a trovare nei momenti di crisi emergerà man mano che ci addentreremo in questo argomento affascinante, complesso e dai molteplici risvolti. Come in un caleidoscopio, vedremo infatti che la resilienza – la protagonista di questo saggio – compone e ricompone continuamente i propri tratti costitutivi a seconda delle circostanze, delle caratteristiche individuali, delle memorie delle passate esperienze, dell’appoggio o meno di presenze significative nel proprio ambiente di vita: cosicché, sebbene i suoi ingredienti siano individuabili e in numero limitato, non esiste un’unica ricetta perché essi non sono sempre gli stessi nelle diverse situazioni e possono, ricomponendosi, far sì che vengano messe in campo strategie individuali, ci si adatti, si resista e reagisca in modo del tutto personale.
Iniziamo dunque questo viaggio nel vasto e multiforme territorio della resilienza partendo da alcune storie individuali.
Gli ostaggi libanesi
Quando, nell’agosto del 1991, l’ostaggio Edward Tracy emerse da cinque anni di dura prigionia in Libano, era visibilmente provato. Sebbene si dichiarasse “in perfetta salute”, era sfinito e disorientato. Disse di avere sessantatré anni, mentre in realtà ne aveva sessanta. Parlò delle sue “mogli” come se fossero morte, sebbene la sua unica ex moglie fosse ancora viva. Date le sue condizioni, Tracy fu ricoverato per una settimana nel reparto di psichiatria dell’ospedale in cui era in osservazione.
Al contrario, John McCarthy – anche lui prigioniero per cinque anni in Libano nelle stesse condizioni di Tracy – quando uscì dalla galera aveva l’aspetto di uno che torna da un viaggio di piacere. Il trentaquattrenne McCarthy rispose alle domande dei giornalisti con gentilezza e senso dell’umorismo e fin dalle prime ore si comportò normalmente: acquistò un’automobile, rilasciò interviste, partecipò persino a una simulazione di volo.
Quali sono le ragioni di una così marcata differenza di condizioni tra i due ostaggi?
Il modo in cui gli ostaggi riescono a fronteggiare la prigionia dipende in parte dal tempo che essi hanno trascorso in cattività e dalle condizioni in cui sono stati tenuti. Quanto più brutali sono state le condizioni tanto più è facile che il corpo e la mente ne siano segnati. Edward Tracy e John McCarthy soffrirono lo stesso tipo di deprivazioni ed entrambi furono picchiati e minacciati di morte. Furono anche, a varie riprese e per tempi lunghi, tenuti in catene e bendati.
Sopravvivere in queste condizioni dipende anche dalle risorse fisiche e mentali con cui gli ostaggi arrivano alla prova. La giovinezza è un vantaggio perché, solitamente, garantisce una maggiore resistenza fisica. Inoltre porta con sé la percezione di poter recuperare il tempo perduto negli anni a venire. Ma rilevanti sono anche i tratti emotivi e intellettuali del prigioniero e le sue passate esperienze di vita, che costituiscono presupposti importanti per creare spazi mentali più o meno improntati alla speranza, alla fiducia in se stessi, negli altri o nelle possibilità di un cambiamento.
Gli ostaggi più resistenti hanno in genere un senso dell’identità molto radicato, hanno fiducia nelle proprie capacità e, pur non essendo tanto ingenui da fidarsi di chiunque, sono fondamentalmente ottimisti. Tendono anche ad avere convinzioni piuttosto chiare, siano esse politiche, religiose o di altro tipo. Fattori protettivi sono anche i legami stabili con i familiari o gli amici, che forniscono al prigioniero una ragione di vita e gli fanno sperare di non venire dimenticato, che qualcuno si stia dando da fare per tirarlo fuori.
Coloro che resistono meglio sono anche capaci, il più delle volte, di creare nuovi legami con altri ostaggi e di sacrificarsi per il bene comune. Possono diventare un punto di riferimento per gli altri. Dalle testimonianze di molti prigionieri emerge che la cosa migliore che si può fare in cattività è dividere con i propri compagni di sventura fino all’ultimo boccone di cibo. Non è soltanto una questione di generosità e altruismo ma anche una strada per non ripiegarsi su se stessi e pensare continuamente alla propria condizione.
Una vivida immaginazione, poi, può essere di aiuto. In molti casi è servita ai prigionieri per fronteggiare il tedio della segregazione e riacquistare una qualche forma di controllo sulla propria esistenza. Se non possono svolgere altre attività come la lettura, la conversazione ecc., alcuni si inventano passatempi, un nuovo linguaggio, ripercorrono mentalmente tutte le tappe di un viaggio ideale, oppure riservano un particolare momento della giornata alle fantasie e ai ricordi piacevoli. Di due uomini che furono tenuti sequestrati in isolamento da un gruppo di terroristi per alcune settimane, il primo, che uscì in buone condizioni, aveva passato buona parte del tempo a inventarsi menù esotici; il secondo, che non aveva trovato rifugio nella fantasia né in altre forme di passatempo, ma aveva continuato a riflettere sulla sua situazione, uscì dalla prigionia in condizioni psicofisiche decisamente precarie.
I fattori che influiscono sulla capacità di adattarsi alla prigionia sono anche quelli che influiscono sulla capacità di riadattarsi alla libertà.
Il rientro nel mondo, infatti, può essere uno shock forte, quasi quanto quello che si subisce nell’uscirne, specialmente se il passaggio avviene sotto i riflettori dei media. In un tempo molto breve l’ostaggio passa dalla solitudine all’invadenza delle telecamere, dal non avere nessuna possibilità di scelta all’averne troppe, dall’essere deprivato dei normali stimoli all’esserne bombardato. “Sono stupito e confuso”, disse Edward Tracy, “nel rivedere un albero e nel riudire il rombo di un aeroplano.”
I sequestrati hanno spesso bisogno di trascorrere del tempo da soli, sia perché non sono abituati a essere al centro dell’attenzione sia perché devono rimettere ordine nelle proprie emozioni, percezioni e sensazioni. Spesso, dominati dalla tensione, hanno difficoltà a stare seduti per più di qualche minuto, ad ascoltare un lungo discorso, a portare a termine un’attività. E ci sono casi in cui devono anche fronteggiare notizie negative. La madre di McCarthy, per esempio, era morta durante la prigionia del figlio, due anni prima.
Lui però ebbe l’energia necessaria per fronteggiare la situazione. I fratelli, il padre e i colleghi lo descrissero come un giovane allegro, affezionato ai familiari e agli amici. “È nato ottimista, un lottatore, con un forte gusto della vita” disse di lui il padre. “È l’uomo più pazzo che ho mai conosciuto ed è anche un mimo divertente: senza di lui non so se ce l’avrei fatta” fu il commento di un suo compagno di prigionia rilasciato alcuni mesi prima. Edward Tracy, invece, aveva condotto un’esistenza caotica passando attraverso dieci nazioni diverse prima di stabilirsi in Libano e facendo ogni tipo di attività, dal poeta al venditore di libri. Da molto tempo Tracy non aveva legami affettivi. Le sue condizioni mentali prima della prigionia non sono chiare: i medici rivelarono che era stato in cura per problemi psicologici. Era però migliorato e inoltre aveva mantenuto un robusto senso dell’umorismo (come emerge da un resoconto del Time).
Ogni sequestrato ha una sua storia, sia durante il periodo di cattività sia, soprattutto, prima. Una storia che lo rende per qualche aspetto unico e diverso dagli altri. Le storie, però, variano con il variare dell’intreccio di alcuni fattori sostanziali: la durata della prigionia, lo stato di isolamento del prigioniero, il trattamento ricevuto, l’età, lo stato di salute, le risorse psichiche. Queste ultime sono in relazione con le passate esperienze, il senso di identità, la fiducia in se stessi, la dimensione ottimismo /pessimismo, il mondo dei legami affettivi da cui si proviene e cui si spera di tornare, la capacità di solidarizzare e di stringere nuovi legami durante la segregazione, il possesso di forti convinzioni e valori, l’abilità nel realizzare “fughe” negli spazi della fantasia, nell’impiegare il proprio tempo in passatempi o altre attività che assorbono la mente, nel mantenere viva la speranza senza perdere, per quanto è possibile e se lo si possiede, il senso dell’umorismo, oppure appoggiandosi a chi lo possiede.
Nel descrivere la propria esperienza nel campo di sterminio nazista di Buchenwald, lo psichiatra Viktor Frankl affermò che i fattori che più contribuirono alla sua sopravvivenza in quelle condizioni di estremo stress furono: darsi dei compiti o porsi degli obiettivi; mantenere la capacità di fare progetti; l’indipendenza e l’abilità di analizzare obiettivamente ciò che si verificava in una situazione complessa; riuscire a tenere sotto controllo i propri impulsi a lamentarsi e a ribellarsi o a esprimere rabbia, ossia non cadere preda della disperazione e/o esporsi a rappresaglie; usare l’immaginazione per distrarsi e confortarsi. Ecco, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, un esempio di come i giochi mentali e la fantasia lo aiutarono a sopravvivere alla monotonia e alle crudeltà della vita del campo.
Obbligai i miei pensieri a cambiare argomento. Improvvisamente mi vidi sulla pedana di una calda, illuminata e gradevole sala per conferenze. Di fronte a me sedeva un pubblico attento. Io stavo tenendo una lezione di psicologia sul campo di concentramento! Tutto quello che mi opprimeva in quel momento divenne obiettivo, visto e descritto dall’ottica distaccata della scienza. Con questo metodo riuscii a controllare la situazione, a ergermi sopra le sofferenze del momento e a guardare a esse come se appartenessero già al passato. Io e i miei problemi diventammo oggetto di un interessante studio psicoscientifico intrapreso da me stesso (Frankl, 1962).
Insomma, quello che ci dice lo psichiatra Viktor Frankl in questo brano è che un fattore protettivo, in condizioni di segregazione dove la propria e l’altrui incolumità sono fortemente minacciate, è la capacità di frapporre una distanza tra la propria mente e gli eventi reali che potrebbero dissestarla.
Come avremo modo di vedere anche in seguito, ciò che in condizioni normali indica un disagio o una patologia vera e propria, ossia una scissione tra il proprio Sé e la realtà esterna tanto da non riuscire più a connetterli in una relazione dotata di senso, in condizioni di forte difficoltà e per brevi periodi può invece assumere i tratti di una strategia salvifica perché, in casi del genere, patologico non è l’individuo, che si costruisce un mondo a parte, ma il mondo esterno. D’altro canto questo meccanismo di difesa entra in azione fin dai primi anni di vita, non appena, da bambini, cominciamo a far uso dell’immaginazione e diventiamo capaci di fingere, nei giochi, situazioni diverse da quella reale. Valga, a titolo d’esempio, il caso di Simone, un bambino che, a quattro anni non ancora compiuti, ha già trovato una sua strategia, molto personale, per fronteggiare una situazione familiare insostenibile.
Il bambino canguro
Simone è un bambino intelligente, con notevole proprietà di linguaggio, ma instabile, quasi iperattivo. Non riesce a fissare l’attenzione né a stare fermo più di qualche secondo e spesso dà l’impressione di non sentire ciò che gli si dice. Da qualche tempo, poi, vuole essere chiamato Jumpy (il nome del canguro di uno spot) per due motivi: perché ciò gli consente di tirare calci e perché i canguri si portano dietro la casa: “La casa ce l’hanno nella pancia” spiega. “I canguri hanno una grossa tasca con i cangurini così nessuno li lascia mai soli!”
Da quando è nato, Simone, unico figlio di una coppia in difficoltà, è al centro di tensioni molto forti. I suoi genitori si stanno separando, ma non riescono a farlo in maniera civile e usano lui come arma di ricatto, per ferirsi, vendicarsi, ottenere dal giudice l’affidamento. Identificandosi in un canguro, Simone da un lato dà sfogo alla tensione che accumula quotidianamente e dall’altro ricrea nella fantasia un ambiente protettivo; questo animale, infatti, con il suo marsupio e i cangurini portati a spasso nel calore del proprio ventre, rappresenta una proiezione rassicurante.
Tendiamo a sottovalutare i bambini, ma anche Simone, come tutti, ha l’esigenza di dare senso alle proprie esperienze, ai comportamenti propri e altrui e di mettervi ordine. Il clima familiare è caotico. Minaccioso. Lui viene spostato da una casa all’altra all’improvviso, senza una ragione, tra malumori e toni alterati. Ha bisogno di coerenza, di serenità, di dare un significato a ciò che sta accadendo intorno a sé. Le ragioni degli adulti gli sfuggono. La sua comprensione del mondo segue altre direzioni. Seppur piccolo, cerca di operare una sintesi tra pezzi diversi di esperienze, alcune prese dal suo mondo, altre da quello degli spot. Identificandosi con Jumpy riesce a raccontarsi una storia che lo tranquillizza. Naturalmente non è questa la soluzione ottimale e non potrà durare per sempre. È una soluzione, però, che serve a ridurre il suo stato di tensione interna in attesa che le cose cambino, che qualcuno presti finalmente attenzione anche alle sue esigenze.
Insomma, la mente umana ha le sue regole, cosicché la strategia messa in atto dallo psichiatra Viktor Frankl non è sostanzialmente diversa da quella del piccolo Jumpy.
Scheda 1
Resistere alla prigionia
• Durata
• Trattamento subìto
• Stato di salute
• Risorse psichiche:
– esperienze passate
– senso di identità forte
– fiducia nelle proprie possibilità di resistere
– ottimismo (contrario del senso di sfiducia o helplessness)
– solidi legami affettivi
– capacità di stringere nuove amicizie
– forti convinzioni (morali, ideologiche, religiose ecc.), valori, ideali
– fantasie positive
Attraversare la guerra
La guerra in Libano iniziò nel 1975 e finì nel 1991, l’anno in cui Edward Tracy e John McCarthy furono rimessi in libertà. Durante questi sedici anni la popolazione libanese fu costretta a confrontarsi con gravissime minacce quotidiane. I bombardamenti prendevano di mira soprattutto i quartieri residenziali, le scuole, gli ospedali e gli altri edifici istituzionali. Periodi di relativa calma, in cui le attività potevano svolgersi normalmente, erano interrotti, senza alcuna forma di preavviso, da azioni terroristiche o militari: esplosioni, bombardamenti… In un clima del genere, la vita attiva non poteva né interrompersi né seguire un corso normale. L’imprevedibilità degli eventi creava un clima di incertezza e rendeva difficile immaginare un futuro.
Nonostante le gravi e ricorrenti difficoltà oggettive, la maggior parte dei bambini non uscì segnata in modo irreversibile da quella esperienza. Secondo i risultati di uno studio condotto da Charles Baddoura (1998), uno psichiatra che operava in Libano, sul 72% dei bambini che negli ultimi due anni di guerra avevano otto e nove anni e che erano stati esposti al clima bellico fin dalla nascita, quel lungo e dissestante conflitto non lasciò strascichi tali da interferire con il loro sviluppo e con un normale funzionamento psicofisico.
Eppure i traumi di guerra possono lasciare ferite morali profonde sia sui soldati sia tra i civili. Nel corso della Prima guerra mondiale, le patologie psicologiche o psichiatriche descritte con maggiore frequenza furono gli stati confusionali e l’isteria. Nel corso della Seconda furono invece i disturbi psicosomatici (che sostituirono le isterie soprattutto tra le persone di livello socio-economico elevato), gli stati psicotici acuti o “schizofrenia dei tre giorni” (caratterizzati da accessi deliranti – in concomitanza con eventi tragici – che però regrediscono rapidamente), le nevrosi traumatiche (inibizione dell’attività, comportamenti regressivi, scariche emotive con aggressività intensa o pianti, ossessioni e incubi).
Quest’ultima sindrome è nota anche come stress postraumatico (Post Traumatic Stress Disorder o PTSD): una reazione ansiosa che si verifica a seguito dell’esposizione a un evento al di fuori del comune, capace di indurre un disagio emotivo nella maggior parte delle persone. Lo sviluppo di questa sindrome (che implica una predisposizione dell’individuo ma che è ampiamente diffusa) è caratterizzato da tre tipi di sintomi:
– flash-back o reviviscenza dell’evento traumatico sotto forma di incubi a ripetizione;
– affievolimento dei sentimenti e rimozione di tutto ciò che è legato all’evento traumatico come l’incapacità di ricordarsi di aspetti importanti del trauma;
– segni di iperattività neurovegetativa (pallore, sudore, tachicardia…).
Per quanto riguarda i bambini, essi possono rivivere gli eventi traumatici nel gioco o in altre attività espressive. Possono, durante il sonno, essere assaliti da sogni angoscianti privi, spesso, di un contenuto preciso. Altri sintomi possibili sono comportamenti ripetitivi o disadattati, agitazione, paure intense, cambiamenti drastici nel rapporto con gli altri, con le normali attività quotidiane e con il futuro.
Anche nel corso dei conflitti più recenti, successivi alla Seconda guerra mondiale, si è evidenziata l’insorgenza di molte patologie. In Libano in particolare, data l’eterogeneità della popolazione – un vero mosaico socio-culturale –, durante i sedici anni di guerra emerse ogni tipo di patologia psichica, dalle sindromi notate nel corso della Seconda guerra mondiale a quelle descritte nella Prima. In più, sia tra i soldati sia tra i civili, si è registrato un aumento sensibile dell’alcolismo e della tossicodipendenza.
Ma se la guerra è per sua natura portatrice di gravi dissesti, come si spiega la tenuta psicologica di un così elevato numero di bambini libanesi? I fattori che possono dar ragione di questa forma di resistenza infantile nelle zone di guerra sono svariati. Un primo aspetto da tenere presente è che le reazioni dei bambini di fronte ai traumi della guerra sono strettamente legate alle reazioni delle persone che vivono accanto a loro, ossia alla tenuta degli adulti. Questi possono agire come filtro, trattenendo ansie e paure, oppure trasmetterle. L’attitudine dei grandi, in particolare dei genitori, modula quella dei bambini e costituisce, nella genesi del disagio infantile, un fattore di gran lunga più importante dell’evento traumatico in sé. Angoscia e tensione, conflittualità dei genitori, separazione dall’ambiente familiare, sono in genere per i bambini elementi più perturbanti degli stessi bombardamenti.
Bis...