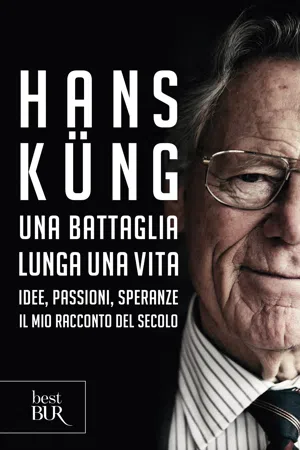![]()
1
Radici della mia libertà
«Non si può pretendere che, per diventare cittadini del mondo, rinunciamo ai nostri legami originari.»
Manifesto ONU per il dialogo tra le culture, 2001
Libertà minacciata
La mia infanzia coincide con l’ascesa al potere di Adolf Hitler e con la minaccia alla nostra libertà nazionale e personale. È questa minaccia a forgiare, più di ogni altra cosa, i miei primi anni di vita.
Nella nostra famiglia, nella cittadina svizzera di Sursee, se ne parla costantemente. Non diversamente da quel che avviene in moltissime altre famiglie svizzere, si discute sempre apertamente, liberamente e spesso appassionatamente di tutto ciò che avviene nella nostra patria, in anni che diventeranno sempre più drammatici a livello di politica locale, cantonale, nazionale e internazionale. Da noi ciascuno si sente un «politico» e, per via della democrazia diretta, dispone, se è un uomo, di molteplici possibilità per impegnarsi attivamente.
Né mio padre («papà»), né mia madre («mammina») sono grandi lettori di libri, in compenso sono avidi lettori di giornali e riviste. E come a mezzogiorno e alla sera si recita insieme una preghiera, così, regolarmente, a mezzogiorno e alla sera si ascoltano le notizie di Beromünster, l’emittente regionale della Svizzera tedesca. I suoi trasmettitori si trovano a circa 5 chilometri di distanza dalla cittadina del cantone di Lucerna in cui sono nato, per così dire nel cuore della Svizzera. Durante la guerra, Radio Beromünster, in quanto voce di un Paese libero, riporta costantemente informazioni sia di parte tedesca sia di parte alleata. Il venerdì c’è il commento pacato e oggettivo della «Cronaca internazionale» curata dallo storico J.R. von Salis, per noi un’autorità intellettuale e una figura di riferimento. Pertanto, «Beromünster», benché presto vietata in Germania, come la BBC, viene ascoltata in segreto anche da molti tedeschi. E sono ora determinati eventi politici scioccanti dei miei primi anni di vita a farmi sentire, leggere e agire in un modo nuovo – se si vuole, più «politico».
Date choc
25 luglio 1934. In questo giorno viene trasmesso un annuncio radiofonico che è il primo a scolpirsi profondamente nella mia memoria: l’uccisione del primo ministro austriaco, nonché ministro degli Esteri, Engelbert Dollfuss – vittima di un putsch nazionalsocialista! Io ho 6 anni.
I tempi, nel marzo 1938, si sono fatti talmente drammatici che io, giorno dopo giorno, divento avido lettore del giornale, l’«organo centrale dei cattolici conservatori», pubblicato a Lucerna e recante il nome patriottico di «Vaterland» (Patria). Tutto ciò, in verità, anche a motivo del romanzo d’amore (il primo che ho letto) che si muove intorno alla battaglia di Sempach del 1386 e il cui seguito divoro con lo stesso fervore con cui leggo i resoconti sugli eventi di politica internazionale. Questi offuscano sempre più l’orizzonte politico dell’Europa. E ciò, non da ultimo, a causa dell’incomprensibile immobilismo e delle vacue note di protesta di quelle potenze occidentali con le quali noi, in Svizzera, apertamente simpatizziamo. Una figura caricaturale era per noi, con il suo ombrello, il premier britannico Neville Chamberlain.
Noi svizzeri ci chiediamo: chi verrà in nostro soccorso quando giungerà il nostro turno? Già risuona il verso tedesco: «E la Svizzera, la Svizzera, il porcospino, ce la prendiamo al ritorno!» O forse già all’andata – in direzione Parigi?».
Nel mio tempo libero, sono già impegnato nel movimento giovanile cattolico, di ispirazione patriottica (Jungwacht, «Giovane vedetta»), la cui «legge» prescrive anche di «amare la propria patria» e nel quale, previo esame, vengo presto promosso «capo ausiliario». Qualche tempo dopo divento il più giovane soldato del presidio locale, sono armato e ovviamente deciso a difendere contro ogni attacco la mia cittadina natale e la libertà del nostro Paese. In seguito, per due inverni prendo ancora parte a corsi straordinari da marconista, così che, con mio sollievo, non vengo reclutato nella fanteria, che non mi piace per niente per via del suo addestramento formale, ma tra le truppe del servizio di trasmissione, nel quale non presto servizio dopo la Seconda guerra mondiale a motivo del mio prolungato soggiorno all’estero. In questo modo mi viene certo risparmiata anche quella «frustrazione personale» dovuta alle esperienze militari che nel «diplomato in architettura» Max Frisch produrranno, come da lui stesso ammesso, quel ressentiment contro l’esercito svizzero che durerà fino all’età adulta.
La «guerra-lampo» della Wehrmacht tedesca contro la Polonia, risoltasi in quattro settimane, unitamente alla cessione della Polonia orientale all’Unione Sovietica, nonché la rapida occupazione della Norvegia e della Danimarca, portano a concludere che ora Hitler si volgerà contro la Francia. Questa, in qualità di potenza protettrice della Polonia, aveva dichiarato guerra alla Germania insieme con la Gran Bretagna, senza tuttavia azzardare una offensiva diversiva sul fronte occidentale lasciato ampiamente sguarnito dalle truppe tedesche. La domanda che assillava noi tutti era: l’attacco tedesco volto ad aggirare, passando per un territorio privo di protezione, la Linea Maginot, saldamente difesa, avverrà attraverso il Belgio e l’Olanda o non invece attraverso la Svizzera? Nel 1939 l’esercito svizzero non è affatto in grado di resistere all’invasione di un’armata tedesca altamente equipaggiata. La maggior parte delle truppe vengono semplicemente disposte ai confini per rendere noto che, come nella Prima guerra mondiale, non si sarebbe accettata una marcia attraverso il Paese.
La Prima guerra mondiale aveva a suo tempo portato a una situazione difficile negli approvvigionamenti. Ora si è meglio preparati: i magazzini dei viveri sono stati riforniti per tempo, e ogni famiglia ha la sua scorta di emergenza (la nostra comprende tra le altre cose un grande sacco di zucchero in soffitta). D’un sol colpo viene richiamata in vita l’organizzazione ombra dell’economia di guerra: un vasto sistema di razionamento che va dal latte e dal caffè fino ai vestiti e alle scarpe, incluso il controllo dei prezzi e la riorganizzazione del settore agricolo e il conseguente aumento della produttività. Anch’io, durante le ferie, devo prestare il mio «servizio agricolo» – fortunatamente, presso contadini miei parenti!
Nel 1940, nel corso della quinta classe, scrivo il mio tema scolastico più lungo, 32 pagine. Il mio maestro è visibilmente irritato dal fatto che continuo a prendere dalla cattedra il blocchetto con i quattro foglietti; ma in nessun caso vuole darmene più di uno alla volta. Il tema che mi affascina ha per titolo: «Come è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale». Nel modo più preciso descrivo qui ciò che è avvenuto in quei giorni drammatici tra Berlino, Parigi, Londra e Roma. Non cito solo i nomi dei capi di governo, ma anche quello dei vari ambasciatori e generali… «Come fa il ragazzo a conoscere tutte queste cose?» chiede il giorno dell’esame la vicina a mia madre, dopo aver gettato un occhio sul mio quaderno dei compiti, tutto ordinato. Mia mamma in seguito me lo racconterà, non senza aggiungere, come poi farà spesso anche altre volte: «Ora però non inorgoglirti!».
In questi tempi difficili le nostre città, prima illuminate a giorno, sono oscurate e ci ricordano ogni sera che anche noi, benché finora non direttamente, siamo tuttavia coinvolti nella guerra.
Adattamento o resistenza?
La problematica di fondo con la quale in seguito avrei dovuto, nel corso della mia vita, così spesso confrontarmi, mi viene posta dalla politica alta per così dire fin dalla culla: adattarsi e stare al gioco – oppure tenere testa e resistere? Negli anni Trenta e Quaranta del XX secolo ne va di un conflitto, sia di politica interna sia di politica estera, tra libertà e schiavitù, un conflitto che, nel nostro Paese, scuote al sommo grado me, come tutti. La libertà non è per me qualche cosa che ho scoperto a posteriori, e a segnare la mia vita non è, come può essere per altri, «ricerca» della libertà, ma piuttosto affermarla e conservarla. E così, in questo senso, è costantemente una rinnovata battaglia per la libertà.
In tutti gli anni del dominio nazionalsocialista in Europa non ho conosciuto un solo svizzero nazista e ho comunque 17 anni quando la guerra finisce. Al contrario: in tutta la mia parentela e nel giro delle mie conoscenze si è decisamente antinazisti.
I miei eroi (e quelli della gran parte del nostro popolo) sono in tempo di guerra le due figure storiche della opposizione democratica al nazismo che per lungo tempo sono state all’ombra della storia. In prima linea Winston Churchill, le cui ferme parole riecheggiano fino da noi: «Non ho altro da offrire se non sangue, fatica, sudore e lacrime».
E poi Charles De Gaulle.
Il simbolo della resistenza per noi in Svizzera è il comandante in capo dell’esercito, l’unico che può fregiarsi del titolo di generale, eletto a schiacciante maggioranza, nel corso di una solenne seduta congiunta del parlamento e della dieta federali, due giorni prima della caduta della Polonia e per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale: Henri Guisan, un benestante sessantacinquenne, piuttosto tranquillo e schivo, proveniente da una famiglia liberale del Vaud, comandante del primo corpo d’armata, capace di riassumere in una sola persona il soldato di milizia e l’uomo di stato.
Grande è la mia felicità quando a Sursee, nel corso di una cerimonia di consegna della bandiera, posso osservare con attenzione, a solo pochi passi di distanza, quest’uomo affabile e nient’affatto autoritario. Una delle sue frasi è: «Quando un uomo sta sull’attenti davanti a me e mi guarda negli occhi, vedo dietro di lui la sua patria, la sua famiglia, le sue preoccupazioni».
In Svizzera ci sentiamo accerchiati e ricattati: un’isola di libertà, certo, ma un popolo privo di carbone, ferro, acciaio e olio combustibile, nonché minacciato il 2 luglio 1940, su ordine del maresciallo del Reich Göring, del blocco delle forniture di carbone.
Ora, è proprio nel momento concitato del massimo pericolo che il generale Henri Guisan dimostra all’interno e all’estero un’incondizionata volontà di resistenza.
Già il 25 luglio 1940 il generale convoca a rapporto sul Rütli tutti gli ufficiali in capo, dal comandante di battaglione in su. Qui, nel celebre promontorio sul lago di Urn, dove secondo la leggenda avrebbe giurato la Lega dei Primi Cantoni svizzeri di Uri, Schwyz e Nidwalden (documentata inequivocabilmente nella lettera federale del 1291 come avvenuta a «inizio agosto»), si raduna ora il vertice dell’esercito: nel segno della tradizionale libertà, indipendenza e democrazia. Senza nominare il nemico, Guisan invoca decisamente resistenza contro ogni attacco che possa provenire dall’esterno, così come contro ogni dubbio, disfattismo e rassegnazione che possa provenire dall’interno del Paese. E in effetti il generale viene subito capito dalla nazione.
Queste esperienze storiche della Svizzera mi segnano in profondità.
Libertà politica – senza capo né sudditi
In modo programmatico e ragionato tutto ciò viene espresso nella Esposizione nazionale svizzera tenutasi presso il lago di Zurigo nel 1939, immediatamente prima dello scoppio della guerra. Per molti dei 10 milioni di visitatori, l’Esposizione è un «evento indelebile» della loro vita.
Per me personalmente lo fu ancora di più, dato che all’approssimarsi di essa mi ero per così dire rovinato la festa. Nelle settimane precedenti si è infatti verificata nella mia scuola di Sursee, per tutta una serie di rivalità, una grande baruffa di classe, così che, negli intervalli, anziché giocare tutti assieme, ci dividiamo in due squadre per giocare a «palla avvelenata». Succede che un giocatore dell’altra squadra abbia l’ardire di lanciare il nostro pallone, il mio pallone (io sono l’unico a possedere un pallone di cuoio), con un alto pallonetto oltre la piazza della scuola, per poi darsi alla fuga impaurito. Dai e dai, lo raggiungo lungo la recinzione di metallo, pieno d’ira, tengo fermo il ribaldo cingendogli un braccio attorno al collo…
Viene detto che ero sul punto di strozzarlo, cosa che nego. In ogni caso, lo scandalo è grande. Ispezione a scuola, visita del maestro a casa dei miei genitori. Anch’essi condannano il mio misfatto e sentenziano, come punizione: «Non andrai all’Esposizione!». Solo pochi giorni prima del viaggio la pena viene commutata nel fatto che non sarei andato con mio papà alla rievocazione della battaglia di Sempach.
Dio sia lodato per questo cambio di pena, perché in effetti, come scrivo nel mio secondo tema più lungo (26 pagine), l’esposizione significa anche per me un evento indimenticabile già alla prima impressione: a cominciare dall’esposizione dei villaggi rurali, passando poi per la funicolare sul lago di Zurigo, al viaggio in battello lungo l’intera mostra, fino a giungere alla visita dell’industria ipermoderna e al sentiero con le migliaia di stemmi delle varie comunità.
Che in Svizzera non si parli di specifici ambiti problematici come la povertà o l’alcolismo in Svizzera è cosa a cui non facciamo granché caso. Sono altri i problemi che emergono in primo piano in questo frangente emotivo: un saldo atteggiamento morale per la difesa spirituale e militare del Paese è, nel 1939, l’esigenza prioritaria. Un simbolo di ciò è una grande statua, più grande del naturale, del libero e indomito Svizzero che con gesto caparbio indossa la giubba militare. E centinaia di migliaia di cittadini elvetici devono fare lo stesso – nel bel mezzo dell’Esposizione nazionale, a causa dello scoppio della Seconda guerra mondiale.
E così ha poi senz’altro uno scopo e un senso politico il fatto che le nostre scuole, nel 1941, un anno dopo il Rapporto del Rütli, organizzino collettivamente un viaggio proprio a Rütli per il 650° anniversario della Confederazione Elvetica. Io ho 13 anni. Anche le scuole di Sursee viaggiano da Lucerna in un grande piroscafo sul lago dei Quattro Cantoni (Uri, Schwyz, Unterwalden e Lucerna) passando per il Prato di Rütli sotto il Monte Seelis. E a me, ora già alla prima classe del ginnasio, viene assegnato il compito di leggere ad alta voce, con partecipazione e al tempo stesso con sobrietà, le parole decisive del giuramento schilleriano: «Vogliamo essere un popolo unito di fratelli, non dividerci in alcuna emergenza e pericolo. Vogliamo essere liberi come lo furono i padri, è meglio la morte che vivere in schiavitù».
È il diritto di resistenza, profondamente radicato nel pensiero del Medioevo, dello svizzero delle origini. Quante volte mi richiamerò in seguito a esso: nessun rispetto per le guardie di Gessler – né mondane né spirituali!
Vivere a partire da una storia di libertà
Ora forse si comprende meglio il mio orgoglio, assolutamente realistico, per una storia di libertà profondamente coinvolgente – pur con tutte le manchevolezze, proprio e anche in questo tempo di nazismo, e pur con tutte le costrizioni e gli scacchi che sempre e di nuovo si verificano. Io non provengo dalla tradizione delle grandi banche svizzere e dei grandi affari, tradizione che all’estero, per via dell’eccessiva accondiscendenza nelle questioni riguardanti valute e forniture militari, ha così fortemente gravato sull’immagine della Svizzera sospingendoci in una penombra morale.
Sì, io provengo da una tradizione di coscienza borghese di libertà e mai la rinnegherò: al nostro «progetto» nazionale e alla mia essenza svizzera appartiene, sì, una avversione quasi istintiva per ogni dittatura nello Stato, nella Chiesa e nella società, per ogni totalitarismo politico e per ogni integralismo ecclesiale. Una opposizione contro l’adorazione anche nei confronti dei leader ecclesiali e contro l’idolatria delle istituzioni, siano esse un partito o una Chiesa. E un impegno, quando necessario, sia contro la destra, sia contro la sinistra, per la democrazia, per il federalismo, per la tolleranza, per la libertà e la dignità di ogni singola persona e delle comunità più piccole. E di conseguenza, un sentimento di responsabilità – con riferimento alla realtà, piedi ben piantati per terra e senso civico.
Ma ora basta con le considerazioni storiche, le mie radici non sono solo nella storia. Ricordi storici e esperienze della natura si sovrappongono per me gli uni con le altre. E le une mi influenzano tanto quanto gli altri e sempre saranno per me una fonte di forza e di gioia, di cui poco sa il puro uomo di città. La natura, nella quale sono cresciuto e di cui vado costantemente alla ricerca, fa parte delle radici della mia esistenza.
Vivere con la natura: lago e montagna
È dunque nella cittadina di Sursee, sul lago di Sempach, che prima della battaglia si chiamava anch’esso Sursee e dal quale il nostro piccolo fiume, la Sura, trae il suo corso nella valle omonima, che sono nato il 19 marzo 1928, sotto il segno dei pesci. Nessuna paura: non credo allo zodiaco di invenzione umana, le cui singole costellazioni stanno spesso a milioni di anni luce di distanza le une dalle altre. Tuttavia, anche in seguito, a Tubinga, raramente andrò a letto senza aver prima osservato il cielo stellato o quantomeno le nuvole.
Un «pesci» lo sono senza dubbio, nella misura in cui volentieri nuoto nella vita, ma in compenso non sono uno scalatore. Certo, da giovane scalo molte montagne nella Svizzera centrale, nei Grigioni e soprattutto attorno a Zermatt: con una lunga marcia di avvicinamento da Randa molte e molte ore a piedi per esempio verso Gornergart, al Lago Nero e alle Capanne Hörnli, ai piedi del Cervino e di nuovo indietro, stanco morto. Ma ecco quel che in seguito mi servirà da giustificazione riguardo a ulteriori avventure montane: sono salito sul monte più alto che si trova in territorio svizzero, recante l’imponente nome di «Dom» («duomo»), direttamente di fronte al Cervino e addirittura più alto di una dozzina di metri, ossia 4545 metri sopra il livello del mare.
Per me, diciassettenne, certo sempre molto alto di statura e a Sursee il più alto della classe, ma sofferente (solo decenni più tardi un medico vi porrà rimedio) di pressione bassa e quindi stanco più rapidamente di altri, ciò ha il significato di una sfida. L’ascesa di molte ore alla vetta del Dom, iniziata presto, attorno alle quattro del mattino a circa 3000 metri, esige le ultime forze residue, specialmente negli ultimi 200 metri quando, a ogni passo, si sprofonda nella neve fresca. Per il terzo della squadra, contando anche il nostro capocordata, il mio futuro vescovo Otto Wüst, è un’avventura quasi fatale; improvvisamente, egli scivola in un crepaccio a un tiro di corda sotto di me, su un precipizio di parecchie centinaia di metri, cercando di fermarsi aggrappandosi con entrambe le mani alla nuda roccia; per fortuna avevamo assicurato la nostra corda. Poi, verso mezzogiorno, eccoci! Finalmente in cima. Una vista incantevolmente bella sugli altri quattromila del Vallese e su una dozzina di punte più basse. Ma i venti soffiano gelidi e riusciamo a ripararci solo più in basso rispetto alla punta, in un lato sottovento. Poi, rapidamente giù, facendo non meno fatica nell’attraversare un ghiacciaio che non finisce mai. Ognuno di noi si alterna come capocordata per scalpellare faticosamente con la piccozza nel ghiaccio uno scalino dopo l’altro. Scivolare sarebbe fatale…
Alla f...