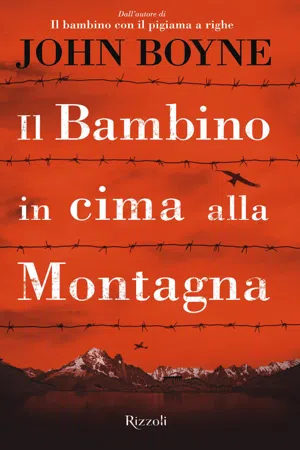![]()
PARTE 1
1936
![]()
CAPITOLO UNO
Tre macchie rosse su un fazzoletto
Sebbene il padre di Pierrot Fischer non fosse morto nella Grande Guerra, sua madre Émilie sosteneva che era stata la guerra a ucciderlo.
Pierrot non era l’unico bambino di sette anni a Parigi a vivere con un solo genitore. A scuola, il bambino seduto davanti a lui non aveva più visto la madre da quando era fuggita, quattro anni prima, con un venditore di enciclopedie, mentre il bullo della classe, quello che chiamava Pierrot “Le Petit” perché era molto piccolo, aveva una stanza sopra la tabaccheria dei nonni su Avenue de la Motte Picquet e trascorreva gran parte del tempo a lanciare palloncini pieni d’acqua dalla finestra del piano di sopra sulla testa dei passanti, per poi insistere che lui non c’entrava niente.
E in un appartamento al pian terreno del suo stesso palazzo, sulla vicina Avenue Charles-Floquet, il migliore amico di Pierrot, Anshel Bronstein, viveva da solo con la madre, Madame Bronstein, dopo che il padre era annegato due anni prima nel fallito tentativo di attraversare il Canale della Manica a nuoto.
Essendo nati a poche settimane di distanza, Pierrot e Anshel erano cresciuti in pratica come fratelli, e quando una delle due madri aveva bisogno di schiacciare un pisolino, l’altra, a turno, si prendeva cura di entrambi i neonati. Ma, al contrario di molti fratelli, loro non avevano mai litigato. Anshel era nato sordo e così i due avevano ben presto escogitato un linguaggio dei segni con il quale comunicavano facilmente, esprimendo attraverso le agili dita tutto quello che dovevano dirsi. Avevano anche creato simboli speciali l’uno per l’altro, da usare al posto dei nomi. Anshel aveva assegnato a Pierrot il segno del cane, poiché pensava che il suo amico fosse una persona gentile e leale, mentre Pierrot aveva adottato per Anshel il segno della volpe, perché tutti dicevano che era il più sveglio della classe. Quando usavano quei nomi, le loro mani si muovevano in questo modo:
Trascorrevano insieme gran parte del tempo, tirando calci a un pallone dalle parti di Champ de Mars o leggendo gli stessi libri. La loro amicizia era così profonda che Pierrot era la sola persona a cui Anshel concedeva di leggere le storie che scriveva di notte nella sua stanza. Neanche Madame Bronstein sapeva che suo figlio voleva diventare uno scrittore.
Questa è venuta bene, diceva a gesti Pierrot, le dita che svolazzavano nell’aria mentre restituiva un plico di pagine. Mi è piaciuto il pezzo sul cavallo e la parte dove si scopre che l’oro è nascosto nella bara. Questa non è un granché, continuava, porgendogli un secondo fascio di pagine. Ma solo perché hai una calligrafia terribile e non sono riuscito a leggerne alcune parti… E questa, aggiungeva, agitando in aria una terza pila di fogli come se si trovasse a una parata, questa non ha alcun senso. Io la getterei nel cestino, se fossi in te.
È sperimentale, gesticolava Anshel, che non aveva niente contro le critiche ma quando si trattava delle sue storie, a volte si metteva un po’ sulla difensiva.
No, rispondeva a gesti Pierrot, scuotendo la testa. Non ha proprio senso. Questa faresti meglio a non farla mai leggere a nessuno. O penseranno che ti manca qualche rotella.
Anche a Pierrot piaceva l’idea di scrivere storie, ma non riusciva mai a starsene seduto tranquillo per il tempo necessario a mettere le parole su una pagina. Così, si sedeva di fronte al suo amico e incominciava a gesticolare, descrivendo qualche bravata combinata a scuola o inventandosela di sana pianta. Anshel, intanto, lo osservava con attenzione e poi trascriveva tutto al posto suo.
L’ho scritta io questa?, chiedeva Pierrot, quando riceveva le pagine e le leggeva da cima a fondo.
No, l’ho scritta io, rispondeva Anshel, scuotendo la testa. Ma è la tua storia.
Émilie, la madre di Pierrot, ormai gli parlava solo raramente di suo padre, anche se il bambino pensava sempre a lui. Wilhelm Fischer aveva vissuto con la moglie e il figlio fino a tre anni prima, ma aveva lasciato Parigi nell’estate del 1933, pochi mesi dopo il quarto compleanno di suo figlio. Pierrot ricordava suo padre come un uomo alto che imitava il verso del cavallo quando lo portava in giro per strada sulle sue spalle larghe, lanciandosi ogni tanto al galoppo e facendolo sempre urlare di gioia. Gli aveva insegnato il tedesco per ricordargli le sue origini e cercava in tutti i modi di fargli imparare qualche semplice canzone al piano, anche se Pierrot sapeva che non sarebbe mai stato bravo quanto lui. Suo padre suonava canzoni popolari che suscitavano le lacrime negli occhi degli ospiti, soprattutto quando le accompagnava con quella voce tenera ma potente che parlava di ricordi e di rimpianti. Se le sue doti musicali non erano un granché, Pierrot si rifaceva con l’abilità nelle lingue straniere; riusciva in un attimo e senza alcuna difficoltà a passare dal tedesco che parlava con il padre al francese, con la madre. La sua specialità alle feste era cantare La Marseillaise in tedesco e Das Deutschlandlied in francese, un’abilità che talvolta metteva a disagio gli ospiti a cena.
«Non voglio che tu lo rifaccia, Pierrot» gli disse maman una sera, dopo che la sua esibizione aveva creato un leggero disaccordo con alcuni vicini. «Impara qualcos’altro, se proprio vuoi metterti in mostra. Acrobazie. Giochi di prestigio. A stare in equilibrio sulla testa. Qualunque cosa che non sia cantare in tedesco.»
«Cos’ha il tedesco che non va?» chiese Pierrot.
«Già, Émilie» disse papà dalla poltrona nell’angolo, dove aveva trascorso la serata bevendo troppo vino e finendo come sempre a rimuginare sulle brutte esperienze che lo tormentavano. «Cos’ha il tedesco che non va?»
«Non ti è bastato, Wilhelm?» chiese lei, le mani ben piantate sui fianchi mentre si voltava a guardarlo.
«Bastato cosa? I tuoi amici che insultano il mio Paese?»
«Non insultavano il tuo Paese» disse lei. «È che fanno fatica a dimenticare la guerra. Specialmente quelli che hanno perso i loro cari nelle trincee.»
«Però, venire a casa mia, mangiare il mio cibo e bere il mio vino, quello non gli costa fatica.»
Papà aspettò che maman fosse tornata in cucina prima di chiamare a sé Pierrot e cingerlo con un braccio intorno alla vita. «Un giorno ci riprenderemo quello che è nostro» disse, guardando il bambino dritto negli occhi. «E quando lo faremo, ricordati da che parte stai. Sarai pure nato in Francia e potrai anche vivere a Parigi, ma tu sei tedesco fino al midollo, proprio come me. Non dimenticarlo, Pierrot.»
Qualche volta papà si svegliava nel cuore della notte, le sue urla che echeggiavano nei corridoi bui e vuoti del loro appartamento. Il cane di Pierrot, D’Artagnan, balzava dalla cesta in preda al terrore, saltava sul letto e cercava di rintanarsi sotto le lenzuola accanto al suo padrone, tutto tremante. Il bambino si tirava la coperta fino al mento e, attraverso le pareti sottili, sentiva maman che cercava di calmare suo padre, sussurrandogli che andava tutto bene, che era a casa con la sua famiglia, che non era stato altro che un brutto sogno.
«Non era un sogno» sentì dire una volta a suo padre, con la voce che gli tremava per l’angoscia. «Era peggio di un sogno. Era un ricordo.»
A volte Pierrot si svegliava per il bisogno di una puntata veloce in bagno e trovava suo padre seduto al tavolo della cucina, la testa riversa sul piano di legno, che mugugnava tra sé e sé con accanto una bottiglia vuota rovesciata. In quei casi, il bambino scendeva di corsa a piedi nudi e gettava la bottiglia nel bidone in cortile così che sua madre non la trovasse il mattino dopo. E in genere, quando tornava di sopra, suo padre si era alzato e in qualche modo aveva ritrovato la via del letto.
Nessuno dei due parlava mai di queste cose il giorno dopo.
Una volta, però, mentre usciva per una di queste missioni a notte fonda, Pierrot scivolò sulle scale bagnate e ruzzolò a terra, non tanto da farsi male, ma abbastanza da mandare in frantumi la bottiglia che teneva in mano e, quando si rialzò, un pezzo di vetro gli si conficcò nella pianta del piede sinistro. Con una smorfia, lo tirò fuori, ma dalla pelle lacerata iniziò subito a uscire, copioso, il sangue. Quando tornò zoppicando in casa in cerca di una benda, papà si svegliò e vide che cosa era successo per colpa sua. Dopo aver disinfettato la ferita ed essersi assicurato che la fasciatura fosse ben stretta, fece sedere Pierrot e si scusò per le sue bevute. Asciugandosi le lacrime, gli disse quanto lo amava e gli promise che mai più avrebbe fatto qualcosa che potesse fargli del male.
«Anch’io ti voglio bene, papà» disse Pierrot. «Ma ti voglio più bene quando mi porti sulle spalle e fai finta di essere un cavallo. Non mi piace quando ti siedi in poltrona e non parli con me e con la mamma.»
«Non piacciono neanche a me quei momenti» disse papà a bassa voce. «Ma qualche volta è come se su di me ci fosse una grossa nuvola nera che non riesco a scacciare. È per questo che bevo. Mi aiuta a dimenticare.»
«Dimenticare cosa?»
«La guerra. Le cose che ho visto.» Chiuse gli occhi e in un sussurro aggiunse: «Le cose che ho fatto».
Pierrot deglutì, quasi avesse paura a chiedere. «Che cosa hai fatto?»
Suo padre gli rivolse un sorriso triste. «Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per la mia nazione» disse. «Lo capisci questo, vero?»
«Sì, papà» rispose Pierrot, che non era sicuro di aver capito il senso di quelle parole ma le trovava comunque valorose. «Anch’io farò il soldato, se questo ti renderà orgoglioso di me.»
L’uomo guardò suo figlio e gli mise una mano sulla spalla. «Purché tu scelga la parte giusta» disse.
In seguito, smise di bere per diverse settimane. E poi, bruscamente come aveva smesso, la nuvola nera di cui aveva parlato tornò, e lui ricominciò.
Papà lavorava come cameriere in un ristorante della zona. Usciva di casa ogni mattina intorno alle dieci e tornava alle tre, per poi andarsene di nuovo alle sei per il servizio serale. Una volta tornò a casa di pessimo umore e disse che un tizio che si chiamava papa Joffre era stato al ristorante per pranzo e si era seduto a uno dei suoi tavoli: lui si era rifiutato di servirlo, finché il suo datore di lavoro, Monsieur Abrahams, gli aveva detto che se non l’avesse fatto, avrebbe potuto andarsene a casa e non tornare mai più.
«Chi è papà Joffre?» chiese Pierrot, che non aveva mai sentito quel nome prima.
«È stato un grande generale durante la guerra» disse maman, sollevando dalla cesta una pila di vestiti e posandoli accanto all’asse da stiro. «Un eroe per il nostro popolo.»
«Per il tuo popolo» disse papà.
«Ricordati che hai sposato una francese» disse maman, rivolgendosi a lui in tono arrabbiato.
«Perché la amavo» rispose papà. «Pierrot, ti ho mai raccontato di quando vidi tua madre per la prima volta? Fu un paio d’anni dopo la fine della Grande Guerra: avevo un appuntamento per incontrare mia sorella Beatrix durante la pausa pranzo e quando arrivai ai grandi magazzini dove lavorava, la trovai che parlava con una nuova commessa, una creatura timida che aveva iniziato proprio quella settimana. Al primo sguardo capii immediatamente che quella era la ragazza che avrei sposato.»
Pierrot sorrise; adorava sentire suo padre raccontargli storie come quella.
«Aprii la bocca per parlare, ma non riuscii a trovare le parole. Era come se il mio cervello si fosse messo a dormire. E così, rimasi lì imbambolato, con lo sguardo fisso, senza dire niente.»
«Io pensai che avesse qualche problema» disse maman, sorridendo anche lei al ricordo.
«Beatrix dovette scuotermi per le spalle» continuò papà, ridendo della sua stessa goffaggine.
«Se non fosse stato per lei, non avrei mai accettato di uscire con te» aggiunse maman. «Mi disse che avrei dovuto darti una possibilità. Che non eri così ottuso come sembravi.»
«Perché non vediamo mai zia Beatrix?» chiese Pierrot, che aveva sentito fare il suo nome in qualche occasione nel corso degli anni, ma non l’aveva mai conosciuta. Non era mai venuta a trovarli e non scriveva lettere.
«Perché è così» disse papà, il sorriso che gli abbandonava il viso mentre mutava espressione.
«Ma perché è così?»
«Lascia perdere, Pierrot» disse lui.
«Sì, lascia perdere, Pierrot» ripeté maman, anche lei rabbuiandosi in viso. «Perché è così che si fa in questa casa. Allontaniamo le persone che amiamo, non parliamo delle cose che contano e non permettiamo a nessuno di aiutarci.»
E così, in un attimo, una lieta conversazione andò in frantumi.
«Mangia come un maiale» disse papà qualche minuto dopo, accovacciandosi per guardare Pierrot negli occhi e contraendo le dita come fossero mandibole. «Papa Joffre, intendo. Come un topo che si fa strada sgranocchiando un’intera pannocchia.»
Una settimana dopo l’altra, papà si lamentava di quanto fosse bassa la sua paga, di come Monsieur e Madame Abrahams lo trattassero con sufficienza, dei parigini che erano diventati sempre più tirchi con le mance. «Ecco perché non abbiamo mai soldi» brontolava. «Sono tutti spilorci. Soprattutto gli ebrei, loro sono i peggiori. E ne vengono di continuo, perché dicono che Madame Abrahams fa il miglior gefilte fish e le migliori latkes di tutta l’Europa occidentale.»
«Anshel è ebreo» disse Pierrot sottovoce, perché vedeva spesso il suo amico uscire con la madre per recarsi al tempio.
«Anshel è uno di quelli buoni» mormorò papà. «Si dice che ogni cassa di mele buone ne contenga una ma...