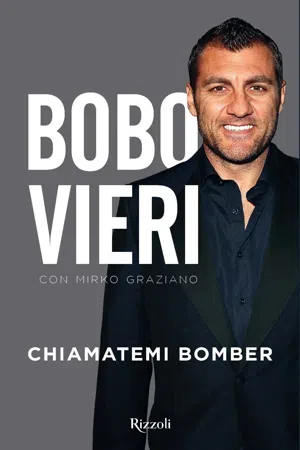![]()
Prima parte
DALL’AUSTRALIA
A SAN SIRO
![]()
Australia
“Sai che ti dico, Christian? Hai ragione!”
Complimenti, mister. Da solo ci saresti mai arrivato? Evidentemente no.
Ha avuto bisogno dell’aiutino, il mister.
E l’aiutino gliel’ho dovuto dare io, un ragazzino di quattordici anni che da terzino sinistro segna più gol degli attaccanti.
“Mister, non è che stare in difesa non mi piaccia, ma forse è meglio se mi metti a giocare davanti.”
Gli ho detto più o meno così.
Solo che gliel’ho detto in inglese perché siamo a Sidney, nel campetto d’allenamento dei giovani del Marconi Football Club, la società in cui, anni prima, giocava mio padre.
“Sai che ti dico, Christian? Hai ragione!”
La mia storia di attaccante è cominciata così.
Alla fine della prima stagione da calciatore di gol ne ho fatti diciotto. Non male, per un raccomandato che con i piedi non ci sa proprio fare. La questione del “raccomandato” è una gran rottura di palle. A Sidney mio padre è stato una celebrità calcistica, io ho appena iniziato, non sono un fenomeno e le malignità si sprecano.
Intendiamoci, non sono un fenomeno col pallone tra i piedi, però corro e ho più fiato degli altri grazie agli allenamenti di atletica che faccio a scuola. A correre sì che sono quasi imbattibile. Le gare dei 100, 200, 400 e 800 metri le vinco sempre io (quando arrivo secondo è perché vince un ragazzo di colore, siamo noi due i migliori). E poi salto in alto e salto in lungo. Diciamo che i diciotto gol mi servono almeno a far star zitti quelli che in me vedono soltanto il “figlio di”.
Che cosa ci faccio a Sidney? Vivo qui da sempre, o quasi. I miei genitori mi ci hanno portato quando avevo quattro anni. Mio padre Roberto era calciatore professionista e nel 1977, quando ancora si usava poco, ha deciso di andare a giocare all’estero. Non in Francia, Spagna o Germania, ma in Australia, nel Marconi Football Club, appunto. E io, naturalmente, me la tiro un po’ ad avere un papà calciatore mentre quelli dei miei amici sono assicuratori o muratori.
Del periodo a Bologna, città dove mio padre ha giocato le ultime stagioni in Serie A, non saprei dire nulla. I miei ricordi hanno inizio dal quartiere in cui abitiamo, a mezz’ora dal centro di Sidney, e sono tutti in lingua inglese. Penso di non aver mai parlato soltanto italiano, per me è sempre stato italiano e inglese.
Qui i miei due amici italiani sono Filomena e Attilio, siamo cresciuti insieme, sono i figli del presidente del Marconi, Toni, e di sua moglie Maria. E poi ci sono l’egiziano, il greco, lo slavo, il peruviano e qualche altro che non ricordo. Oggi non posso che benedire quel periodo della vita perché mi ha aperto a ogni cultura e mi ha tenuto lontano da qualsiasi stronzata razzista. I razzisti sono razzisti perché non sono mai usciti di casa, dal paesello, dalla città che li ha visti nascere e che li vedrà morire. È brutto morire ignoranti, ma capisco anche che non tutti hanno la fortuna di prendere e andarsene in giro per il mondo.
Davanti a casa mia per strada non c’è mai nessuno, le macchine sono rarissime e abbiamo tutto lo spazio che vogliamo per giocare a cricket e a calcio. Inevitabilmente, quasi ogni giorno, centriamo le finestre di casa e spacchiamo vetri su vetri. Sì, ok, diciamo che il più delle volte sono io il colpevole. Non vi dico le scenate dei miei, costretti a farli riparare. Dopo l’ennesimo vetro frantumato, prendo io l’iniziativa e vado direttamente dal vetraio che abita a cento metri da noi.
“La prego, mi ascolti, è urgente! Deve venire a cambiarmi il vetro prima che torni mia mamma!” gli dico quasi in lacrime.
E lui, cuore di pietra: “Adesso non posso, ho un lavoro da finire”.
Non mi sembra una buona ragione. Comincio a stargli con il fiato sul collo in modo insistente, come solo i bambini sanno fare, e alla fine lo convinco a seguirmi a casa.
Dopo la terza volta non devo nemmeno più dirgli niente: mi limito a fare capolino nel negozio. Il vetraio mi vede, sorride e dice: “Ho capito, ho capito. Qual è stavolta?”.
“Quello sul retro.”
“Arrivo tra cinque minuti.”
Mia mamma, però, si accorgeva regolarmente della sostituzione e si incazzava come una biscia. Mai capito come facesse, forse i vetri nuovi erano più puliti degli altri, chissà.
Il calcio non è ancora in cima ai miei pensieri, fino ai quattordici anni mi dedico all’atletica, per il resto vado con gli amici al centro commerciale... a rubare biciclette! Sbloccare i lucchetti è un gioco da ragazzi, i controlli poi non sono così rigorosi. Il lavoro sporco è tutto mio, gli altri fanno il palo. Dopodiché il bottino finisce nella mia cantina, che è diventata il deposito della refurtiva. Lì cancelliamo i codici dai telai e smontiamo le bici in tanti pezzi da rivendere singolarmente. Tiriamo su dei bei soldi!
Povera mamma, un giorno scende in cantina e si trova davanti una trentina di bici parcheggiate. Preferisce non farsi domande, apre e chiude immediatamente.
Non la prende altrettanto bene quando la combino grossa e mando a fuoco la cucina. Voglio farmi i pop corn, peccato che in casa non ci sia il mais. Tiro fuori la padella, verso l’olio, accendo la fiamma al minimo e… esco a comprare il mais! Sulla strada del ritorno, a cento metri da casa mia, vedo un sacco di fumo provenire proprio da lì. Inizio a realizzare il guaio e comincio a correre più veloce che posso. Entro, getto acqua sulla padella in fiamme, spalanco porte e finestre per respirare ma non si vede niente. Sono costretto a restare in giardino per un’oretta, prima di poter rientrare a controllare com’è conciata la cucina. Quando finalmente rimetto piede dentro scopro che ormai è tutto da buttare, pareti e mobili. Un vero macello.
Stavolta papà Bob si toglie la cintura dei pantaloni per darmele meglio. Si impegna davvero, ma non mi fa tutto il male che vorrebbe perché io, mentre ero lì ad aspettarli, non sono mica rimasto con le mani in mano.
Non sono il tipo che va al patibolo con rassegnazione. Mi ero imbottito di gommapiuma le zone sensibili e quindi ora mi limitavo a fare un po’ di scena e a cacciare fuori qualche urlo ogni tanto per rendere tutto più realistico, qualche “Ahia”, qualche “Basta!”, qualche “Non lo faccio più”.
Uso la stessa tecnica di difesa quando i miei scoprono che a scuola nessuno sa dove sono finito, e che la cosa va avanti da tre mesi.
Ho cominciato a saltare le lezioni quasi per caso e poi ci ho preso gusto. Tre mesi di pace e tranquillità. Mio fratello Max mi scopre e lo minaccio: “Se lo dici alla mamma ti gonfio di botte”.
Ma non mi fido di lui e quindi lo obbligo a fare forca con me. Coinvolgendolo nel crimine, ho un complice ricattabile e, per questo motivo, dalla mia parte al cento per cento. Cominciano le telefonate dalla scuola. La prima volta rispondo io. Poi ne seguono altre e, ovviamente, continuo a rispondere io. Faccio la vittima, racconto che non abbiamo soldi, che i miei lavorano quindici ore al giorno, e per giunta non parlano l’inglese, ecco perché non li trovano mai al telefono.
Altre volte mi fingo malato, varicella o giù di lì. Ma a un certo punto la mia scuola e quella di mio fratello si confrontano e la dirigente di quella di Max smaschera le mie balle: “Non parlano inglese? Ma per favore, lo parlano eccome!”.
Telefonano a mia madre direttamente al lavoro, un bar che i miei hanno appena aperto. Lei chiama a casa e mi dice solo: “Sono qui che sto trattenendo tuo padre. Ma sappi che appena arriva a casa ti ammazza di botte”.
Cosa faccio nell’attesa? Risposta esatta: la gommapiuma. E anche stavolta le legnate mi fanno solo il solletico. Che è un po’ il senso ultimo di tutta la mia vita. Le legnate mi fanno il solletico. Il discorso è che anche il solletico, dopo un po’, diventa fastidioso.
Nel frattempo la mia passione per il calcio cresce sempre più e dopo l’annata dei diciotto gol vengo chiamato dall’Under 15 del Marconi per le semifinali cittadine. Sono il più piccolo, hanno tutti un anno più di me. In squadra c’è anche Paul Okon, che ritroverò nella Lazio anni dopo, suo padre è il nostro allenatore. In semifinale segno subito e vinciamo. In finale stessa cosa: ricevo un pallone sul sinistro a gara appena iniziata, vedo che la porta è lontanissima ma ci provo lo stesso. Faccio partire un missile ed è gol! Campione cittadino.
Alla fine della stagione io e Paul partiamo per l’Italia, ci hanno organizzato dei provini. Ci stabiliamo a Prato da zia Bianca (sorella di papà), zio Egidio e da mio cugino Dimitri. Nella stessa casa vive anche il nonno e ci arrangiamo nella sua stanza. Io e Paul dormiamo in un letto a castello, io sopra e lui sotto.
Lasciare la famiglia e gli amici a quattordici anni non è cosa da poco. Anche se alla fine sono a casa di parenti, mi mancano tremendamente i miei genitori. Quanta nostalgia! Quanti pianti! Ogni giorno scrivo alla mamma oppure registro delle cassette e gliele mando per posta. So che le ascolta mentre stira e scommetto che anche a lei scappa qualche lacrima.
Per tutti, Paul e io siamo “i due australiani”: il nonno ha convinto quelli del Prato a farci allenare con loro. Per i primi tempi speriamo nel tesseramento, ma il Prato fa soltanto promesse e non le mantiene, perciò Paul decide di cambiare strategia e va in Belgio. Io invece resto con il nonno in attesa di qualche proposta.
Un giorno, però, arriva il presidente di un’altra squadra, il Santa Lucia. Si chiama Rodolfo Becheri ed è il suocero dell’allenatore (tra l’altro è pure il nonno di un bambinetto che si chiama Alino Diamanti, sì, proprio quell’Alino Diamanti). “Perché tuo nipote non lo porti da noi? Parlo io a mio genero. Almeno da noi gioca. Qui fa la muffa…” dice al nonno.
Parole sante, grazie signor Becheri.
Con il Santa Lucia esordisco nel Campionato Regionale Allievi e il nonno inventa una tecnica che adesso chiamerebbero “di incentivo”: “Ti do cinquemila lire per ogni gol che fai”.
Alla prima partita ne metto dentro quattro. Ventimila, nonno, thank you very much.
Lui impazzisce per me, non fa che ripetere a mia zia: “Christian ha i numeri, diventerà uno dei più forti attaccanti d’Italia!”.
Seconda partita, altri tre gol.
“Questo mi frega la pensione” comincia a pensare il nonno. “Ti voglio tanto bene” mi dice, “ma d’ora in poi sono mille lire a gol.”
Da cinquemila a mille significa un ribasso dell’ottanta per cento, avrei dovuto contrattare e chiudere a duemila, duemila e cinque, ma è pur sempre mio nonno e tutto sommato dei soldi non me ne frega niente.
Ormai avevo preso gusto a segnare e a trasformare le legnate dei difensori in solletico. Il fisico di allora non era quello che avrei avuto in seguito: all’epoca ero magrolino però compensavo con l’altezza. In certi casi è stata proprio l’altezza a fare la differenza con gli avversari.
I gol mi fanno piacere, l’entusiasmo del nonno anche, ma continuo a pensare all’Australia e alla mia famiglia. Piango sempre. Piango così tanto che mio padre prende un volo in fretta e furia e mi raggiunge a Prato. Vede che soffro molto e mi dice: “Se proprio non ce la fai, torna pure giù”. Ma il nonno è determinato a convincermi a non ripartire: “Christian deve restare in Italia. È fortissimo. Qua può sfondare. L’Italia è l’Italia. In Australia non farà mai strada, chi lo calcola il calcio australiano?”.
Il babbo, però, ha il cuore più tenero e dopo una settimana sono sull’aereo che mi riporta down under.
Cara vecchia Sidney! Cari mamma e papà! Che sollievo, quei primi giorni. Una gioia che, però, non riesco a godermi del tutto. Le parole del nonno continuano a risuonarmi nella testa: “Diventerà uno dei più forti attaccanti d’Italia”. A quindici anni appena compiuti non aspiravo certo a diventare chissà chi, ma sapevo che il nonno era uno che di calcio ne capiva, e anche tanto (è stato anche lui calciatore professionista, portiere), e se diceva così non era soltanto perché ero suo nipote. Su certe cose era serio, non parlava a vanvera.
Resto chiuso in camera per giorni e giorni. Ripenso continuamente a quello che mi è successo, cerco di convincermi di aver fatto la scelta giusta. Non ne potevo più di stare lontano da casa.
Il nonno e gli zii sono stati bravissimi con me, così come Mauro, un cugino di papà, ma i miei genitori sono un’altra cosa. E poi gli amici, tutto il mio mondo... Prato non era casa mia. Io sono un australiano...